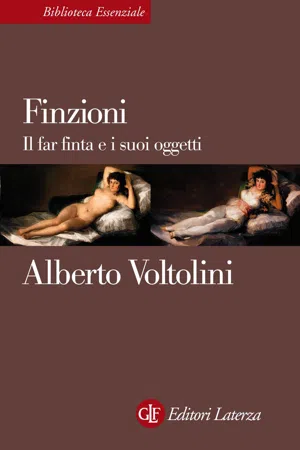
- 196 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Cosa significa far finta? Esistono davvero Anna Karenina e Gatto Silvestro? Una guida alla finzione, come concetto e come pratica. Un'indagine sul far finta e i suoi oggetti e su chi fa finta per piacere o per mestiere.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Finzioni di Alberto Voltolini in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Language in Philosophy. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
PhilosophyCategoria
Language in PhilosophyCapitolo primo.
La metafisica della finzione (1).
Che cos’è un atto di finzione
1. La teoria illocutoria della finzione
Immaginate che un giorno qualcuno apra a caso un libro in cui trovi scritto:
Per molto tempo, mi sono coricato presto la sera. A volte, non appena spenta la candela, mi si chiudevan gli occhi così subito che neppure potevo dire a me stesso: «M’addormento». E una mezz’ora dopo, il pensiero che dovevo ormai cercar sonno mi ridestava; volevo posare il libro, sembrandomi averlo ancora fra le mani, e soffiare sul lume; dormendo avevo seguitato le mie riflessioni su quel che avevo appena letto, ma queste riflessioni avevan preso una forma un po’ speciale; mi sembrava d’essere io stesso l’argomento del libro: una chiesa, un quartetto, la rivalità tra Francesco I e Carlo V.
Come il lettore avvertito avrà già capito, si tratta del celeberrimo incipit del primo volume di Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, La strada di Swann (nell’altrettanto nota traduzione di Natalia Ginzburg, Einaudi, Torino 1946, p. 5). Ma, per l’appunto, questo lo capirà il lettore avvertito, il lettore che sa già un sacco di cose: che il testo è un testo di Proust, che Proust è uno dei più grandi romanzieri del Novecento, e così via. Il nostro lettore inesperto che si rigira tra le mani quel libro, invece, se è almeno un parlante competente della lingua italiana, saprà al più dire non solo che gli enunciati del testo sono ben formati dal punto di vista grammaticale, ma anche che si tratta di una narrazione in prima persona, il cui autore parla di cose che gli sono capitate. Ma non saprà certo dire se si tratta di un’autobiografia storica, in cui un concreto individuo reale parla della propria vita, o di un’autobiografia romanzata, in cui il protagonista racconta pezzi della sua vita immaginaria.
Detta in modo più generale: da un frammento di linguaggio che si comprende in quanto parlanti di quel linguaggio non si può capire se quel frammento costituisca o meno un testo di finzione. Messa giù un po’ più pomposamente: la finzione certo non è una faccenda di sintassi, del modo in cui le espressioni di una lingua si combinano per formare espressioni più complesse, ben strutturate dal punto di vista grammaticale – non ci sono indicatori sintattici di finzione, elementi grammaticali di una lingua che permettono di individuare che un testo è un testo di finzione. (A qualcuno verrebbe forse da dire: mah, se un testo comincia con «C’era una volta» e poi continua con una narrazione all’imperfetto, allora è un testo di finzione1. Ma certo non tutti i testi di finzione cominciano con «C’era una volta», e anche un testo che comincia così potrebbe in realtà narrare eventi storici. Quanto all’imperfetto, beh, si veda un qualsiasi verbale dei carabinieri.) Ma, il che è più interessante, la finzione non è neppure una faccenda di semantica, di ciò che le espressioni di una lingua significano – dal significato linguistico delle espressioni in gioco, quello che conosciamo come parlanti competenti di una lingua e che si trova riassunto da una definizione da dizionario, non capiamo se il testo conti come un testo di finzione o meno2.
Allo stesso risultato arriviamo considerando anche altre forme espressive oltre a quelle (meramente) letterarie. Siamo a teatro in attesa dell’inizio della pièce e a un certo punto il nostro vicino di sedia si mette a sbraitare, richiamando su di sé l’attenzione. Che scostumato, pensiamo: la pièce sta per iniziare, e questo signore dà in escandescenze. Poi, a poco a poco, capiamo: non è un signore qualsiasi, è un attore! La pièce ha avuto inizio in questo modo, con un attore in mezzo al pubblico, e noi non ce n’eravamo neanche accorti. Ma da che cosa abbiamo capito che la finzione era cominciata? Certo non da ciò che l’attore stava dicendo, che nuovamente comprendevamo meramente in quanto parlanti competenti dell’italiano. E se ci spostiamo dal teatro e andiamo al museo, ecco che ci troviamo nuovamente in una situazione analoga: se non andiamo a sbirciare di soppiatto il titolo di un quadro, abbiamo una certa comprensione di ciò che il quadro raffigura – è un quadro che raffigura un individuo importante, diciamo un generale – ma non capiamo se abbiamo a che fare col ritratto di una persona storica – il quadro di Jacques-Louis David, Il Primo Console supera le Alpi al Gran San Bernardo, con Napoleone a cavallo, poniamo – o se il quadro ci presenta semplicemente un individuo immaginario, un generale di finzione. E così via.
Per il momento, però, concentriamoci sugli aspetti linguistici della faccenda – una parte consistente delle nostre finzioni è costituita per l’appunto da finzioni letterarie. Se la finzione che ha luogo con testi linguistici non è una faccenda di sintassi e neppure di semantica, dal punto di vista dei livelli di analisi del linguaggio sembra non restare che un’opzione da considerare, e cioè che sia una faccenda relativa al modo in cui parlanti di un linguaggio usano in un determinato contesto le espressioni di quel linguaggio per compiere delle significazioni particolari; in altri termini, che sia una faccenda di pragmatica. Qui per «pragmatica» intendo quello che Cresswell (1973) chiama «pragmatica pragmatica», o pragmatica propriamente detta, ossia quel livello di analisi del linguaggio che riguarda l’uso delle espressioni in una situazione concreta di discorso per significare qualcosa di più e di diverso rispetto a quello che tali espressioni significano. La situazione concreta di discorso prende il nome di contesto in senso ampio, per indicare che si considerano parte del contesto tutti i fattori che in una concreta situazione di discorso determinano ciò che viene significato usando le rilevanti espressioni. Il contesto ampio viene invocato qui in un ruolo post-semantico, un ruolo che serve cioè a determinare i fattori che permettono all’uso delle espressioni linguistiche di significare qualcosa che va oltre il significato di quelle stesse espressioni (cfr. Perry 1997). Nella corrente maggioritaria della filosofia analitica del linguaggio, è tradizione dominante pensare che il significato delle espressioni subenunciative coincida con la determinazione delle condizioni di verità degli enunciati di cui tali espressioni fanno parte; vale a dire, che tale significato coincida con le condizioni di applicazione di tali espressioni (nei casi più semplici, il loro riferimento), di modo che il significato di un enunciato coincida per l’appunto con le sue condizioni di verità, le condizioni che debbono essere soddisfatte perché un enunciato sia vero. La pragmatica pragmatica investigherà dunque i fattori ultraverocondizionali della significazione, i fattori che, grazie all’uso in un contesto ampio delle espressioni di un enunciato, vanno oltre la determinazione delle condizioni di verità di un enunciato siffatto.
Ecco un esempio calzante di tale situazione. A chi mi chiede dove andrò in vacanza quest’anno rispondo: resterò a Torino. Infatti, continuo:
(1) Torino è una città di mare.
Il mio enunciato ha un significato perfettamente chiaro, catturato dalle sue condizioni di verità: come si suol dire, (1) è vero se e soltanto se, ossia solo alla condizione che, Torino sia una città di mare. Ma è evidente che non ho usato (1) per dire quello che chiunque abbia un minimo di competenza geografica sull’Italia sa bene essere una falsità, dato che Torino ha tanti pregi, ma non quello di essere sul mare. Ho usato piuttosto (1) per comunicare qualcosa che va oltre le condizioni di verità di tale enunciato, ossia per fare una facile ironia su Torino comunicando che Torino non è una città di mare.
Se si va nella direzione della pragmatica così trattata, la prima mossa teorica da valutare è che il prendere un testo come un testo di finzione corrisponda a un particolare atto illocutorio, l’atto che, seguendo Currie (1990), chiamerò l’atto di narrare una storia.
Com’è noto, la nozione di atto illocutorio è stata teorizzata da Austin (1961a) per rendere compiutamente conto del fenomeno della performatività del linguaggio. Con «performatività del linguaggio» Austin intese prima di tutto il fatto che il linguaggio spesso è utilizzato non tanto per descrivere (correttamente o scorrettamente) il mondo, quanto per fare delle cose, nel senso che (nelle condizioni appropriate) proferire un enunciato conta come la realizzazione di un vero e proprio atto linguistico, un’azione che si compie per il fatto stesso di proferire quell’enunciato. Se mentre sto insegnando con una certa sbruffoneria dico:
(2) La lezione è interessante
il fatto di proferire (2) non rende ovviamente la lezione interessante – ciò che dico è vero o falso a seconda che la lezione che sto tenendo sia effettivamente interessante o meno. Ma se, sempre a lezione, dico:
(3) La lezione è conclusa
la mia lezione finisce per il fatto stesso che io proferisco (3). In quanto docente incaricato di tenere presso l’Università di Torino un corso di filosofia del linguaggio, proferire (3) conta effettivamente come la conclusione della lezione (a differenza di quel che sarebbe successo se (3) fosse stato proferito da uno studente o, peggio ancora, da uno che passava di là). A differenza di (2), un enunciato puramente constativo, (3) ha dunque un valore performativo.
Ripensandoci su, però, Austin capì che la vera differenza tra il proferire (2) e il proferire (3) non è che il secondo enunciato ma non il primo ha un valore performativo, perché anche proferire il primo ce l’ha. È vero che proferire (2) non rende interessante la mia lezione, ma comunque qualcosa tendenzialmente quel proferimento lo compie lo stesso: nelle condizioni appropriate, proferire (2) conta come asserire qualcosa. La vera differenza tra il proferire (2) e il proferire (3) consiste dunque non nel fatto che il secondo enunciato ma non il primo realizza se proferito un atto linguistico, bensì nel tipo di atto linguistico che (nelle condizioni appropriate) i proferimenti di quegli enunciati rispettivamente realizzano: se il primo proferimento conta come un’asserzione, l’asserzione che la lezione è interessante, il secondo proferimento conta come una dichiarazione, la dichiarazione che la lezione è conclusa. Dunque, concludeva Austin, se dato nelle condizioni appropriate, ogni proferimento – o almeno, ogni proferimento in cui si dica qualcosa di sensato, in cui cioè si sia preventivamente compiuto quello che Austin chiamava un atto locutorio – realizza un atto di tipo illocutorio, un atto che si realizza nel proferire un enunciato: nel nostro esempio, rispettivamente, un’asserzione e una dichiarazione. (Intuitivamente, è chiaro perché un atto illocutorio presuppone un atto locutorio. Provate se siete capaci a realizzare qualcosa nel linguaggio nel proferire l’insensato:
(4) Impalluccio il luccio con il gatto palliduccio
Ora l’illocutività del linguaggio, ciò che paradigmaticamente cattura il fenomeno della performatività linguistica, è esattamente una dimensione di...
Indice dei contenuti
- Capitolo primo. La metafisica della finzione (1). Che cos’è un atto di finzione
- Capitolo secondo. La metafisica della finzione (2). Che cos’è un oggetto fittizio
- Capitolo terzo. L’ontologia della finzione. Ci sono entità fittizie?
- Capitolo quarto. L’epistemologia della finzione. Stati mentali e finzione
- Cos’altro leggere
- Riferimenti bibliografici
- Ringraziamenti
- L’autore