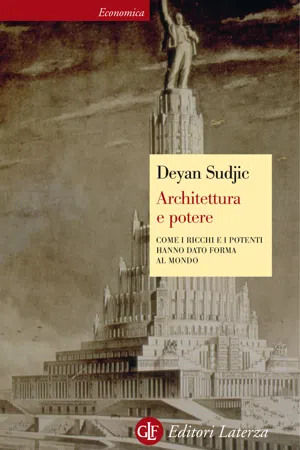II. La lunga marcia verso la scrivania del capo
Adolf Hitler si recò a Parigi una sola volta in tutta la sua vita. Ci andò dopo il crollo dell’esercito francese, come capo vittorioso del Terzo Reich, da lui creato ed esteso dall’Atlantico alla frontiera con l’Unione Sovietica, per cancellare l’umiliazione subita dalla Germania a Versailles, nel 1919. Il 28 giugno 1940 atterrò all’aeroporto di Le Bourget subito prima dell’alba. Ma a sedergli accanto, sull’aereo personale, non c’erano generali o dirigenti del partito. Insolitamente, Hitler aveva scelto di assaporare il suo più importante momento di trionfo militare in compagnia di due architetti, Albert Speer e Hermann Giesler, e di Arno Breker, il principale scultore del regime: evitò i luoghi della politica più scontati e, invece di recarsi al palazzo dell’Eliseo o alla sede dell’Assemblea Nazionale, li condusse a vedere il Teatro dell’Opera, il Palazzo Charles Garnier, e passò più di un’ora mettendo alla prova il ricordo dei progetti tanto ossessivamente studiati a Vienna nei giorni della sua vita povera; conosceva l’edificio così bene che, percorrendo i sontuosi corridoi di marmo, riuscì a individuare l’ubicazione di una porta murata, che una volta si apriva su una stanza poi eliminata da successivi interventi.
Più tardi, quello stesso giorno, sullo scalone di Les Invalides venne scattata una delle foto più indimenticabili del XX secolo, un’immagine chiave per comprendere la natura della sete di potere hitleriana. L’ex caporale, appassionato di architettura durante tutto l’arco della sua vita, sostò presso la tomba di Napoleone e, nell’uscire, affidò a Giesler il compito di progettare qualcosa di ancora più imponente, quando fosse giunto il momento. Ecco che il gruppo riemerge alla luce del sole, Hitler si trova ovviamente al centro e indossa un lungo soprabito bianco. Tutti gli altri sono vestiti di nero da capo a piedi, quasi anticipassero stranamente la passione per gli abiti Comme des garçons, così diffusa tra gli architetti all’inizio del XXI secolo. Molti di loro sono militari, e un paio appartengono all’entourage politico del Führer, fra cui spicca Martin Bormann. Ma l’uomo in uniforme che si trova immediatamente alla destra di Hitler, e guarda la macchina fotografica, è Speer. Alla sua sinistra, a rispettosa distanza, stanno Giesler e Breker, lo scultore, con il tipico berretto a visiera dei nazisti.
Il capo, circondato dai suoi seguaci architetti, è una figura magica che irradia luce, come un Re Sole attorniato da insignificanti mortali confusi nelle tenebre. Si tratta di una scena meticolosamente costruita come i raduni del partito ideati da Speer, un quadro vivente denso di significati e – almeno in teoria – sorprendente, come se George W. Bush decidesse di farsi un giro per Baghdad in compagnia di Jeff Koons, Philip Johnson e Frank Gehry. Il dittatore illustra le priorità e spiega in modo estremamente chiaro le proprie intenzioni: il grande architetto Hitler si appresta a ridisegnare il mondo. E tuttavia non comprenderemo mai a sufficienza questa semplice verità: Hitler non voleva essere visto come un capo militare o un personaggio politico, ma come un artista. Per molti leader l’architettura rappresenta un mezzo per raggiungere uno scopo. Esiste invece la reale possibilità che, almeno per Hitler, sia sempre stata un fine in sé.
Quando Emil Hácha infine oltrepassò il secondo dei due enormi cancelli di bronzo che costituivano l’entrata ufficiale della Cancelleria del Reich, nella Wilhelmstrasse, era già da un pezzo passata la mezzanotte. Dal suo appartamento all’Adlon Hotel, il presidente cecoslovacco aveva compiuto in auto il breve percorso attraverso le strade vuote di Berlino, sedendo di fronte al ministro degli Esteri tedesco, il barone Joachim von Ribbentrop. Una piccola folla, non più di cinquanta persone, attendeva per vederli passare velocemente, diretti verso quelle che sarebbero state le tre ore più difficili di tutta la vita di Hácha.
Era un orario piuttosto scomodo per compiere una visita di Stato, ma il 15 marzo 1939 sarebbe stato uno dei giorni più critici della storia europea. Hitler aveva rimilitarizzato la Renania e annesso l’Austria senza sparare un colpo. Era ora deciso ad assicurarsi allo stesso modo il pieno dominio della Cecoslovacchia, se gli fosse riuscito. Il primo e unico presidente della seconda repubblica cecoslovacca si era recato in visita a Berlino nel disperato e inutile tentativo di strappare il proprio paese dall’oblio. Aveva infatti già perduto la regione dei Sudeti, con tutte le sue file di fortificazioni e casematte allineate lungo la frontiera con la Germania, in seguito al tradimento della conferenza di Monaco. Ora Hitler voleva distruggere del tutto lo Stato assediato. Incoraggiati dalla Germania, gli ungheresi e i russi stavano muovendosi per assicurarsi fette di territorio cecoslovacco, lasciando il resto ai nazisti sotto forma di protettorato del Reich. Allo stesso tempo gli slovacchi preparavano una secessione per creare uno Stato satellite della Germania, dando a Hitler la possibilità di attaccare la Polonia, il suo prossimo obiettivo nella ricerca del Lebensraum.
Hácha non aveva altre carte da giocare oltre alla propria dignità. I suoi funzionari avevano tempestato Berlino di telefonate negli ultimi tre giorni, implorando un’udienza con il Führer. Quando alla fine Hitler acconsentì all’incontro, 200.000 soldati tedeschi furono mobilitati per varcare la frontiera. In effetti, il treno speciale che conduceva Hácha a Berlino insieme con la figlia, il Primo ministro František Chvalovský e un piccolo gruppo di funzionari, arrivò con un’ora di ritardo, intralciato dai trasporti di truppe che si muovevano verso sud e verso est. Che la posizione di Hácha fosse quella di un postulante apparve subito chiaro. Una guardia d’onore ricevette il presidente alla stazione dell’Anhalt, seguendo alla lettera il protocollo diplomatico. Ma la delegazione addetta al ricevimento annoverava solo funzionari di rango offensivamente inferiore, e il direttore della banda musicale omise di suonare l’inno nazionale cecoslovacco. Hácha probabilmente si pentì di non essere rimasto a Praga per ordinare alle sue truppe di combattere. I negoziati avevano avuto inizio senza che i cecoslovacchi lo sapessero, e ora avevano già perso il primo round. Il presidente si recò all’Adlon Hotel, mentre il suo Primo ministro Chvalovský chiamò il ministero degli Esteri tedesco e si mise in contatto con Ribbentrop, che poi lo riaccompagnò in albergo. Le condizioni che Hácha si vide presentare erano così brutali che lui e Chvalovský sulle prime rifiutarono di lasciare l’hotel. Ribbentrop li lasciò rimuginare per più di un’ora mentre si recava da Hitler, poi ripassò a prenderli: secondo un testimone, avrebbe passato questo tempo guardando un film con il Führer.
Hácha era diventato presidente quando Edvard Beneš, il suo predecessore, nel 1938 era andato in esilio perché Neville Chamberlain si era rifiutato di sostenerlo contro le pretese territoriali di Hitler, acconsentendo così allo smembramento della prima repubblica cecoslovacca. Era un autorevole giurista, capo della Corte suprema, ma con poca esperienza politica e ancor meno stoffa di combattente. Se la sua arrendevolezza nei confronti di Hitler sia stata un modo di salvarsi la pelle, oppure un tentativo di risparmiare al proprio paese inutili spargimenti di sangue, resta una questione aspramente controversa. Sarebbe morto in disgrazia nel 1945 nell’ospedale della prigione di Praga, dove era detenuto come collaborazionista dopo la liberazione alleata del protettorato di Boemia e Moravia. Ma quali che fossero le sue intenzioni, ebbe bisogno di vero coraggio quando entrò nel Cortile d’onore della Cancelleria, in quella notte berlinese di sei anni prima.
Nella sua funzione di preludio al palazzo, il cortile era stato concepito da Albert Speer come un mondo all’interno di un altro mondo, privo di ogni altra uscita oltre quella voluta da Hitler. I suoi muri spogli illuminati dai riflettori chiudevano fuori la città per creare uno spazio vuoto, aperto verso il cielo, in cui le guardie del Führer, marciando avanti e indietro, proiettavano ombre giganti sullo sfondo delle ciclopiche dimensioni. Il vuoto del cortile era riempito dalle urla degli ordini e dal suono degli stivali in marcia sulla pietra. Si trattava di una manifestazione pratica del potere politico espresso tramite l’architettura, la cui valenza simbolica veniva utilizzata per scopi attentamente calcolati. A meno di centocinquanta chilometri di distanza, il ben equipaggiato esercito cecoslovacco, dotato di una moderna artiglieria nonché di aerei e carri armati Škoda tecnologicamente avanzati, attendeva l’ordine di Hácha per difendere il proprio paese. Ma a Berlino si stava facendo in modo che questi si sentisse invece indifeso, paralizzato dalle luci dei riflettori di Speer nell’apparato scenico delle sue architetture, meticolosamente progettate per fargli credere di essere alla mercé dell’uomo più potente del mondo.
Per la seconda volta quella notte Hácha passò in rivista una guardia d’onore, con l’accompagnamento musicale di un’altra banda militare, e salì gli scalini che dal cortile portavano all’alto e stretto ingresso della Cancelleria, fiancheggiato da due statue di Breker in bronzo, alte 4 metri e mezzo, che raffiguravano una coppia di giganti teutonici nudi e gonfi di muscoli. Quello alla sinistra di Hácha impugnava una spada sguainata per rappresentare la Wehrmacht, mentre il suo omologo, dall’altro lato, reggeva una torcia accesa a simboleggiare il partito nazionalsocialista. Sopra l’entrata, incastonata nella pietra di provenienza nazionale con cui era costruito l’intero palazzo, un’aquila di bronzo spiccava il volo stringendo una svastica fra gli artigli. Quattro colonne monolitiche incombevano sugli scalini. Hácha era un uomo di quasi settant’anni, basso di statura, stempiato e dai capelli radi con un paio di grosse sopracciglia, e debole di cuore. Salire la scala, sotto lo sguardo fisso delle SS in guanti bianchi ed elmetti di acciaio, con le baionette inastate, l’aveva lasciato senza fiato. Gli scalini dovevano mostrare ai visitatori come ascendere al livello del Führer fosse un privilegio, e allo stesso tempo creavano un piano terra senza finestre, che esprimeva la funzione difensiva del Palazzo della Cancelleria, collegato a tre livelli di bunker sotterranei posti sotto e dietro l’edificio. Hácha, pallido come un cencio, era preoccupato e confuso mentre percorreva l’atrio d’ingresso completato appena otto settimane prima. Era esattamente il tipo di visitatore per cui il palazzo era stato progettato. Se mai l’architettura può essere usata come un’arma, questo era un caso esemplare.
La grandiosità della Cancelleria era parte essenziale del piano di Hitler per costringere Hácha a capitolare. Oltre il cortile, che in sé costituiva una specie di summa dello Stato nazista, all’interno del palazzo si snodava una sequenza di spazi attentamente disegnati per condurre alla presenza di Hitler i visitatori ufficiali, mantenendoli in uno stato d’animo di opportuna intimidazione. Dopo aver percorso quasi quattrocento metri, essi non avevano più dubbi sulla potenza della nuova Germania. In questo senso, l’architettura era soprattutto un mezzo rivolto a un fine. «Ho un compito assai urgente per voi», Hitler disse a Speer all’inizio del 1938. «Nel prossimo futuro dovrò tenere conferenze molto importanti. Perciò ho bisogno di sale e saloni maestosi che facciano impressione sulle persone, e specialmente sui funzionari di grado inferiore». Certo, Bismarck era riuscito a orchestrare l’unificazione tedesca senza ricorrere a simili stratagemmi autocelebrativi. Aveva sì ‘lavorato’ nei paraggi relativamente modesti della vecchia Cancelleria, poi fagocitata dall’opera di Speer. Ma non aveva mai voluto essere anche architetto.
Oltrepassate le guardie e fuori dalla luce dei riflettori, Ribbentrop accompagnò Hácha all’interno del portico e lo fece entrare nella sala retrostante, priva di finestre, dalle pareti decorate con l’immagine pagana di aquile a mosaico che stringevano torce accese inghirlandate con foglie di quercia, e sdrucciolevoli pavimenti di marmo. Non c’erano mobili, nemmeno l’impronta di un tappeto a ingentilire la severità della sala. Al di sopra del marmo del pavimento stava sospeso un soffitto di vetro opaco, illuminato elettricamente dall’interno, che diffondeva una luce senza ombre in un gesto inequivocabilmente moderno e quasi art déco. Nemmeno Hitler era riuscito a escludere ogni traccia del mondo contemporaneo. Questo era lo spazio che lo scultore Arno Breker descrisse come «pervaso dal fuoco del potere». L’unico suo scopo era quello di impressionare. Sotto il vetro sospeso, le porte di bronzo aperte nelle massicce pareti di marmo, dall’altra parte della sala, luccicavano in segno di richiamo e di minaccia. I visitatori erano prepotentemente sospinti a percorrere quello spazio, come se dovessero passare attraverso una galleria del vento. Mentre camminava, Hácha era consapevole che il suo cuore stava accelerando, con battiti rapidi e irregolari.
Dopo aver attraversato un’altra serie di porte, Ribbentrop condusse Hácha in una stanza circolare sormontata da una cupola. Speer l’aveva progettata nel vano tentativo di nascondere il fatto che l’inesorabile asse spaziale da percorrere per essere ammessi alla presenza di Hitler doveva adattarsi, almeno per il momento, alla casuale geometria planimetrica di Berlino e alla sopravvivenza di vestigia architettoniche del passato. Oltre questa stanza, Hácha aveva trovato un’altra sala di marmo, risonante d’echi. Con i suoi 150 metri, la sua lunghezza era due volte quella della galleria degli specchi di Versailles. Hitler e Speer non si stancavano mai di ricordare questo fatto quando snocciolavano le interminabili liste dei record architettonici battuti dal Palazzo della Cancelleria.
Più in lontananza, Hácha poteva vedere ancora un altro ambiente, il salone dei ricevimenti dove Hitler, nel gennaio appena trascorso, aveva riunito le delegazioni diplomatiche presenti a Berlino per l’inaugurazione della Cancelleria. Come il Führer disse in quell’occasione, «nel lungo percorso che separa l’entrata dal salone dei ricevimenti tutti avrebbero assaporato la potenza e la grandezza del Reich tedesco». Ma non era qui che Ribbentrop stava conducendo Hácha. La sala che stavano percorrendo era alta 10 metri; sulla sinistra una fila di finestre dava su Voss Strasse, mentre sulla destra si aprivano cinque portali giganteschi, alti ciascuno più di 5 metri. I due uomini si fermarono davanti alla coppia di porte centrali, sorvegliate da due SS con elmetti d’acciaio. Un cartiglio di bronzo al di sopra della porta recava le iniziali AH: era lo studio di Hitler, che lui chiamava il suo laboratorio, anche se il termine teatro sarebbe stato più adatto. Forse Hácha riconobbe gli arazzi del XVIII secolo che decoravano entrambi i lati della porta, visti quando era uno studente di legge in vacanza a Vienna. Erano stati presi al Kunsthistorisches Museum e rappresentavano la conquista da parte di Alessandro il Grande del mondo allora conosciuto.
La sala si fregiava di un alto soffitto a cassettoni. Nell’angolo più lontano si trovava la scrivania di Hitler, presso una delle finestre alte quanto tutta la parete. Estesa più di 370 metri quadrati, non era una semplice sala. Per andare dalla porta alla scrivania ci voleva un intero minuto, il che metteva a dura prova i nervi. Hácha forse non colse il significato delle imprese di Alessandro raffigurate sugli arazzi, ma gli intarsi di fronte alla scrivania di Hitler, che rappresentavano Marte con la spada estratta a metà dal fodero, non avrebbero potuto essere più espliciti. L’effetto era amplificato dalle pareti in marmo rosso sangue, dal gigantesco mappamondo sul piedistallo vicino al tavolo di marmo, davanti alla finestra, e dal tappeto intrecciato con il motivo della svastica. Accanto alla scrivania si ergeva un busto di Bismarck, ma Hácha non si rese conto che si trattava di un trucco di Speer. L’originale infatti si era rotto durante la costruzione della Cancelleria e Speer aveva tenuto segreto il cattivo presagio, pregando Breker di farne una copia. «Gli conferimmo una patina antica lasciandolo a bagno nel tè», avrebbe dichiarato in seguito.
Più lontano, dall’altra parte della sala, al di sopra di un camino collocato fra due porte gemelle, era appeso uno dei ritratti di Bismarck dipinti da Lembach. Davanti al camino c’era un sofà grande come una scialuppa di salvataggio, su cui sedevano Goebbels e Göring. Il maresciallo dell’aria Göring iniziò a descrivere le carneficine che i suoi Stukas avrebbero potuto facilmente provocare a Praga. Avrebbero iniziato con la distruzione del castello e poi si sarebbero spostati sulla città, quadrante dopo quadrante. Per il nervosismo Hácha, sotto pressione, ebbe improvvisamente un collasso. Si riprese, ma tre quarti d’ora dopo il suo arrivo, prima di firmare il trattato che avrebbe posto i cechi sotto il controllo tedesco, perse nuovamente i sensi e venne chiamato il medico personale di Hitler. «Avevo talmente fatto pressione su quel vecchio che i suoi nervi crollarono completamente, era sul punto di firmare ma ebbe un attacco di cuore», Hitler disse in seguito a Speer. «Nella sala da pranzo il dottor Morell gli fece un’iniezione, ma questa si rivelò anche troppo efficace: Hácha recuperò le forze più del necessario, si riprese e non fu più disposto a firmare».
Solo alle quattro del mattino lo spirito di Hácha cedette ed egli acconsentì a sottoscrivere il documento che riconosceva la completa capitolazione della Cecoslovacchia, dichiarando che il destino dei cechi era nelle mani di Hitler e del Reich. La repubblica ceca aveva smesso di esistere, e lo stesso Hácha era ridotto al ruolo di governante fantoccio del protettorato tedesco di Boemia e Moravia. Un’umiliazione sulla quale ebbe molto tempo per riflettere durante l’interminabile tragitto a ritroso attraverso le marmoree sale a mosaici della Cancelleria.
L’architettura di Speer aveva evidentemente assolto il compito che Hitler si aspettava, infliggendo un colpo quasi mortale al presidente Hácha e aiutando la Germania a invadere un intero paese senza incontrare opposizione. Speer aveva concepito ogni blocco di pietra, ogni mobile, ogni arazzo, ogni interruttore elettrico e ogni curva e svolta della pianta affinché servissero a rafforzare il messaggio della implicita superiorità tedesca. Era entusiasta della propria decisione di usare pietra vera, e non cosmetici rivestimenti di tale material...