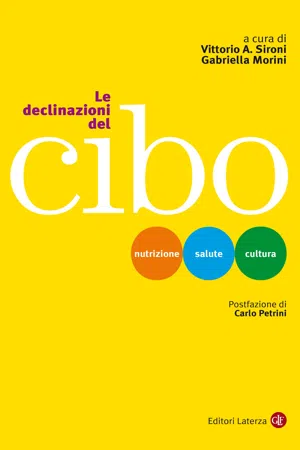Per un futuro in salute:
essere in forma tra scuola e famiglia
di Sergio Bernasconi*
Oggi la medicina dimostra come le condizioni di buona salute si costruiscano nel tempo. I meccanismi biologici che controllano la nostra vita sono plasmati durante la vita fetale e modificati nelle fasi di maggiore crescita e sviluppo, che caratterizzano l’età evolutiva, da un dinamico rapporto tra il patrimonio genetico ereditato dai nostri genitori e l’ambiente in cui viviamo. A una maggiore attenzione verso quest’ultimo si deve accompagnare un impegno diretto nella costruzione della nostra salute futura, modificando positivamente le nostre abitudini alimentari e adottando corretti stili di vita.
1. L’importanza di assumere corretti stili di vita
Negli ultimi decenni la medicina ha dimostrato come le condizioni di buona salute si costruiscano nel tempo, partendo già dall’epoca prenatale. I meccanismi biologici che controllano la nostra vita vengono plasmati durante la vita fetale e modificati nelle fasi di maggiore crescita e sviluppo, che caratterizzano l’età evolutiva, da un dinamico rapporto tra il patrimonio genetico ereditato dai nostri genitori e l’ambiente in cui viviamo. Sappiamo, per esempio, che l’inquinamento è causa importante di malattia diretta (malattie broncopolmonari nel caso dell’inquinamento atmosferico) o di modifiche metabolico-ormonali che possono portare nel tempo a sviluppare condizioni patologiche. Recentemente è stata dimostrata una stretta correlazione tra obesità, insulino-resistenza e livelli urinari di alcuni metaboliti degli ftalati (sostanze chimiche provenienti da plastiche, prodotti di cosmesi, vernici, diserbanti in grado di interferire su vari meccanismi ormonali) (1).
Le più importanti cause di mortalità e/o morbilità, con conseguente peggioramento della qualità della vita (malattie cardiovascolari e numerosi tipi di neoplasie), possono essere totalmente o parzialmente prevenute o attenuate da corretti stili di vita.
Con questa dizione ci si riferisce sia al danno provocato da comportamenti non corretti (abuso di alcool, fumo, uso di sostanze stupefacenti) sia alla pratica di una corretta alimentazione e allo svolgimento di una regolare attività fisica. Ultimamente anche la regolarità del sonno è stata inserita in questo contesto, dato che si è dimostrata l’esistenza di un legame tra alterazione del sonno e rischio di obesità. Una recente meta-analisi di studi eseguiti in bambini di età inferiore ai 10 anni ha sottolineato che per ogni ora di aumento del sonno vi è una diminuzione del rischio di obesità del 9% (2). Uno studio compiuto su oltre 7000 bambini di 3 anni, seguiti longitudinalmente con un monitoraggio della loro tipologia di sonno, ha dimostrato che dormire meno di 10,5 ore al giorno si associa a condizioni di obesità a 7 anni (3).
Numerose evidenze scientifiche hanno inoltre chiarito come sia importante che stili di vita corretti vengano appresi e applicati fin dalla prima età (4) e, ancor prima della nascita, dalla madre in preparazione della e durante la gravidanza (5). Nelle madri un Body Mass Index (BMI) pre-gravidico superiore alla norma è un segnale predittore di patologie gravidiche quali un maggior rischio di tagli cesarei, di diabete mellito gestazionale e di pre-eclampsia (6). Nelle adolescenti gravide l’eccesso di zuccheri determina un accumulo di grasso addominale nel feto (7), inoltre macro e micro-nutrienti modulano le citochine pro-infiammatorie, la differenziazione delle cellule immunitarie e la loro proliferazione mediante meccanismi epigenetici (8).
Partendo da questi dati, le autorità sanitarie di vari paesi da alcuni anni esercitano una forte sollecitazione rivolta a tutta la popolazione, e in particolare ai pediatri e ai sanitari che operano per l’età evolutiva, nel collaborare all’opera di educazione sanitaria e di prevenzione pianificata a livello nazionale e regionale. Molti programmi sono stati focalizzati sulla prevenzione dell’obesità.
L’intervento su bambini e adolescenti deriva da varie considerazioni:
1) le cattive abitudini alimentari e la tendenza alla sedentarietà tendono a mantenersi nel tempo fino all’età adulta. Per esempio, bambini di due fasce di età (5-6 e 10-12 anni) si sono potuti suddividere statisticamente, in rapporto ai loro stili di vita e all’inizio dello studio longitudinale, in tre gruppi: un primo gruppo con stili di vita corretti, un secondo abituato a consumare cibi ad alta densità calorica e con molto tempo dedicato alla televisione, un terzo abituato alla sedentarietà o all’attività fisica moderata. In ambedue le fasce di età si è notata una tendenza a rimanere nello stesso gruppo nei tre anni di follow-up, con una significativa propensione a sviluppare sovrappeso e obesità nel secondo gruppo (9).
2) I dati epidemiologici mostrano un’elevata incidenza di obesità in età precoce. Le ultime rilevazioni nazionali (2014) del programma di sorveglianza Okkio alla salute (www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/), promosso e finanziato dal ministero della Salute, coordinato dall’Istituto superiore di sanità e riferito a bambini tra 8 e 9 anni, indicano valori del 20,9% per il sovrappeso e del 9,8% per l’obesità (il 2,2% di tipo grave). Queste percentuali rappresentano valori medi ed esiste una notevole variazione da regione a regione con una tendenza all’aumento da Nord a Sud. Se paragoniamo queste medie a quelle raccolte negli anni precedenti, notiamo una diminuzione negli ultimi sei anni del 2,4% per il sovrappeso e del 2,2% per l’obesità. Da un lato questo dato è positivo e incoraggia a proseguire e intensificare l’opera di prevenzione, ma dall’altro non deve far dimenticare che Grecia, Italia e Spagna sono ai primi posti in Europa per incidenza di obesità rispetto a nazioni più «virtuose» come Belgio, Norvegia e Lituania. Anche se prendiamo in considerazione bambini in età prescolare (2-5 anni), troviamo in Europa percentuali significative di sovrappeso e obesità con punte in Spagna del 15-16% (10). In Italia in età adolescenziale il 31,4% dei maschi e il 10,6% delle femmine quindicenni sono in sovrappeso e rispettivamente il 3,9 e 1,4% sono obesi (www.hbsc.unito.it).
Questi dati epidemiologici rivestono una particolare importanza in quanto esiste una continuità tra obesità infantile/adolescenziale e obesità adulta, in particolare nelle forme più gravi e nelle fasce di età puberale e post-puberale (11). Secondo una recente esperienza svedese, il 79% degli adolescenti obesi a 15 anni rimane tale a 20 (12) ed è stato inoltre dimostrato che, dopo trent’anni da una valutazione fatta in età evolutiva, il 16% di bambini e adolescenti rimane obeso e il 34% sovrappeso (13).
Nell’adulto è assodato che l’eccesso ponderale e l’obesità favoriscono l’insorgere di malattie cardiovascolari (14); inoltre gli adulti obesi, che sono tali durante l’adolescenza, sono a maggior rischio di diabete di tipo 2, ipertensione, dislipidemia e lesioni aterosclerotiche carotidee (15).
3) I bambini/adolescenti obesi possono sviluppare più facilmente, rispetto ai coetanei normo-peso, patologie a livello di vari organi e/o apparati (polmone, fegato, apparato scheletrico, ecc.) e vanno più frequentemente incontro a problemi psico-comportamentali (depressione) e sociali (in quanto vittime di bullismo) (16); inoltre, hanno già evidenti alterazioni di laboratorio in tre dei parametri coinvolti nella genesi delle complicanze in età adulta: dislipidemia, flogosi di basso grado e resistenza insulinica (17). In altri termini, già nel bambino obeso è possibile tracciare, sulla base di vari parametri quantitativi, un profilo di rischio da monitorare nel tempo.
4) Una volta instauratasi, l’obesità è difficile da ridurre. Lo dimostrano i risultati ottenuti anche da centri altamente specializzati che, dopo due anni di follow-up, registrano un drop-out di pazienti superiore al 40% e, nel rimanente 60%, una significativa riduzione del peso solo nel 25% (18). Questi risultati poco brillanti trovano una possibile spiegazione sia nel fatto che la patogenesi dell’obesità è ancora poco nota e sicuramente plurifattoriale (19) sia nel fatto che con il dimagrimento si attivano vari meccanismi biologici che tendono a far recuperare il peso perduto (20).
5) Anche se non esistono ancora studi longitudinali condotti in maniera scientificamente rigorosa, la meta-analisi delle evidenze disponibili in letteratura dimostra che un intervento sugli stili di vita (tabella 1) è in grado di migliorare il BMI e di ridurre alcuni parametri di rischio cardiovascolare (colesterolo, trigliceridi, insulinemia) e i valori di pressione arteriosa (21)....