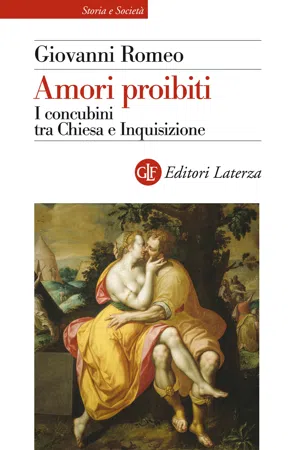VI. Tra eresia e peccato: gli amori proibiti a Napoli dal primo Seicento alla peste del 1656
1. Il 12 luglio 1615 una cerimonia di abiura inconsueta attirò a Roma, nella basilica di S. Maria sopra Minerva, l’intero collegio cardinalizio, molti rappresentanti della nobiltà cittadina e una grande folla. Nel corso di essa tre inquisiti revocarono ‘eresie’ sessuali pesantissime, diffuse a Napoli per parecchi anni da una presunta santa e dai suoi complici e accompagnate da pratiche altrettanto scandalose. Si trattava di un religioso appartenente alla Congregazione dei ministranti agli infermi, padre Aniello Arciero, di una sua figlia spirituale, la terziaria Giulia De Marco, e di un avvocato, Giuseppe De Vicariis. La sentenza fu pubblicata poche settimane dopo anche nella Cattedrale di Napoli, grazie a una scelta che i vertici inquisitoriali romani avevano subordinato al consenso dell’arcivescovo Carafa. Tuttavia, data l’estrema delicatezza del caso, le modalità di svolgimento della cerimonia furono suggerite nei dettagli da Roma, dal papa e dai cardinali della Congregazione.
Era opportuno – si raccomandò al Carafa – che egli ne concertasse l’organizzazione insieme al Nunzio e al ministro dell’Inquisizione delegata e che fossero presenti tutti i confessori della diocesi. Inoltre, lo stesso arcivescovo avrebbe valutato se era il caso di evitare la lettura dei passaggi più scabrosi della sentenza. Erano cautele ovvie, che pure non bastarono ad impedire drammatici contraccolpi, segnalati immediatamente alla Congregazione: un uomo ammazzò la moglie, devota di suor Giulia, altre donne legate alla terziaria rischiavano di fare la stessa fine1. Era un epilogo doloroso e forse inevitabile, in una vicenda che aveva suscitato polemiche e clamori di ogni genere, non solo a Napoli. Non era stato facile incastrare il gruppo: condannati già nel 1609 per simulazione di santità, avevano confessato le trasgressioni più gravi, insieme a numerosi complici, solo nel corso di un secondo procedimento, aperto nell’estate del 1614.
Parecchi testimoni li accusarono di aver fondato a Napoli una Congregazione dedita ad attività sessuali di ogni genere, praticate sotto il segno della santità: a lumi spenti, dopo una breve orazione in lode della ‘Carità carnale’, recitata da suor Giulia, i devoti presenti erano invitati dalla donna a congiungersi liberamente. Essi erano convinti di non commettere peccati, ma atti meritori che li univano a Dio, grazie a un dono del Signore che la terziaria trasmetteva loro: quello di vivere qualsiasi esperienza sessuale senza perdere la castità. Da Dio era venuto a suor Giulia anche il potere di indovinare i più riposti peccati degli altri. Ma nell’autunno del 1614 una realtà molto più prosaica si era delineata davanti ai cardinali del Sant’Ufficio: i tre leader avevano ammesso che la loro era una truffa ben organizzata, in cui padre Aniello e suor Giulia avevano avuto un ruolo determinante. Illuminazioni divine non ce n’erano: la presunta santa conosceva i più occulti segreti del cuore di ciascuno solo grazie alle informazioni che il religioso raccoglieva nel corso delle confessioni e le comunicava quotidianamente. Ecco un passaggio, tra i più castigati, dell’abiura della donna:
[i] miei devoti e figli spirituali... per non recare confusione, li facevo dividere in più congregazioni in alcune stanze secrete della mia casa in un’ora a ciò destinata, dove, dopo una brieve orazione, che faceva loro in lode della Carità carnale, spenti i lumi, li facevo congiungere insieme, e ciò senza scrupolo d’incorrere in peccati, anzi con fare atto meritorio, ogni volta che si reiterava la copula, stante la partecipazione fatta loro del dono della castità comunicatomi da Dio, conforme mi avea detto il P.e Aniello Arciero mio confessore, il quale per mostrare a tutti che io ero una Santa, e che Iddio mi avea comunicato il suo lume divino, e per penetrare l’interno del cuore delle persone, mi rivelava giornalmente i peccati occulti, che li suoi penitenti li dicevano in confessione, che poi io parlando con quelli gli avvertivo de’ loro occulti difetti, e li persuadevo che l’anima mia era sempre attualmente unita con Dio2.
Ovviamente, di fronte a confessioni di questo tipo, bisogna sgombrare il campo dai dubbi sulla loro attendibilità. Possiamo essere certi che i giudici non le avessero estorte, che non si trattasse di una manifestazione autentica di santità, deformata e stravolta dagli ingranaggi spietati dell’intolleranza? L’ipotesi è stata avanzata per la prima volta parecchi anni fa: secondo uno studioso, suor Giulia e i suoi adepti sarebbero stati dei mistici perseguitati con asprezza da una Congregazione del Sant’Ufficio tesa a distruggere modelli di santità femminile laica incompatibili con i rigidi schemi agiografici della Controriforma. In funzione di quell’obiettivo, gli inquisitori generali non avrebbero esitato ad estorcere le confessioni, attraverso l’imposizione di stereotipi medievali di tipo orgiastico3. In realtà, se è vero che l’Inquisizione romana assunse proprio nel primo Seicento un ruolo decisivo nel controllo delle manifestazioni di santità e che esercitò con durezza i suoi nuovi poteri, non ci sono prove per sostenere che spregiudicati meccanismi giudiziari abbiano caratterizzato il processo del 1614-1615 a suor Giulia4.
Rispetto a un’ipotesi così aerea, parecchie nuove fonti fanno sembrare più accettabili, nelle linee di fondo, le conclusioni cui era giunta la storiografia napoletana del Novecento. Esse avevano liquidato la vicenda come un esempio di ciarlataneria prosperata tra le pieghe di un cattolicesimo troppo incline a dare credito a forme di devozione equivoche, malsane5. Oggi il loro acre moralismo può far sorridere, ma i costumi della città, i frammenti del caso di suor Giulia conservati nell’archivio centrale dell’Inquisizione romana e i confronti con numerosi altri episodi non meno scottanti, capitati negli stessi anni, invitano ancora una volta ad allargare lo sguardo dall’albero alla foresta: da un caso eclatante alla fisionomia abituale delle ‘eresie’ sessuali nell’Italia del primo Seicento6.
2. Un primo approfondimento riguarda le dinamiche giudiziarie. Sulla base dei decreti del Sant’Ufficio, l’ipotesi di una montatura costruita a freddo a danno di un gruppo di mistici è oggi difficilmente sostenibile. Anche nel secondo processo i contenuti e i toni delle decisioni adottate dagli inquisitori generali nei confronti dei tre ‘capi’ della conventicola sono in linea con gli standard repressivi applicati dall’Inquisizione romana a trasgressioni di tale gravità. Se c’è in esse qualcosa di atipico, dipende dallo straordinario credito di cui godono i leader del gruppo. La fama di santità della donna era diffusissima, a tutti i livelli: travalicava ampiamente i confini della città e coinvolgeva il viceré, i suoi ministri, il fior fiore dell’aristocrazia e un bel po’ di religiosi, prelati e cardinali. Il caso dei contatti di Federico Borromeo con suor Giulia non è l’unico, è solo il più eclatante. Fin dalle battute iniziali del primo processo i cardinali del Sant’Ufficio e il papa sono consapevoli di questa situazione e misurano attentamente i propri passi.
Ad esempio, aderiscono di buon grado, già nel febbraio del 1608, alla proposta del ministro dell’Inquisizione napoletana di rinunciare alla carcerazione di padre Arciero, troppo pericolosa, e di aggirare l’ostacolo, facendolo convocare a Roma dai superiori7. Negli stessi mesi è ancor più difficoltosa l’adozione di provvedimenti a carico di suor Giulia. La reclusione in un monastero della città è l’unica restrizione che i cardinali del Sant’Ufficio riescono ad imporle. Inoltre, ogni intervento giudiziario che la coinvolge è calibrato con molta cautela, specialmente quando sono chiamati a testimoniare nobili e donne8.
Queste scelte prudenti non impediscono agli inquisitori generali di adottare alla fine del primo processo misure punitive adeguate. Esilio dal regno, confinamento in un monastero romano, sospensione dalla confessione e divieto di accedere a cariche di governo nel suo Ordine sono il pesante fardello che grava su padre Aniello; la relegazione in un monastero di Cerreto Sannita è la drastica soluzione prescelta per la donna. L’avvocato De Vicariis è citato rapidamente solo nel decreto di condanna, come destinatario di un precetto (quello di consegnare scritti sulla presunta santa) e dell’obbligo di adempire penitenze salutari gravi. Non risulta neppure che sia stato sottoposto a un processo formale9. Insomma, fino alla condanna del 1609 la vicenda di suor Giulia è essenzialmente la storia del suo rapporto con un confessore imprudente o esaltato. L’unico obiettivo dei giudici sembra quello di impedire che quel legame si riannodi: una strategia processuale ordinaria, di fronte a una storia di simulazione nata, come tante altre, all’ombra del confessionale.
Anche per questa ragione, nel lungo intervallo che separa la prima condanna dall’inizio del secondo processo, la Congregazione mostra una certa disponibilità ad ammorbidire le punizioni inflitte al religioso e alla terziaria. Un solo limite sembra invalicabile: i due non si devono più incontrare. Così a lui fu revocato abbastanza presto il divieto assoluto di confessare, mentre l’attivissima madre di suor Giulia, sostenuta con forza dagli Eletti della città di Napoli, vide accolte, sia pur più faticosamente, le pressanti istanze di trasferimento della figlia, motivate dall’ar...