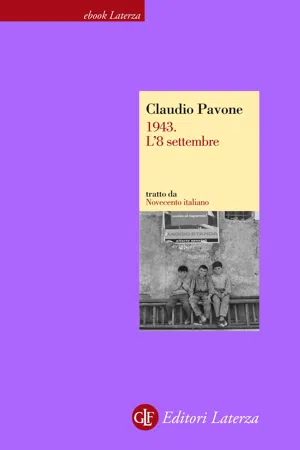1943. L’8 settembre
di Claudio Pavone
Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR:
Proclama del Capo del Governo, parla Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badoglio.
«Il Governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al Generale Eisenhower, Comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo; esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza».
È questo il proclama col quale il maresciallo Badoglio annunziava agli Italiani la conclusione dell’armistizio. Dell’ultima e infelicissima frase, le truppe «reagiranno ad attacchi da qualsiasi altra provenienza», torneremo a parlare fra un momento.
Qui voglio sottolineare subito il carattere di spartiacque che ha la data dell’8 settembre, spartiacque che viene confermato ed elaborato poi anche nella memoria che larga parte del popolo italiano ne ha avuto.
L’evento può essere considerato da due punti di vista: uno di carattere internazionale e l’altro per il suo significato più prettamente italiano. Io mi soffermerò soprattutto su questo secondo punto. Però un cenno a come l’armistizio si inquadra nel panorama della Seconda guerra mondiale ritengo opportuno farlo, anche limitandomi solo a dire che l’Italia era la prima potenza dell’Asse che capitolava. L’Italia era certo l’anello debole dell’Asse stesso, era già ridotta allo stremo e messa in condizioni di non nuocere; però era la culla del fascismo, quindi la sua capitolazione aveva anche un profondo significato politico, oltre che immediatamente militare.
Le trattative per l’armistizio condotte dal governo Badoglio erano state tortuose e ambigue: il governo si era illuso di potere giostrare fra gli Alleati e i Tedeschi, avendo sostanzialmente paura sia degli uni che degli altri, ma senza fare un calcolo preciso dei rapporti di forza, sopravvalutando la propria capacità di mediazione e cadendo quindi in molte ambiguità, che poi verranno fatte scontare dagli Alleati.
Comunque, quello che va detto è che all’Italia, per il fatto stesso che si concludesse con essa un armistizio, non venne applicata integralmente la cosiddetta formula di Casablanca: nel gennaio 1943, in una conferenza tenuta a Casablanca fra Churchill e Roosevelt, era stato affermato che le potenze dell’Asse dovevano arrendersi senza condizioni.
Ora, stipulare un armistizio, con condizioni certo molto dure per l’Italia, costituiva di per sé una deroga e fu un fattore che poi influirà sui rapporti con gli ex nemici.
Durante le trattative il governo italiano diede prova di molta superficialità, generando negli Alleati l’idea di non potersi fidare degli Italiani in generale. Ricorderò un solo episodio: in vista appunto dell’armistizio, e quindi della necessità di difendere dalla prevedibile reazione tedesca soprattutto la capitale, era stata avviata una trattativa affinché gli Alleati mandassero una divisione aviotrasportata a difendere Roma. Fu inviato in avanscoperta un generale americano, il generale Taylor, che al suo arrivo in Italia non poteva avere impressione peggiore di quella che ebbe. Badoglio lo ricevette in pigiama e il Capo di Stato maggiore generale Ambrosio era andato a Torino per motivi di famiglia. Allora Taylor fu costretto a comunicare ad Eisenhower di annullare l’operazione. Non era un bel precedente.
Il 3 settembre fu firmato a Cassibile, in Sicilia, il cosiddetto armistizio breve, cui poi seguirà l’armistizio lungo firmato a Malta il 29 settembre e sul quale sarebbe importante soffermarsi più a lungo perché contiene molte formule più politiche, più minuziose, anche per l’applicazione dell’armistizio: ad esempio, si parla della consegna di Mussolini agli Alleati e dell’abolizione delle leggi razziali che il governo Badoglio dei 45 giorni non aveva provveduto ad eliminare.
Per sottolineare l’ambiguità, che sarà una delle cause dello sfacelo seguito all’8 settembre, si possono ricordare due fatti: il primo è che ancora nel pomeriggio dell’8 settembre vi fu un Consiglio della Corona in cui si discusse se smentire completamente gli accordi con gli Alleati e quindi mancare alla parola data. Per fortuna questa fu una tesi che non prevalse, ma il semplice fatto che potesse essere discussa è molto indicativo. Il secondo fatto è che lo stesso giorno Badoglio si preoccupava di mandare al quartier generale di Algeri, dove si trovava il generale Eisenhower, un messaggio in cui assicurava che, se i Tedeschi avessero attaccato, l’esercito e il popolo italiano avrebbero reagito. Eisenhower fu costretto a dare per primo l’annuncio dell’armistizio per tagliar corto con queste tergiversazioni e incertezze del governo italiano.
Ci fu un momento in cui poteva anche capovolgersi questa inaffidabilità degli Italiani agli occhi degli Alleati: parlo del difficile momento che Inglesi e Americani stavano attraversando con lo sbarco di Salerno, avvenuto fra l’8 e il 9 settembre, quando rischiarono davvero di essere buttati a mare. In quel momento un eventuale aiuto degli Italiani, cioè dell’esercito italiano che avrebbe potuto prendere alle spalle i Tedeschi, sarebbe stato molto importante. C’è un messaggio, un promemoria che Churchill scrisse proprio il 9 settembre, indirizzato al presidente Roosevelt, in vista di un loro incontro alla Casa Bianca: «se dovessero scoppiare combattimenti fra Italiani e Tedeschi, le prevenzioni della pubblica opinione scomparirebbero rapidamente e in una quindicina di giorni la situazione potrebbe talmente maturare, se sapremo dirigere in questo senso gli eventi, da rendere possibile una dichiarazione di guerra alla Germania da parte dell’Italia». Questa dichiarazione arriverà tardivamente, il 24 ottobre. Quindi c’era la possibilità, nei rapporti con gli Alleati, di parlare da posizioni meno ambigue.
È anche interessante ricordare che alcuni deputati laburisti, nella seduta sull’Italia svoltasi alla Camera dei Comuni il 21 e 22 settembre, accusarono Churchill e il governo di aver puntato sulle forze più retrive italiane, il re, la monarchia e gli alti comandi dell’esercito. I due deputati presentarono una interpellanza, dichiarando che, «se il legittimo appello dei capi democratici italiani al popolo italiano fosse stato consentito», in modo che «la fiamma della libertà percorresse legittimamente l’Italia come fece durante il Risorgimento», i Tedeschi avrebbero avuto danni assai maggiori di quelli apportati da «uomini che si è preteso dovessero rischiare la vita per sostenere dei voltagabbana con armi insufficienti».
Possiamo così dire che ci fu una grande occasione perduta, perché, dato lo sfasciamento delle forze armate italiane, a Salerno gli Alleati dovettero cavarsela da soli; questo indubbiamente aumentò la diffidenza verso gli Italiani. In quelle circostanze non si andava molto per il sottile.
A questo punto possiamo passare a parlare delle reazioni italiane all’annuncio dell’armistizio. Non solo la reazione dei militari, ma anche quella della popolazione civile, che viene immediatamente tirata in ballo, come lo era stata, del resto, già dal carattere totale che aveva assunto la guerra: la popolazione civile sarebbe stata travolta non solo dai bombardamenti aerei, ma dalle tante altre forme di privazioni e di ristrettezze e infine dalle rappresaglie tedesche e fasciste.
E qui occorre un breve cenno al modo in cui gli Italiani avevano vissuto la guerra tra il 1940 e il 1943. È un argomento sul quale occorrerebbe indagare ancora, studiare, perché la rimozione della guerra fascista tra il 1940 e il 1943 è stata forte anche a livello degli studi. È importante comprendere quale fosse effettivamente lo stato d’animo precedente all’armistizio. Quelle che sarebbero state le reazioni all’8 settembre erano covate da tempo, si erano accumulate nell’animo degli Italiani, sia militari che civili, anche in precedenza; e si rivelarono apertamente con il trauma finale.
Dobbiamo anche dire che sia alcuni antifascisti militanti nelle carceri o nell’esilio, sia alcuni militanti solo con la mente e col cuore avevano ritenuto che la sconfitta militare fosse un doloroso ma necessario passaggio. Ad esempio, Benedetto Croce in una pagina del suo diario scrive: «io a un certo punto, sia pure facendo forza al mio animo che avrebbe preferito veder vincere il proprio paese, ho dovuto obbedire alla voce della mia coscienza e desiderare la sconfitta dell’Italia».
È una dichiarazione sicuramente di alto valore morale che fa il paio – posso citare solo questo raffronto – con quello che il pastore tedesco Bonhoeffer, con grande acutezza di previsione, aveva scritto subito dopo l’invasione della Cecoslovacchia da parte dei Tedeschi: «so purtroppo che fra un po’ di tempo verremo costretti, noi Tedeschi, a scegliere tra fare la guerra, e quindi appoggiare questo governo, oppure obbedire a una voce della nostra coscienza che ci dica come questo sarebbe un disastro innanzi tutto per la Germania». E Bonhoeffer, con parole molto simili a quelle di Croce, aggiungeva: «io so quale sarà la via che mi detterà la mia coscienza, anche se so benissimo quanto sia doloroso vedere sconfiggere in guerra il proprio paese». Bonhoeffer verrà ucciso dai nazisti dopo il fallito attentato a Hitler del 10 luglio 1944.
Per quanto riguarda le forze politiche, bisogna dire che la sinistra europea aveva fatto un certo sforzo per riconvertirsi dal pacifismo, seguito alla Prima guerra mondiale, a una politica di intervento attivo nei riguardi delle potenze fasciste. Questo processo si rafforzò dopo l’avvento al potere del nazismo nel 1933.
Dei combattenti del 1940-43, che avevano sperimentato direttamente la guerra, sono state messe in luce le insicure motivazioni: fedeltà alle istituzioni monarchiche più che fasciste, scarso entusiasmo – potrem...