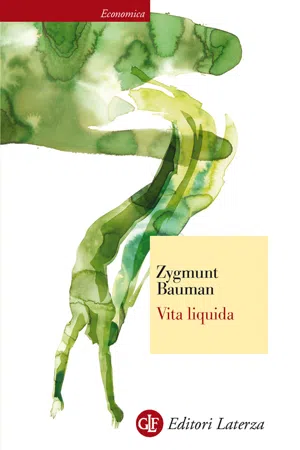
- 214 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Vita liquida
Informazioni su questo libro
Il consumismo ha un temibile avversario che ne demistifica i meccanismi sociali e psicologici. Il suo nome è Zygmunt Bauman. "L'Indice"
Stress, paura sociale e individuale, città alienanti, legami fragili e mutevoli: la vita liquida è precaria, vissuta in condizioni di continua incertezza, con la paura di essere colti alla sprovvista e rimanere indietro. Ciò che conta è la velocità, non la durata.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Vita liquida di Zygmunt Bauman in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Cultura popolare. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Cultura popolare1. L’individuo sotto assedio
L’eroe eponimo del film dei Monty Python Brian di Nazareth, furibondo per esser stato proclamato Messia contro la sua volontà e seguito ovunque da un’orda di adepti, cerca in tutti i modi, ma invano, di convincerli a non comportarsi come un gregge di pecore e ad andarsene. Grida loro: «Siete tutti degli individui!». E il coro dei devoti gli risponde prontamente all’unisono: «Sì, siamo tutti degli individui!». Solo una voce, flebile e solitaria, replica: «Io no...». Brian allora fa un altro tentativo: «Ognuno di voi è diverso!». «Sì, ognuno di noi è diverso!», approva entusiasticamente l’assembramento di fedeli. E, di nuovo, quell’unica vocina obietta: «Io no...». A quel punto la folla inviperita si guarda intorno per linciare il dissidente, se soltanto riuscisse a trovarlo, confuso nella massa indistinta.
In questa piccola gemma della satira è racchiuso tutto l’esasperante paradosso – o meglio l’aporia – dell’individualità. Alla domanda che cosa significhi essere individui, chiunque – dai filosofi fino a coloro che non si sono mai chiesti che mestiere faccia il filosofo – darebbe più o meno una risposta del genere: essere individui significa essere diversi da chiunque altro. Un’eco remota del modo in cui Dio si presenta a Mosè si può cogliere nella risposta «Io sono colui che sono», che significa: sono un essere unico, una creatura unica, fatta – o fattasi, come Dio – in modo talmente peculiare e unico che è impossibile descrivere tale unicità con parole che possano avere più di un referente.
Il guaio è che sono gli stessi ‘altri’ (dai quali non si può fare a meno di essere diversi) a pungolarci, spingerci, costringerci a essere diversi. È quella compagnia che si chiama ‘società’, di cui non si è che uno dei tanti, di quei tanti in giro e che sono più o meno familiari, ad attendersi (da me, da te, da chiunque altro si conosca o di cui si conosca l’esistenza) la prova risolutiva di come si sia un ‘individuo’ fatto, o fattosi, ‘diverso dagli altri’. Quando si tratta dell’obbligo di dissentire e distinguersi, nessuno può osare dissentire o distinguersi.
In una società di individui ciascuno deve essere un individuo: almeno in questo senso, chi fa parte di una simile società è tutto fuorché un individuo diverso dagli altri, o addirittura unico. Al contrario, ciascuno è incredibilmente uguale agli altri, in quanto deve seguire la stessa strategia di vita e deve utilizzare segni condivisi – ossia comunemente riconoscibili e intelligibili – per convincere gli altri che lo stanno facendo. In materia di individualità non esistono scelte individuali. In questo caso il dilemma «essere o non essere» non si pone affatto.
Paradossalmente, l’‘individualità’ è legata allo «spirito della folla»: è quest’ultima ad imporla. Essere un individuo significa essere uguale, anzi identico, a chiunque altro faccia parte della folla. In tale situazione, in cui l’individualità è un «obbligo universale» e la difficoltà in cui ognuno si dibatte, l’unico atto che farebbe veramente di me un individuo, un soggetto diverso dagli altri, sarebbe cercare – in modo sconcertante, sorprendente – di non essere un individuo: ammesso di potercela fare, e comunque rassegnandomi alle conseguenze (molto spiacevoli) di tale scelta...
Un rompicapo terribile, dunque. Non sorprende che la tremenda esigenza di individualità ci tenga occupati di giorno e svegli di notte... E in realtà non è nemmeno un semplice rompicapo, una mera contraddizione logica (possedimento esclusivo e preoccupazione privata dei filosofi, che, si sa, sono sempre pronti a scendere in guerra contro assurdità e contraddizioni, anche quando chi non si interessa di filosofia riesce a convivere pacificamente, e quasi senza accorgersene, con esse). Il rompicapo di cui parliamo esprime un compito assolutamente pratico, per completare il quale serve tutta la vita, per così dire ‘dalla culla alla bara’. In una società di individui come la nostra «società individualizzata», a ciascuno di noi è richiesto di essere un individuo, e tutti noi desideriamo ardentemente esserlo e ci impegniamo profondamente a tal fine.
Poiché «essere un individuo» viene normalmente tradotto come «essere diverso dagli altri», e poiché è a ‘me’, al mio io, che si rivolgono l’invito e l’aspettativa a emergere e a distinguersi dagli altri, il compito appare intrinsecamente autoreferenziale. Non sembra esserci altra possibilità se non quella di farsi consigliare sul modo migliore per addentrarsi sempre più profondamente all’‘interno’ di se stessi, in quella che è certamente la nicchia più privata e protetta di un mondo di esperienza che per il resto somiglia a un affollato e rumoroso bazar. Cerco il «vero me stesso», che suppongo nascosto da qualche parte nell’oscurità del mio essere originario, non condizionato (non inquinato, né soffocato, né deformato) dalle pressioni esterne. E libero dal suo involucro l’ideale dell’‘individualità’ intesa come autenticità, come «essere vero verso me stesso», il «vero me stesso». Mi cimento in una sorta di «introspezione fenomenologica» alla Husserl (per quanto spesso casareccia e frettolosa) nella mia ‘soggettività’ autentica e non contraffatta, realmente «trascendentale», attraverso una penosa opera di «riduzione fenomenologica» con cui «metto in epoché», ossia metto fra parentesi, sospendo, recido ed elimino qualsiasi elemento ‘estraneo’ che riconosco di aver importato dall’esterno.
Ecco quindi che prestiamo speciale ascolto alle emozioni e ai sentimenti che si agitano dentro di noi: ci appare, questo, un modo sensato di procedere, dal momento che le sensazioni – a differenza della distaccata e imparziale ragione, universalmente condivisa, o almeno ‘condivisibile’ – non sono ‘impersonali’, ma mie, e mie soltanto. Esse, dal momento che non possono essere comunicate con un linguaggio ‘oggettivo’ (o almeno non possono esserlo completamente in modo soddisfacente per noi e per chi ci ascolta), né condivise totalmente e senza residui, ci appaiono come l’habitat naturale di tutto ciò che è realmente privato e individuale. I sentimenti intrinsecamente soggettivi sono l’epitome stessa della ‘unicità’.
Diligentemente restiamo in ascolto delle voci «di dentro»: eppure difficilmente saremo mai convinti del tutto e al di là di ogni ragionevole dubbio che le voci non siano state fraintese, che le abbiamo ascoltate a sufficienza da poter prendere una decisione o pronunciare una sentenza. È evidente che non possiamo fare a meno di qualcuno che ci aiuti a interpretare ciò che udiamo, anche solo per rassicurarci sulla fondatezza delle nostre ipotesi. Quando si vuole, un modo si trova sempre, e quando c’è una domanda l’offerta non si fa mai attendere troppo. Nella nostra società di individui disperatamente in cerca della propria individualità non manca chi, sulla base della propria qualifica, o magari di una semplice autocertificazione, ci offre il suo aiuto (naturalmente al giusto prezzo) per farci da guida nelle oscure segrete della nostra anima, dove si troverebbe imprigionato il nostro io che lotta per uscire alla luce.
Ma anche quando troviamo simili soccorritori e ricorriamo ai loro servizi (a pagamento), le ansie non finiscono, sembrano anzi crescere e farsi più gravose. Così Charles Guignon ha sintetizzato di recente le gioie e i dolori delle visite guidate alla scoperta di sé:
Programmi ideati per aiutarci a entrare in contatto con il nostro vero io, e apparentemente motivati da ideali di emancipazione, hanno spesso l’effetto d’indurre a pensare in modo da confermare l’ideologia di chi li ha promossi. Il risultato è che molti di coloro che partono pensando di avere una vita vuota o priva di senso finiscono per smarrirsi nell’approccio mentale di uno specifico programma, o per avere, qualsiasi cosa facciano, la sensazione di ‘non essere abbastanza in gamba’1.
Molto spesso il viaggio alla scoperta di sé si perde in una fiera globale in cui le ricette per l’individualità vengono offerte a buon mercato («non ne troverete una migliore») e in cui qualsiasi kit di montaggio esposto in vetrina è in realtà un prodotto industriale di massa all’ultimo grido. Ed è allora deludente vedere come il valore delle caratteristiche meno comuni – quelle veramente individuali – del proprio io possa essere riconosciuto solamente dopo che esse sono state convertite nella valuta più comune e più largamente usata.
In breve l’individualità, in quanto atto di emancipazione personale e di autoaffermazione, appare gravata da una aporia congenita, da una contraddizione insanabile. Essa ha bisogno della società sia come culla che come punto d’arrivo. Chiunque cerchi la propria individualità dimenticando, respingendo o sottovalutando tale sobria/oscura verità si candida a una condizione di frustrazione. L’individualità è un compito che la società degli individui assegna ai suoi membri – un compito individuale, da svolgere individualmente, sulla base delle proprie risorse individuali. E tuttavia questo compito è autocontraddittorio e votato alla sconfitta: anzi, impossibile da svolgere.
La società degli individui, però, oltre a porre i suoi membri dinanzi alla sfida dell’individualità, fornisce loro anche i mezzi per convivere con quella impossibilità: in altri termini, per tollerare la sostanziale e inesorabile impossibilità di svolgere il compito nonostante il continuo ripetersi e accumularsi dei tentativi falliti.
Il termine ‘individuo’ affiorò alla consapevolezza della società (occidentale) nel XVII secolo, agli albori dell’età moderna. Esso esprimeva un compito, non immediatamente intuibile dal nome datogli fin dall’inizio: il termine, di derivazione latina, implica in primo luogo e principalmente – come il greco a-tom – l’attributo dell’indivisibilità. Esso faceva dunque riferimento soltanto al fatto, in sé banale, che se si suddivide la totalità della popolazione umana in elementi costitutivi sempre più piccoli, tale operazione si dovrà arrestare quando si arriva al livello di una singola persona: l’individuo è infatti l’unità più piccola cui sia ancora possibile attribuire la qualità dell’‘umanità’, esattamente come l’atomo di ossigeno è l’unità più piccola dotata delle caratteristiche di quell’elemento chimico. In sé il nome non definiva l’unicità del suo titolare (gli atomi dello stesso elemento sono indistinguibili gli uni dagli altri). La caratteristica dell’‘unicità’, l’«essere diversi dagli altri» (l’ipséité di Paul Ricoeur) fu certamente aggiunto al campo semantico del termine come una sorta di ripensamento, a seguito dell’interpretazione e della riflessione sui contesti in cui i suoi usi sociali erano collocati e rimanevano chiusi.
Tali aggiunte sopraggiunsero in un secondo tempo, ma presero ben presto il sopravvento, colonizzando tutto lo spazio semantico del termine ed emarginando, se non addirittura espellendo totalmente, i significati preesistenti. Quando oggi si sente pronunciare la parola ‘individuo’ difficilmente si pensa all’‘indivisibilità’; al contrario, l’‘individuo’ (proprio come l’atomo della chimica fisica) fa riferimento a una struttura complessa ed eterogenea fatta di elementi altamente separabili, raccolti in unità precaria e fragile da una combinazione di attrazione e repulsione, di forze centripete e centrifughe, in un equilibrio dinamico, mobile e costantemente instabile. L’accento cade soprattutto sull’autocontenimento di quest’aggregato complesso, e sul compito di attenuare i continui scontri tra elementi eteronomi e introdurre una qualche armonia nella loro sconcertante varietà. E cade anche sulla necessità di realizzare tale compito dentro quell’aggregato, con gli strumenti disponibili al suo interno. ‘Individualità’ significa oggi, prima di qualsiasi altra cosa, autonomia della persona, dove la prima viene percepita come diritto e dovere della seconda. Prima di qualsiasi altra cosa, l’affermazione «sono un individuo» implica che io sono responsabile dei miei pregi e dei miei difetti e che è mio compito sviluppare quelli e rammaricarmi per questi, cercando di porvi rimedio.
In quanto compito, l’individualità è un prodotto finale della trasformazione societaria, camuffato da scoperta personale. Nella fase iniziale di tale trasformazione lo studente Karl Marx osservava che quando il sole tramonta le falene cercano la luce delle lampade, la cui attrazione cresce man mano che sul mondo esterno cala l’oscurità. L’ascesa dell’individualità è stata la spia del progressivo indebolimento – per disintegrazione o distruzione – della fitta rete di legami sociali che avviluppava strettamente la totalità delle attività della vita. Essa esprimeva il fatto che la comunità era sempre meno capace e/o interessata a regolare normativamente la vita dei suoi membri. Più esattamente, quell’ascesa segnalava che la comunità, non essendo più an sich (come avrebbe detto Hegel) o zuhanden (nei termini di Heidegger), aveva perso l’antica capacità di assicurare tale regolazione in maniera ordinaria, nei fatti e senza coinvolgere l’autocoscienza, e che la perdita di tale capacità trasformava esplicitamente il compito di modellare e coordinare le attività umane in un problema, in qualcosa su cui riflettere e di cui preoccuparsi, oggetto di scelta, decisione e sforzo finalizzato. Il numero dei modelli di routine quotidiana che restavano incontestati ed evidenti di per sé diminuiva sempre più; il mondo della vita quotidiana perdeva l’ovvietà e la ‘trasparenza’ di cui aveva goduto fino allora, finché i percorsi della vita erano stati privi d’incroci e non ancora irti di ostacoli da evitare, contrattare o rimuovere a forza dal proprio cammino.
Gli zatterieri che trasportano tronchi d’albero lungo il fiume seguono la corrente: non gli serve la bussola, a differenza dei marinai che non possono farne a meno, una volta preso il largo. Gli zatterieri si lasciano trasportare dal corso delle acque, assecondando i movimenti della propria imbarcazione con un colpo di pagaia di tanto in tanto, per seguire la corrente, e tenendola a debita distanza dagli scogli e dalle rapide, dalle secche e dagli scogli sulle rive. I marinai, invece, sarebbero perduti se la propria rotta fosse affidata esclusivamente ai capricci dei venti e delle correnti mutevoli. Essi non possono che farsi carico dei movimenti della barca: hanno bisogno di decidere dove andare, e perciò gli occorre una bussola che dica loro quando e da che parte andare per poterci arrivare.
L’idea dell’‘individuo’ autocostruito fu espressione di tale bisogno, allorché i moderni marinai succedettero agli zatterieri premoderni. La comunità era in fase di ripiegamento e il suo sistema immunitario, nato per evitare che essa venisse contaminata dai problemi, si trasformava a sua volta in un problema: non si poteva più restare sordi e ciechi di fronte alla scelta della direzione e alla necessità di tenere la rotta. Se un tempo le cose ‘andavano’ così, ora ‘andavano fatte’ così. La società – quella «comunità immaginata», subentrata al posto di quella che era invisibile nella propria stessa luce abbagliante, oppure di un contesto sociale che non richiedeva l’impiego dell’immaginazione al servizio dell’autoanalisi e non avrebbe potuto sopravvivere ad essa – assurgeva a nuova necessità (non scelta), in quanto diritto dell’uomo (conquistato a caro prezzo).
Diversamente dalla ‘comunità’ (una totalità cui fu dato quel nome a posteriori, nel momento stesso in cui un nuovo contesto col nome di ‘società’ lottava per riempire il vuoto normativo creato dalla sua ritirata), nella ‘società’ i nuovi poteri normativi si limitavano, in linea di massima, a regolare lo spazio sociale che si poteva abbracciare unicamente grazie all’immaginazione. Tale spazio si disinteressava della sfera delle relazioni interpersonali, il microspazio della prossimità e i rapporti de visu, in cui gli strumenti che si potevano adoperare con efficacia per l’interazione personale potevano ormai essere impiegati liberamente nell’attività di ‘socializzazione’: ossia nelle interazioni quotidiane fra esseri umani, nella definizione e nella revoca degli impegni personali, nella creazione e nello scioglimento di legami individuali e nella scelta della strategia per questi fini.
Nella sfera dei rapporti de visu l’individualità viene affermata e rinegoziata ogni giorno attraverso una interazione costante. Essere ‘individuo’ equivale ad accettare una responsabilità inalienabile per l’andamento e le conseguenze di tale interazione: responsabilità che non può essere assunta seriamente se gli attori non sono liberi di scegliere il modo di procedere. La ‘libera scelta’ può anche essere una finzione (come i sociologi hanno sostenuto instancabilmente fin dagli albori della loro scienza), ma la presunzione del diritto di libera scelta trasforma tale finzione nella realtà della Lebenswelt, in un «fatto sociale» in senso durkheimiano, ‘reale’ in quanto sostenuto dalla pressione schiacciante di sanzioni irresistibili: una pressione di cui non si può nemmeno concepire o desiderare l’assenza, e che tanto meno è possibile contrastare efficacemente o ignorare impunemente. Per quanto libera possa essere (o no) la scelta individuale, sicuramente il precetto di scegliere liberamente e di definire qualsiasi azione come esito di tale libertà non è a sua volta materia di scelta individuale. Nella società degli individui tutti noi siamo individui, ciascuno di noi lo è. Individui de jure, per legge: in base alla legge scritta, ma anche alle sue numerose varianti non scritte, ma non per questo meno forti: alla pressione – diffusa ma incessante, travolgente e irresistibile – dei «fatti sociali».
Il diritto e il dovere di libera scelta – premessa, tacita o/e esplicita, dell’individualità – non sono sufficienti a garantire che l’esercizio di quel diritto sia praticabile, e dunque che la prassi dell’individualità sia all’altezza dei modelli imposti da quel dovere. L’esercizio della libera scelta è quasi sempre fuori della portata di molti, uomini e donne, e per altri ancora lo è in determinate occasioni (più o meno numerose).
Jeremy Seabrook ha descritto in maniera molto efficace la condizione dei poveri globali dei nostri giorni, tanto spesso sfrattati dalla propria terra e costretti a cercare la sopravvivenza negli slum in rapida crescita della megalopoli più vicina:
La povertà globale è in fuga: non è stata cacciata dalla ricchezza, ma s...
Indice dei contenuti
- Introduzione. Vivere in un mondo liquido-moderno
- 1. L’individuo sotto assedio
- 2. Da martire a eroe, da eroe a celebrità
- 3. La cultura: ribelle, ingestibile
- 4. Rifugiarsi nel vaso di Pandora. Ovvero: paura, sicurezza «and the city»
- 5. Il consumatore nella società liquido-moderna
- 6. Imparare a camminare sulle sabbie mobili
- 7. Pensare in tempi oscuri (rileggendo Arendt e Adorno)
- Note