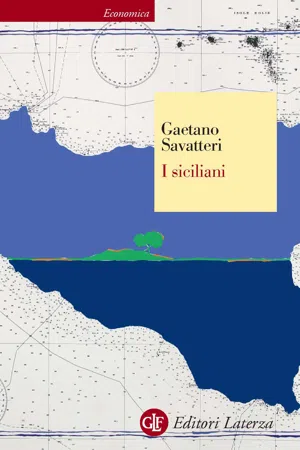Il potere e l’eresia
Chi è potente? Chi ha assai e chi non ha niente
Proverbio siciliano
«Tutto il Cassaro era affollato di gente che voleva vedere gli inquisiti, povera gente, la più parte delle province, ignorante e superstiziosa o epilettica e isterica. Altra folla gremiva il piano della cattedrale, si addensava sul Cassaro. Nei balconi e nelle finestre dei palazzi prospicienti sul piano altra folla sfolgoreggiava di sete di gioielli: era la nobiltà, la quale interveniva, come si esprimono i cronisti dell’epoca, ‘con gale le più esquisite, per celebrare il trionfo della fede’».
Il trionfo della fede, l’autodafé. Lo «spettacolo» messo in scena dalla Santa Inquisizione era di fiammeggiante sfarzo e miseria, iniquità e splendore: fiammeggiante, e non cade a caso il termine ché nel rogo si concludevano i riti, con i colpevoli di eresia o di stregoneria, già provati dalle torture che gli inquisitori avevano inflitto loro nelle segrete del carcere dello Steri, arsi vivi nel piano di Sant’Erasmo, nella barocca scenografia del golfo di Palermo chiuso da un lato all’altro dal monte Pellegrino e dall’Aspra: «Quando la processione giunse nel piano della cattedrale e salì sul palco, offrì all’occhio uno spettacolo imponente. Dall’alto della loggia, che pareva un trono, i tre inquisitori del regno signoreggiavano la folla e pareva davvero che nelle loro mani fosse il supremo potere, la somma autorità. Intorno a loro le fronti si chinavano per paura; lo stesso senato, che talvolta osava contrastare con l’autorità del viceré, si chinava sommesso dinanzi alla solenne e tremenda maestà di quel fosco tribunale».
Si è scelta una descrizione romanzesca, sia pure sostenuta da solidi documenti e cronache d’epoca, per restituire il clima delle cerimonie che periodicamente si celebravano a Palermo. Si è scelta la ricostruzione di Luigi Natoli, il romanziere d’appendice che con il nome di William Galt, agli inizi del Novecento, pubblicò a puntate sul «Giornale di Sicilia» numerosi feuilleton ispirati a personaggi e storie della Sicilia secentesca. Romanzoni densi di duelli, tradimenti, amori, misteri, come quei Beati Paoli da cui è tratto il racconto di questo autodafé: «Erano circa le ventidue ore e mezza, e cominciavano le esecuzioni. I rei, posti sopra carrette, una mitra in capo, le spalle nude, le braccia legate dietro le reni, erano flagellati dal boia e dai suoi aiutanti. La carretta si fermava davanti all’arcivescovado, a piazza dei Bologna, ai quattro Canti, dinanzi la Vicaria, dinanzi al palazzo del Sant’Offizio ove i condannati erano deposti. A ogni fermata squillava la tromba e il boia frustava. Una folla di curiosi, la maggior parte giovanetti, nei quali lo spettacolo destava gli istinti più bestiali, la seguiva. Del fango, dei torsoli, delle immondizie volavano sul dorso, sui volti di quei disgraziati, tra le ingiurie, gli sghignazzamenti del popolaccio, che prendeva di mira specialmente le vecchie condannate per sortilegio e fatture».
Ma adottare la ricostruzione romanzata di Natoli, cioè di uno scrittore prolifico e inventivo, dal carattere fortemente popolare, ha anche un’altra ragione: nel 1923, sempre con il suo pseudonimo, firmò il romanzo a puntate Fra Diego La Matina, resuscitando la storia di quel frate agostiniano di Racalmuto che il 4 aprile del 1657, mentre veniva interrogato (e, si può presumere, torturato) nel carcere dello Steri, uccise, colpendolo con i ferri che gli serravano i polsi, il suo inquisitore, monsignor Giovanni Lopez Cisneros. Evento unico e irripetuto di ribellione, menzionato ellitticamente da alcuni storici e cronisti, dal quale Natoli fece rampollare un romanzo carico di avventurose vicende, di passioni e di complicazioni in gran parte frutto della sua fantasia, nel quale Diego La Matina non eretico sembrava, ma un brigante sfortunato.
Quarant’anni dopo il romanzo di Natoli, Leonardo Sciascia scrive Morte dell’inquisitore, un libro vibrante e appassionato, aperto su un interrogativo: di quale eresia era accusato fra’ Diego La Matina? (E dirà Sciascia: «Questo breve saggio o libretto su un personaggio quasi dimenticato della storia siciliana è la cosa che più mi è cara tra quelle che ho scritto e l’unica che rileggo e su cui ancora mi arrovello... un libro incompiuto, da riscrivere non appena scoperto un nuovo documento, una nuova rivelazione, un indizio...».) Sciascia addiviene a una conclusione, provvisoria e suggestiva: l’eresia di fra’ Diego La Matina – arrestato, assolto, di nuovo imprigionato, evaso, ancora catturato e, infine, dopo l’uccisione dell’inquisitore, bruciato vivo – fu di natura sociale: «Un’azione che fosse stata al tempo stesso eresia e contravvenzione alle leggi ordinarie. Per esempio: un’idea od opinione contro la proprietà o contro certe forme di proprietà». Un’eresia «fondata su proposizioni evangeliche la cui esegesi doveva allora apparire pericolosa e sovvertitrice ma difficilmente controvertibile, difficilmente condannabile».
L’eretico fra’ Diego La Matina, messo alla corda, straziato, insultato, troverà la forza non solo di ribellarsi ma perfino di tener testa ai teologi che, tra i supplizi, cercano di portarlo a retta strada, quella della ragione e del potere del Sant’Uffizio. È uomo di «tenace concetto», lo accusa il cronista che riporta la sua vicenda, faziosamente schierato con la Santa Inquisizione: ma nel voler restituire prova della cocciutaggine e ostinazione dell’eretico di Racalmuto, finisce per riconoscerne la saldezza delle idee, il coraggio di sostenerle, la caparbietà nel perseguirle. Fino alla morte.
Stabilire se la Sicilia sia stata terra di eretici è arbitrario, certo fu terra di molte esecuzioni e di numerosi autodafé. E dal numero dei condannati si deduce che molti furono gli eretici, almeno fino al 1782, quando il Sant’Uffizio fu chiuso per ordine del viceré Caracciolo, affidati colpevolmente alle fiamme gli archivi dello Steri, quasi per una paradossale regola di contrappasso volta a cancellare nel fuoco le nefandezze di un tribunale che, ultimo in Europa, aveva continuato a funzionare, a infliggere pene, a bruciare condannati. E per avere debole idea di quel che significasse vivere dentro quelle celle, sottoposti alle sevizie minuziosamente regolate dai carnefici, basta rileggere una delle poesie graffite e lasciate su un muro da uno dei detenuti, laboriosamente ricostruita da Giuseppe Pitrè nel 1906:
Cui trasi in chista orrenda sipultura
vidi rignari la [gran] crudeltati
unni sta scrittu alli segreti mura:
nisciti di spiranza vui chi ntrati;
chà nun si sapi s’agghiorna o si scura,
sulu si senti ca si chianci e pati
pirchì non si sa mai si veni l’hura
di la desiderata libertati.
Una voce dall’abisso. Un urlo disperato che rimbalza attraverso i secoli, dal chiuso di una segreta, dal luogo del supplizio, dall’epicentro dell’umiliazione della dignità. «Non è un uomo che parla, è un cuore che geme, un’anima che grida dalla tomba nella quale il suo corpo è stato sepolto vivo; un’anima straziata», commenta Pitrè, attribuendo i versi al palermitano Simone Rao, marchese della Ferla, poeta e prelato, nato nel 1609 e incarcerato per il sospetto di aver partecipato a una congiura.
Ma se alto era il numero dei «penitenziati» e delle «penitenziate», cioè di detenuti e detenute; se inesauribili erano le pene, numerosi i condannati al rogo, se ne può arguire che molteplici erano le eresie e le devianze che il Sant’Uffizio si trovava santamente a redarguire, a suprema conferma che nella Sicilia della Controriforma – ma anche prima, e dopo – ferreo era il sistema di potere dominante. Perché le eresie possono germogliare soltanto là dove vi sia qualcuno pronto a estirparle, come gramigna infesta: quanto più è vasto l’apparato della norma e della repressione, tanto più innumerevoli sono i comportamenti trasgressivi.
Siciliani le vittime, siciliani i carnefici. In una morsa che avvinghia da secoli l’isola, dentro cui ciascuno sceglie o trova la parte assegnata. Ad alcuni tocca il ruolo degli eretici, ad altri tocca la parte degli inquisitori, dei potenti, degli uomini che, per dirla con Natoli, «signoreggiano sulla folla». Antico rapporto col potere quello dei siciliani: un potere che, svincolato dal senso dello Stato, dal rispetto delle istituzioni, dalla funzione pubblica, può risolversi anche in un astratto sofisma, nutrito di concreti interessi, ma di sfuggente definizione.
Come già si è detto, nel Cinquecento il messinese Scipio De Castro, nei suoi Avvertimenti a Marco Antonio Colonna quando andò viceré in Sicilia, affermava che i siciliani «sono sommamente timidi e sommamente temerari. Timidi quando trattano i loro affari, poiché sono molto attaccati ai propri interessi e per portarli a buon fine si trasformano come tanti Protei, si sottomettono a chiunque può agevolarli e diventano a tal punto servili che sembrano nati appunto per servire. Ma sono d’incredibile temerarietà quando maneggiano la cosa pubblica, e allora agiscono in tutt’altro modo...». La temerarietà di cui parla De Castro oggi può avere un’identificazione più penalmente individuabile: può chiamarsi, di volta in volta, peculato o concussione o corruzione.
La perseguibilità giudiziaria non serve però a individuare l’origine di un virus del potere che si svela in alcuni abitanti dell’isola. Forse dagli spagnoli – o ancor prima dagli arabi – promana l’arte di questa suggestione, un’arte orientata a rivestire le forme del potere di parole e atteggiamenti che ne sostanziano l’essenza, ne incarnano la ragione, ne racchiudono il mistero che pone alcuni sopra e altri sotto.
Il principe che creava mostri
Sarebbe fin troppo scontato far posto a Ferdinando Francesco II Gravina Cruylas e Alliata nel voluminoso album dei matti, rassegna di stranezze e corde pazze che molti hanno già sfogliato. Carico di titoli e cognomi, il principe di Palagonia, grande di Sicilia, rilascia di sé scarne notizie biografiche, malamente deformate dall’ampia novellistica germogliata attorno alla sua unica e indecifrabile opera: la villa dei mostri di Bagheria. Statue deformi, sedie inservibili, specchi infiniti popolavano la residenza alle porte di Palermo. Cantiere aperto di incongruenze, aborti, incubi, la villa proliferava di figure inconcepibili. Inconcepibili almeno per quel secolo dei lumi nel quale si trovò a vivere il principe di Palagonia. Nel loro Grand Tour italiano, artisti e poeti europei che si spinsero fino in Sicilia non riuscirono a mancare all’appuntamento con questo giardino degli orrori. Se ne ritrassero, alcuni, atterriti e sconcertati. Come Johann Wolfgang von Goethe, che il 9 aprile 1787 vi andò in visita, provando un fascino carico di ribrezzo. Pochi giorni dopo, a Palermo, intravide il principe. Ne lasciò indimenticabile ritratto nel suo diario di viaggio.
Un mio desiderio venne esaudito questa sera ed in modo tutto particolare. Mi trovavo sul marciapiede della strada principale e stavo scherzando con il negoziante di cui vi ho già parlato. Improvvisamente un corriere alto, ben vestito si avanza verso di me tenendo in mano un piatto d’argento sul quale sono collocate parecchie monete di rame ed alcune d’argento. Poiché non mi era chiaro di che si trattasse, mi strinsi nelle spalle accennando con il capo, come si usa qui per dire di no a richieste ed a domande che non si comprendono o che non si vogliono comprendere. Si era allontanato con la medesima celerità con la quale si era avvicinato ed ora notai, sul lato opposto della strada, un altro come lui, intento alla medesima occupazione.
Domandai al mio negoziante di che si trattasse ed egli, con un gesto prudente ed ammiccando, mi indicò un signore alto e magro che, vestito come per andare a corte, avanzava in mezzo alla strada, corretto e tranquillo nonostante la lordura. Era in parrucca e incipriato, il cappello sotto il braccio, in abito di seta, la spada al fianco, ed un elegante paio di scarpe ornate con una fibbia con pietre preziose. Il vecchio avanzava così, calmo e solenne, tutti gli occhi si erano rivolti verso di lui.
«Quello è il principe di Palagonia» disse il commerciante «il quale ogni tanto va per le vie della città e raccoglie danaro per riscattare schiavi prigionieri in Barberia. In verità la colletta non frutta molto, ma la questione non viene dimenticata e, a volte, quelli che in vita se ne astennero, morendo destinano a questo scopo somme importanti. Il principe è da molti anni presidente di questa associazione ed ha fatto molto bene».
Risposi: «Invece di spendere grandi somme per le stravaganze della sua villa, le avrebbe potute destinare a questo scopo. Nessun principe al mondo avrebbe fatto di più».
Il mercante mi rispose: «Ma sono tutti così! Le nostre stravaganze ce le paghiamo volentieri da noi; per le nostre virtù, il danaro lo devono dare gli altri».
Quando Goethe lo incontra, il principe ha quasi cinquantasei anni e gli resta appena un anno di vita. Era nato il 25 novembre 1722. Suo padre si chiamava Ignazio Sebastiano Gravina e Lucchese. Sua madre era donna Margherita Alliata, figlia a sua volta del principe di Villafranca. È noiosa e complessa la genealogia araldica del principe di Palagonia, irta di antenati normanni e pisani e longobardi. Così come altrettanto labirintica è la mappa di fratelli, fratellastri, sorelle di secondo letto, ingarbugliata da matrimoni costruiti per rinsaldare dinastie e perpetuare patrimoni. Non a caso, Ferdinando Francesco Gravina, saggiamente – e questa saggezza stride con il resto – accresce la propria eredità sposando il 16 marzo del 1747 Maria Gioachina Gaetani e Buglio, erede del duca Aloisio Gaetani, conte di Racalmuto. Ai suoi feudi e titoli altri così ne aggiunge: il principato di Lercara, il marchesato di Bifora. Non gli mancavano successi e onori: grande di Spagna di prima classe, cavaliere dell’Ordine di san Gennaro, presidente della Compagnia dei Bianchi, ciambellano del re di Napoli, Sicilia e Spagna.
Insomma, non doveva essere così demente se riusciva a collezionare prebende, ricchezza e potere. D’altra parte, tranne la descrizione fatta da Goethe, quasi nulla si sa di lui: del suo carattere, dei suoi comportamenti. Il principe di Palagonia, in realtà, ha finito per identificarsi con la sua villa dei mostri, un’opera alla quale dedicò il suo tempo, dissipandovi gran parte del patrimonio familiare. Un’opera che non si concluse mai, se non con la sua morte. E subito dopo, dai suoi discendenti, statue e mostri vennero smantellati, con sistematica devastazione, quasi a voler cancellare quella assurda creazione, a rimuovere le testimonianze di quella follia. Qualcosa oggi ancora resta, ma come un disegno mal cancellato.
Il primo impianto della villa risaliva al 1715, messo in piedi dal nonno di Gravina. Risentiva ancora delle influenze barocche, nel disegno delle scalinate d’accesso, in una certa esuberanza architettonica che pervadeva tutte le residenze estive, le «casene», che erigevano a gara i nobili siciliani, a Bagheria o nella piana dei Colli; ennesima competizione di fasto e dispendio che celebrava il morbo nascosto di un irreversibile declino. Ma è con il principe di Palagonia che muri, terrazze, stanze si affollano di presenze inquietanti, di surreali creature pietrificate.
Perché tutto questo? Giovanni Macchia, in un suo intenso saggio del 1978, finisce per non dare, o per non voler dare, risposte. «L’esistenza del principe, così come oggi la vediamo, da tanto lontano, con gli occhi della nostra fantasia, fu un’esistenza enigmatica. E tale deve rimanere...», spiegava a commento del suo libro. Un saggio che, per superare gli ostacoli della ragione e della critica, si conclude con un immaginario dialogo tra il principe di Palagonia e un conte veneziano, durante il quale Ferdinando Francesco Gravina assume i toni – ma più straniti e stralunati – del principe di Salina quando tenta di spiegare la Sicilia all’esterrefatto Chevalley. Il principe di Palagonia, con le parole di Macchia, spiega se stesso, il suo tempo: «Qual è il nostro tempo? In che cosa il nostro tempo è diverso dagli altri ‘tempi’: come se ne esistessero tanti, tanti...? Certo l’impressione comune è che il mondo cammini. Mutano le istituzioni, i governi, gli usi, le abitudini, il volto delle nostre città, le uniformi dei soldati, il disegno delle nostre carrozze e le nostre parrucche, il fermaglio delle nostre scarpine, i campanili delle nostre chiese: cose grandi e cose piccine. Eppure in fondo a queste cose, nella profondissima realtà delle nostre giornate, tutto resta immoto. In questo ambiente così mio, così siciliano, così moderno, diciamo (e non per mia colpa), io che cosa ho fatto? Non ho fatto che ricostruire la prima casa di Adamo: non nel paradiso, ma sulla terra. Non ho fatto che ricostruire un’immensa arca di Noè tutta di pietre e tufo, in attesa del diavolo. [...] E il diluvio un giorno o l’altro verrà!».
Archiviare la villa dei mostri di Bagheria nell’affollato scaffale della follia siciliana, significa ridurre a capriccio della mente una realtà che ha fatto crescere attorno a sé una vasta letteratura. Forse c’è un’altra interpretazione. Possibile, verosimile: la presunta follia di Ferdinando Francesco Gravina è un’eresia dissimulata. Gli anni in cui egli si dedica all’opera immane e infinita di dare concretezza all’orrore sono gli anni di Diderot e di Voltaire, gli anni dell’Enciclopedia, in altre parole la stagione in cui l’uomo cerca di imprimere il lume della ragione sul caos del mondo. Lontano dalla Francia illuminista, nella...