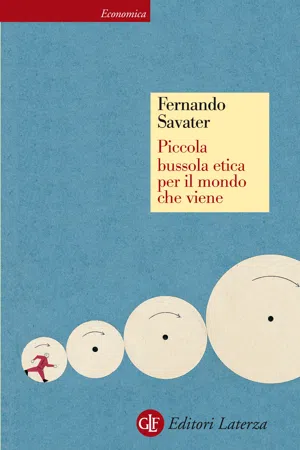L’educazione
Chi studia o lavora in università sa che le nuove tecnologie hanno rivoluzionato soprattutto le attività di documentazione, permettendo di reperire su Internet bibliografie relative a qualunque argomento. Naturalmente le nuove tecnologie hanno rivoluzionato anche la pratica didattica, con l’uso di schermi al posto delle lavagne o con la possibilità di tenere lezioni a distanza. Ma il vero problema, oggi, non sono tanto gli strumenti, quanto la difficoltà di mantenere vivo lo spirito di ricerca che è l’obiettivo primario della formazione accademica.
Di sicuro, sono i bambini a subire le maggiori conseguenze di tale trasformazione. Un tempo si andava a scuola per imparare nozioni su materie – geografia, grammatica, storia, letteratura, musica – che a casa nessuno conosceva. Si può dire anzi che tutte le conoscenze arrivavano dalla scuola e che l’insegnamento consisteva proprio in quello: nel trasmettere ai bambini informazioni a loro sconosciute. Chi iniziava la scuola ignorava la verità su diversi argomenti – morte, sesso, ambizione, potere – e questa gli veniva rivelata poco a poco, anno dopo anno.
Oggi, invece, grazie alla tv e a Internet, la priorità della scuola non è più quella di informare, bensì quella di orientare l’alunno nel labirinto di informazioni in cui rischia di perdersi. In altre parole, chi educa non può più limitarsi a trasmettere conoscenze, ma deve svolgere un lavoro di orientamento. Da questo punto di vista, l’educatore diventa una sorta di bussola nel ginepraio di informazioni di cui siamo prigionieri, un ginepraio in cui è difficile distinguere la verità dalla menzogna e la serietà dalla frivolezza. I bambini di oggi vanno educati a distinguere la qualità delle informazioni a cui hanno accesso, perché Internet – non c’è alternativa possibile, indietro non si torna – è destinato a invadere sempre più le loro vite e non ha senso cercare di proteggerli dal loro habitat e convincerli ad ascoltare i consigli della nonna. Dobbiamo insomma sforzarci per sfruttare al meglio questi strumenti in funzione educativa e nell’interesse del cittadino.
Un’amica mi raccontava recentemente di aver sentito dire dalla figlia: «Mamma, quando sarò grande non voglio avere figli». Sulle prime, la mia amica è rimasta sorpresa per questa decisione così repentina e tassativa, ma poi ha scoperto che la figlia aveva appena visto un parto in televisione e aveva deciso che avrebbe potuto perfettamente fare a meno di quell’esperienza, per quanto interessante potesse essere. Tanti anni fa certe cose te le spiegavano i genitori e gli insegnanti a tempo debito, e un aneddoto del genere sarebbe stato impensabile.
Ma se la bambina, dopo aver visto il video, rifiuta di diventare mamma, forse sta semplicemente cambiando punto di vista. In questo caso non dovremmo proteggerla?
Quello che sta cambiando è il ruolo dell’educatore, che non può più andare a raccontare alla bambina la storia dei figli portati dalla cicogna ma deve trovare un altro modo per affrontare l’argomento. L’educatore non può negare la realtà, e la realtà è che esiste un flusso di informazioni costante che mette insieme in un tutto indistinto elementi veri ed elementi falsi, elementi necessari ed elementi accessori, elementi rilevanti ed elementi irrilevanti. Quello che dobbiamo fare è imparare e insegnar loro a navigare in questo mare. Non si tratta più di scoprire cose, ma di dare una gerarchia e un ordine alle informazioni che trovano.
Si dice che cercare informazioni su Internet sia un po’ come fare zapping col telecomando. Concentrarsi diventerà sempre più difficile?
Quando ancora insegnavo in università, non si percepiva questo presunto problema di concentrazione. Alcuni docenti avevano di questi timori quando vedevano un alunno usare Internet, ma erano impressioni soggettive. In compenso si cominciava già ad affermare la tendenza a somministrare esami tipo test a scapito di prove che privilegiassero la capacità di argomentare, ragionare, disquisire...
Tale cambiamento è un riflesso di ciò che accade all’interno della società. Martha Nussbaum, che di recente ha ricevuto il premio Príncipe de Asturias, insiste molto sul fatto che abbiamo smesso di utilizzare, nell’insegnamento, il metodo socratico di implicazione personale: un metodo che si basa sull’argomentazione. Secondo questo metodo, non importa che gli alunni sappiano che Aristotele è nato a Stagira; importa sapere che cosa pensano delle riflessioni di Aristotele e quali riflessioni suscitano in loro.
Man mano che PowerPoint sostituisce l’argomentazione tradizionale, questo modello si svuota di contenuto. Lo stesso accadrà il giorno in cui proporremo un esame in formato Twitter, in cui tutto potrà essere riassunto in una frase o in uno slogan. Quando una persona si abitua a esprimersi in centoquaranta caratteri, quando si abitua all’insolenza e all’insulto, perde la capacità di argomentazione, che rappresenta il nucleo stesso del pensiero.
Lo scrittore e filosofo rumeno Emil Cioran scrisse una volta che gli sarebbe piaciuto essersi formato in una società dominata dall’aforisma e dall’epitaffio. Bene: oggi la gente comunica e si alimenta intellettualmente a base di epitaffi. E io credo che sarebbe bene che chi educa opponesse una qualche resistenza e continuasse a educare gli alunni all’argomentazione.
Quanto alla perdita d’attenzione, non credo che sia un problema esclusivo dei bambini e che debba essere affrontato solo dagli educatori: con la quantità e la varietà di richiami e stimoli a cui siamo esposti, la difficoltà di prestare attenzione al prossimo sta diventando il problema centrale della vita moderna. Lo possiamo osservare ogni giorno. Se una volta invitavi a pranzo qualcuno che nel bel mezzo del pasto si metteva a leggere il giornale, ti alzavi e te ne andavi, e ciò se prima non gli avevi rotto una bottiglia in testa. Oggi, invece, se ti metti a protestare perché un tuo commensale presta più attenzione al cellulare che alla conversazione, rischi di passare per un tipo intollerante, pedante e rompiscatole.
Negli Stati Uniti, l’associazione che riunisce le compagnie di distribuzione cinematografica sta valutando la possibilità di permettere l’uso dei telefoni cellulari nelle sale di New York, che stanno perdendo il pubblico giovanile. I ragazzi non vanno più al cinema se proibisci loro di tenere il cellulare acceso: impossibile obbligarli a rinunciare al telefonino per un’ora o due. È una battaglia persa. Però viene da chiedersi: come faranno a mantenere la concentrazione sul film? Come faranno a concentrarsi in generale?
Il mutamento è più rilevante di quanto non appaia, perché tutte le cose importanti nella vita richiedono attenzione: la conoscenza, l’amore... Anche per cambiare la realtà, la politica, la società è necessario concentrarsi. Senza un’attenzione adeguata non c’è progresso, non c’è civilizzazione, non c’è sviluppo umano.
La cosa davvero grave, che si ripercuote su molti aspetti della nostra vita individuale e sociale, è questa idea di attenzione fluttuante, sospesa, costantemente minacciata dal minimo refolo di vento. Ed è proprio l’attenzione che bisogna provare a recuperare, visto che stiamo parlando di educazione e di istruzione. A cominciare dall’attenzione nei confronti dell’insegnante, il quale deve recuperare la propria centralità senza cedere né concedere troppo. Gli alunni devono riacquistare la capacità di concentrarsi sulle cose per periodi di tempo prolungati e imparare che in alcuni momenti Internet e telefonino possono diventare armi di distrazione di massa.
In questo senso, la principale sfida educativa della modernità sta nel cercare di recuperare l’attenzione degli alunni.
Internet favorisce molto la specializzazione. Una volta, se volevi specializzarti in qualcosa, dovevi andare in biblioteca, creare un circolo di appassionati. Adesso si può fare tutto su Internet tramite forum e siti ad hoc. Secondo lei, specializzarsi senza uscire di casa può diventare un problema quando si tratta di affrontare questioni generali e di interesse universale come quelle proposte dalla filosofia e dall’etica?
In un certo senso la specializzazione è una buona cosa. A me, ad esempio, piacciono molto le corse dei cavalli, e su Internet ho trovato siti e forum a tema dove si riuniscono tutti gli appassionati come me, che possono passare giornate intere a contarsela su argomenti di cui al resto dell’umanità non importa niente di niente.
Il problema di Internet è che ha cancellato la cultura dello sforzo. Una volta, per arrivare al mondo della specializzazione o per entrare a far parte di un gruppo di appassionati, dovevi sforzarti. Quando penso a queste cose, mi viene sempre in mente un amico musicista che vive in Germania e che su Internet è capace di trovare qualunque tipo di partitura. Quest’amico mi ha raccontato che un tempo gli appassionati di musica andavano in archivio muniti di carta pentagrammata e copiavano loro stessi la partitura. Era ovviamente un sistema molto più costoso e molto più scomodo, ma aveva un suo valore, perché al di là della difficoltà dell’operazione, che salta immediatamente agli occhi, costituiva un fattore di trasformazione personale. Copiare non era solo la fatica di copiare, ma anche l’esperienza di far propria la partitura tramite lo sforzo. Uno potrebbe dire: «Che stupidi dovevano essere questi eruditi che ci impiegavano un pomeriggio a fare le stesse cose che io faccio schiacciando un semplice tasto». E tuttavia l’unica conoscenza che mette buone radici è quella che passa attraverso l’esperienza e trasforma la persona. Quella prodotta da contenuti, canzoni o libri scaricati e infilati in una borsa ce l’hai lì a disposizione, ma non ti tocca, non ti trasforma.
Questo è il lato negativo di un mutamento nel modo di ottenere informazioni che interessa tutti noi e da cui tutti noi abbiamo tratto beneficio. Se mentre scrivo un articolo non mi ricordo la data della battaglia di Waterloo, ovviamente non ho più bisogno di alzarmi per andare a cercare sull’enciclopedia. Guardo su Wikipedia e stop. Queste scorciatoie le prendiamo tutti e sono molto utili. Ma una cosa è se lo fa un adulto con una buona base di conoscenze frutto di studio oppure se lo fa un alunno esperto; un’altra è se a prendere la scorciatoia è uno che non conosce niente di niente. Il pericolo è che qualcuno si convinca di poter sostituire lo sforzo e l’esperienza con dati ottenuti in modo meccanico. Per dire, il fatto che gli apparecchi elettronici consentano di eseguire calcoli piuttosto complicati non toglie che sia cosa buona conoscere le quattro operazioni. E questo non solo per evitare il rischio di essere ingannati, ma anche perché imparare a calcolare (ed esercitarsi a farlo) favorisce lo sviluppo mentale dell’individuo. E te lo dice uno che da giovane era un pessimo studente di matematica e che ha sempre pensato che la calcolatrice fosse una specie di vendetta per tutti quegli sforzi.
Adesso si può dire che i bambini nascano già con la calcolatrice incorporata, ma per quanto buona sia la macchinetta, se non fossero capaci di fare le addizioni o le sottrazioni, ne ricaveremmo l’impressione che qualcosa – un’abilità elementare – è andato perduto, che saper fare le cose da sé, sapere come si fanno e perché si fanno in un certo modo costituiscono già di per sé conoscenze importanti per una persona.
Qualcosa di simile accade con la specializzazione. Specializzarsi è diventato più facile? Benissimo. Ma se questo significa perdere la dimensione della ricerca e dell’avventura personale, allora non va più bene per nulla.
In quali altri aspetti Internet e la televisione hanno cambiato il ruolo dell’educatore?
In questo cambio di scenario anche l’educatore deve domandarsi che significato possono avere termini come solidarietà o pietà. Ogni giorno vediamo accadere disgrazie in luoghi remoti, che grazie allo schermo sentiamo vicinissime. Come reagire, di fronte a queste tragedie? Un tempo certe notizie interessavano solo le persone che vivevano vicino alle vittime di un dramma. Oggi, invece, la sfida consiste nel praticare pietà e solidarietà verso esseri che non sono né nostri vicini né nostri compatrioti, ed è una sfida che l’educatore non può ignorare.
Non avrebbe senso ribellarsi contro questa situazione. L’infanzia è una fase deliziosa ma transitoria: i bambini di sessant’anni non possono più essere considerati bambini, ma persone affette da disturbi mentali. I bambini non si stancano di fare domande, sono i primi filosofi, non accettano l’ignoranza, vogliono liberarsene quanto prima. È rarissimo che un bambino non voglia ascoltare dei racconti, che non voglia sapere, che si tappi le orecchie quando parlano i grandi: nessuno vuole rimanere bambino per sempre. Dunque, l’educatore non può limitarsi a mettere una benda sugli occhi del bambino o a spegnere il televisore. Al contrario, deve insegnargli a consumare la giusta dose d’informazione e a distinguere le notizie vere da quelle false e dannose.
Il problema è che ci stanno inculcando il criterio con cui dobbiamo pensare. Invece di insegnarci a pensare da soli, ci dicono come dovremmo pensare secondo loro. A me preoccupa il fatto che le prossime generazioni avranno vita ancora più dura, forse non avranno neppure la possibilità di imparare a pensare. Di questo passo, ai bambini del futuro diranno quello che devono fare, quello che devono essere, quale aspetto fisico devono avere per essere accettati dalla società. Anche i valori che ci hanno trasmesso i nostri genitori rischiano di estinguersi.
Se volgi lo sguardo al passato, in qualunque epoca troverai sempre le solite lamentele. Nel 2012, ad esempio, abbiamo celebrato il...