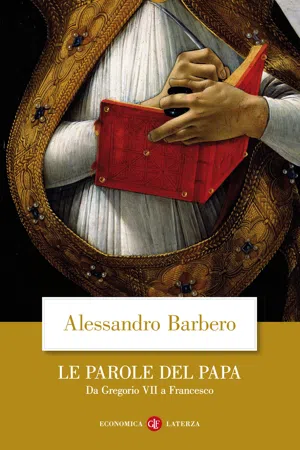1
I papi del Medioevo e il dominio del mondo
1 Gregorio VII e Enrico IV (1081)
Il nostro viaggio comincia nell’anno Mille, o per essere più precisi nell’XI secolo: quando, cioè, il vescovo di Roma respinge decisamente quella subordinazione al potere politico che, sia pure con oscillazioni teoriche, aveva caratterizzato la Chiesa del primo millennio, e comincia a rivendicare non solo l’autorità suprema su tutti i vescovi del mondo, ma anche una concreta supremazia sui titolari del potere politico, compreso il più importante di tutti, l’imperatore. La rivendicazione della supremazia non soltanto onorifica, ma politica e amministrativa di Roma sulle altre diocesi porterà alla rottura con le Chiese orientali, in particolare quella greca: una rottura che non si è ricomposta neanche oggi, benché l’ostilità militante abbia lasciato il posto a generiche dichiarazioni di fratellanza. La pretesa di dare ordini ai sovrani, e di essere puntualmente obbediti, si tradurrà in un acutissimo conflitto col potere imperiale, che oggi è relegato nei manuali di storia, nel capitolo dedicato alla lotta per le investiture, ma che all’epoca, come direbbe papa Bergoglio, armó un lío memorabile. Lo scontro fra Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV aprirà la strada a oltre due secoli – fino all’umiliazione di Bonifacio VIII ad opera di Filippo il Bello re di Francia – durante i quali il papato medievale si comporterà effettivamente come il detentore della direzione non solo spirituale, ma politica dell’intero Occidente.
È evidente che i papi di quest’epoca erano enormemente sicuri di sé: persuasi che Dio aveva conferito loro l’autorità suprema sul mondo e che imperatori e re dovevano obbedire agli ordini di Roma. Ma poiché era una novità, i papi del Medioevo si sentivano in dovere di dimostrarla. Uno degli argomenti impiegati a questo scopo era destinato a produrre alla lunga conseguenze imprevedute sulla cultura politica dell’Europa. Esso consisteva nello svilire l’origine e la natura del potere monarchico, che per consuetudine, fin dal tempo di Costantino, i cristiani avevano per lo più considerato di origine divina. In totale contrasto con questa tradizione venerabile e rassicurante, ai papi più impegnati nello scontro mortale con l’impero capitava di avventurarsi in dichiarazioni di sfiducia nei detentori del potere terreno che non sarebbero sfigurate sotto la penna di Marx o di Proudhon. La spregiudicatezza è in generale una caratteristica del linguaggio medievale, poco succubo dei conformismi e felicemente libero da ipocrisie, e dunque non stupisce ritrovarla anche nelle parole dei papi. Così Gregorio VII, nel pieno dello scontro con Enrico IV, scriveva nel 1081 al vescovo Ermanno di Metz, per spiegargli come fosse ovvio che lui, il papa, aveva tutto il diritto di scomunicare l’imperatore:
Chi non conosce la voce del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che nel Vangelo dice: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa, e a te darò le chiavi del regno dei cieli; e tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato anche in cielo, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche nei cieli»? Forse che i re qui sono eccettuati, o magari non fanno parte del gregge che il figlio di Dio ha affidato a san Pietro?
Anche i re, dunque, fanno parte del gregge e debbono accettare la guida del pastore. Ma la perorazione di Gregorio VII prosegue in una direzione ancora più esplosiva. Da dove proviene, si chiede infatti il papa, quella dignità imperiale e regia di cui tanto si vanta Enrico IV? La Chiesa romana è stata fondata dal figlio di Dio, ma chi ha fondato l’impero, se andiamo a vedere, sono stati gli antichi Romani, pagani e destinati alla dannazione. E, dunque, fra le due istituzioni non c’è partita.
Una dignità che è stata inventata dai laici, per di più ignoranti di Dio, non deve forse essere soggetta a quella dignità che la provvidenza di Dio onnipotente ha trovato a onore di Dio stesso e ha donato misericordiosamente al mondo? Il cui figlio, come è senza alcun dubbio Dio e uomo, così pure è da considerare sommo sacerdote, capo di tutti i sacerdoti, seduto alla destra del Padre, e sempre pronto a intercedere per noi; lui che ha disprezzato il regno di questo mondo, di cui si inorgogliscono i figli del secolo, ed è venuto di sua libera scelta al sacerdozio della Croce?
Il regno, dunque, è cosa terrena e spregevole, mentre la Chiesa siede alla destra di Dio. Ma Gregorio VII si spinge anche oltre, e si chiede, in linea con un interrogativo che ritorna frequentemente nel pensiero medievale, com’è stato possibile che gli uomini, creati uguali, abbiano dato vita a una società così gerarchica, conferendo tutto il potere ai principi. E qui gli interrogativi retorici del pontefice assumono una cadenza veramente rivoluzionaria:
Chi non sa che i re e i duchi hanno avuto origine da quelli che, ignorando Dio, con la superbia, le rapine, la perfidia, gli omicidi, alla fine con tutti i delitti, spinti dal principe di questo mondo, il diavolo, hanno preteso di dominare i loro pari, gli uomini, con cieca avidità e intollerabile presunzione?
Non solo la proprietà, insomma, ma anche il potere è un furto. L’esistenza stessa dell’imperatore, dei re e dei loro baroni testimonia la degradazione in cui è scivolata l’umanità; le loro corone non vengono da Dio, ma dal diavolo; il loro potere e i loro privilegi sono un insulto ai loro fratelli, gli uomini; e solo accogliendo umilmente gli ordini della Chiesa essi possono sperare di riscattare l’origine infernale del loro potere.
2. Gregorio IX e Federico II (1239)
Una volta dimostrato che tutti dovevano obbedire al papa, chi non lo faceva, ovviamente, era un eretico, e contro di lui si mobilitavano tutte le risorse di una sontuosa retorica biblica. Ne fu vittima, forse più di chiunque altro, l’imperatore Federico II di Svevia: che i suoi contemporanei chiamarono dapprima, con speranza, «il ragazzo del Sud» (puer Apuliae) e poi, con timore reverenziale, stupor mundi, ma nei cui confronti i papi finirono per sviluppare una progressiva insofferenza. Un papa, Innocenzo III, l’aveva allevato, persuaso che questo giovanissimo re di Sicilia sarebbe stato un riconoscente alleato; un altro papa, Onorio III, aveva accettato di incoronarlo imperatore, in cambio della promessa di partire per la crociata; un terzo papa, Gregorio IX, lo scomunicò per costringerlo a mantenere la promessa, poi accettò di perdonarlo, ma finalmente dovette concludere che il ragazzo promettente si era trasformato in un avversario implacabile dell’egemonia papale, e lo scomunicò di nuovo nel 1239.
La lettera in cui il papa annunciava la sua decisione venne inviata in copia a tutti i sovrani e i vescovi del mondo cristiano: dimostrazione impressionante della capacità di lavoro della cancelleria pontificia. Cominciava così:
È salita dal mare una bestia piena di parole di bestemmia: infierisce coi piedi dell’orso e la bocca del leone, ha le altre membra come il leopardo e apre la bocca per bestemmiare il nome di Dio.
È la bestia dell’Apocalisse (Apoc. 12.1), a cui il papa paragona tranquillamente l’imperatore. Il fatto è che Federico, per giustificare il suo rifiuto di obbedire agli ordini di Roma, ha pubblicato un manifesto in cui rivolge al pontefice tutte le accuse possibili, e Gregorio IX, prima di rintuzzarle puntigliosamente in dieci dense pagine, avverte i destinatari che queste accuse in realtà sono bestemmie, perché sono rivolte contro il vicario di Cristo:
Smettete di stupirvi, tutti voi a cui giungono le parole di bestemmia rivolte da questa bestia contro di noi, se noi, assoggettati al servizio di Dio, siamo bersaglio dei dardi della calunnia, perché neppure il Signore rimane indenne da quest’obbrobrio. Smettete di stupirvi, se sfodera contro di noi la spada delle ingiurie colui che aspira a cancellare dal mondo il nome del Signore. Ma piuttosto, affinché possiate resistere alle sue menzogne proclamando la verità e confutare i suoi inganni con mente pura, osservate bene la testa, il corpo e la coda di questa bestia, Federico cosiddetto imperatore..., fabbricante di falsità, che non sa cosa sia la modestia e ignora il pudore, si fa beffe della verità e mente senza arrossire...
...E così via su questo tono. Se solo i papi del XX secolo avessero usato queste parole contro Mussolini e Hitler! Sarebbe cambiata la storia del mondo. Ma il linguaggio della Chiesa, a quell’epoca, non era più lo stesso, e le parole che riuscivano così naturali ai papi del Medioevo non potevano più essere pronunciate, anche se venivano direttamente dalla Bibbia. La collera che oggi ci stupisce quando papa Francesco anche solo accenna, scherzando, alla possibilità di arrabbiarsi, era un tratto normale dei papi del Medioevo: perché credevano davvero di essere stati posti su quel trono come vicari del Dio degli eserciti, e per combattere la sua giusta battaglia, in un mondo pieno di nemici che meritavano di essere schiacciati.
3. Unam sanctam (1302):
Bonifacio VIII e Filippo il Bello
Ma c’è ancora un aspetto del linguaggio dei papi del Medioevo che merita di essere evidenziato, perché è tipico della loro cultura, non meno che i solenni riferimenti biblici e le collere apocalittiche. Le analogie con la Bibbia avevano, naturalmente, un poderoso impatto sull’opinione pubblica, e bastavano da sole a creare un discorso politico – a patto, naturalmente, di non impiegarle così spesso da logorarle. Ma era possibile anche un altro uso di quelle Scritture sacre che i teologi dell’epoca conoscevano a memoria e da cui potevano attingere con facilità e naturalezza in qualunque occasione. La Bibbia offriva un ricchissimo repertorio di situazioni e di frasi la cui analogia col presente poteva essere ancor più valorizzata se si riusciva ad analizzarle coll’arte della logica e con la sottigliezza dell’avvocato che interpreta una legge. Ora, i papi del Medioevo erano spesso giuristi, addestrati a commentare le sentenze del diritto e a spremere da una parola più conseguenze di quelle che sembrava contenere agli occhi degli inesperti. Giurista, quasi certamente licenziato all’università di Bologna e specialista di diritto canonico, era Bonifacio VIII, al secolo Benedetto Caetani, e questa formazione è ben riconoscibile nel suo linguaggio. Nel 1302, nel pieno dello scontro col re di Francia Filippo il Bello, che di lì a poco si sarebbe concluso con la sua rovina, il papa pubblicò la bolla Unam sanctam, in cui affermava che la Chiesa è una sola e che detiene non soltanto il potere spirituale, ma anche quello temporale.
Abbiamo usato il verbo affermare; ma Bonifacio VIII, in realtà, non afferma nulla in modo asseverativo e gratuito. Piuttosto, argomenta e dimostra, partendo sì dalla Bibbia, ma commentandola e piegandola al suo scopo con la duttilità di una mente giuridica. Si tratta, innanzitutto, di dimostrare che la Chiesa è una sola: e all’inizio il papa procede come avrebbe potuto procedere un teologo di secoli meno sofisticati, per pura analogia. Nel Cantico dei Cantici lo sposo proclama: «Unica è la mia colomba, la mia perfetta. È l’unica figlia di sua madre, la preferita» (Cant. 6.9); al tempo del diluvio l’arca è stata una sola, e aveva un solo timoniere, Noè (Gen. 6-8); nei Salmi si legge: «Salva dalla spada, Signore, la mia anima, e dagli artigli del cane, è l’unica che ho» (Ps. 21.21). In tutti questi casi la parola del Signore, sottintende il papa, si riferisce sempre alla stessa cosa, e cioè alla Chiesa; e allo stesso modo si spiega anche quel passo del Vangelo di Giovanni, in cui viene precisato che la tunica di Gesù era tessuta tutta d’un pezzo (Gv. 19.23-24): «Questa è quella tunica senza cuciture del Signore, che non fu tagliata, ma tirata a sorte».
Fin qui, dunque, il papa procede con un metodo argomentativo del tutto tradizionale, anzi arcaico. Poi continua:
Dunque la Chiesa, che è una sola e unica, ha un corpo, e un solo capo, non due come se fosse un mostro; ha per capo Cristo e il suo vicario Pietro, e il successore di Pietro...
E qui, di colpo, è il giurista che prende il sopravvento:
...perché il Signore ha detto a Pietro: «Pascola le mie pecore». Mie, ha detto, e in generale, non singolarmente queste o quelle: per cui si deve capire che gliele ha affidate tutte.
La novità salta all’occhio. Non si tratta più soltanto di citare passi biblici che si prestano a un’analogia: si tratta di interpretare il passo evangelico (Gv. 21.16), ma non come interpreta un teologo, bensì come interpreta un avvocato. «Mie, ha detto, e in generale, non singolarmente queste o quelle: per cui si deve capire che gliele ha affidate tutte». E Bonifacio VIII è rapido a forzare la conclusione: chi non riconosce l’autorità del papa non forma un’altra Chiesa, ma è fuori dalla Chiesa, perché ne esiste una sola.
Se quindi i Greci o altri dicono di non essere stati affidati a Pietro e ai suoi successori, devono ammettere per forza di non far parte del gregge di Cristo, perché il Signore nel Vangelo di Giovanni dice che c’è un solo ovile e un solo pastore.
Con lo stesso metodo il papa-giurista procede a dimostrare che la Chiesa romana detiene non soltanto l’autorità spirituale, ma anche quella temporale, e quindi – usciamo da queste formule invecchiate per capire che cosa concretamente significano – il papa ha il diritto, e il dovere, di dare ordini ai re, e i re hanno il dovere di ubbidirgli. Gregorio VII l’aveva dichiarato solennemente oltre due secoli prima, ma Bonifacio VIII non si accontenta di ripeterlo: ritiene che sia ancora utile dimostrarlo. Per tradizione l’esistenza di due poteri, spirituale e temporale, era espressa con l’immagine delle due spade, a partire da un episodio del Vangelo di Luca, e Bonifacio continua a utilizzarla, ma senza rinunciare nel commento a un’ulteriore sottigliezza:
E il Vangelo ci insegna che in questo ovile e nella sua autorità ci sono due spade, lo spirituale e il temporale. Perché, quando gli apostoli dissero «Ecco qua due spade», il Signore non rispose che era troppo, ma che era abbastanza.
L’episodio evangelico a cui fa riferimento il papa (Lc. 22.36-38) è di quelli che danno da fare ai commentatori. Durante l’Ultima cena, Gesù avverte gli apostoli che presto verranno ...