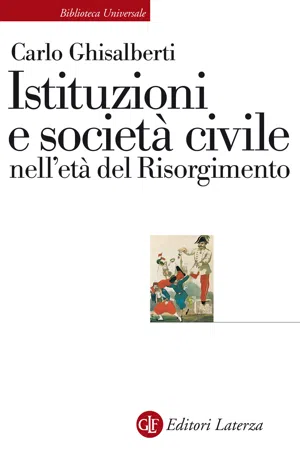
- 222 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento
Informazioni su questo libro
L'evoluzione del rapporto tra potere, istituzioni e cittadini nel corso della delicata fase di formazione dello Stato unitario italiano, dalle irrequiete vicende politiche risorgimentali alle diverse esperienze costituzionali 'giacobine' e napoleoniche fino allo Statuto albertino. Carlo Ghisalberti illustra i lineamenti delle trasformazioni costituzionali risorgimentali e il modo in cui incisero sulla società civile.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento di Carlo Ghisalberti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Politics & International Relations e Italian History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Politics & International RelationsCategoria
Italian HistoryIV. Tra Baiona e Cadice: illusioni e miti in due costituzionalismi
Se non è mai agevole paragonare esperienze storiche vissute anche nello stesso periodo da popoli differenti, per il retaggio di tradizioni antiche, per il condizionamento delle realtà ambientali e soprattutto per la varietà delle contingenze politiche, la comparazione appare ancor più problematica quando si vogliono confrontare le vicende costituzionali d’Italia e di Spagna negli anni tra la fine dell’antico regime e la Restaurazione1. È noto come la storia delle due penisole dall’autunno del Medioevo alle soglie dell’età moderna – al di là del ruolo eminente esercitato dalla romanità fattasi cristiana nella formazione di un’italianità o di una hispanidad culturale e civile, legate la prima anche alla tradizione giustinianea, l’altra prevalentemente ma non esclusivamente a quella teodosiana mantenuta durante la dominazione visigotica – abbia costituito nel tempo un forte elemento di identificazione nazionale in ciascuna di esse. Un’identificazione che sul finire dell’età di mezzo, tanto per la diffusione estremamente vasta e per certi aspetti addirittura universale della tradizione romanistica recepita ad opera della giurisprudenza delle due nazioni, quanto per il destino politico che dal tempo di Filippo II all’avvento dell’egemonia austriaca in Italia le accomunava come parti dell’unico impero – nel quale molte regioni della nostra penisola erano soggette all’iberica –, sembrava confermata anche dalla similitudine degli istituti di governo e di strumenti normativi che regolavano la vita pubblica e i rapporti civili nelle due aree. Tale similitudine infatti avrebbe dovuto riflettersi anche nell’introduzione sia in Italia che in Spagna della prassi e dei canoni di governo dell’assolutismo, empirico prima, illuminato poi2.
In realtà la differente applicazione di questi nelle due aree – caratterizzate da un diverso grado di sviluppo culturale e civile di popolazioni dalla mentalità, dai costumi e dalle tradizioni dissimili – e la differente influenza esercitata nelle due penisole da dottrine e idee non sempre ugualmente recepite e accettate avevano ostacolato il realizzarsi di quella omologazione. Così la diffusione dell’Illuminismo che, nonostante il generico approccio universalistico, si presentava con connotazioni piuttosto diverse nelle due nazioni3 e la successiva espansione delle idealità della Rivoluzione francese, abbastanza facilmente recepite in Italia e invece duramente contestate in Spagna anche per lo scarso seguito che trovarono nell’opinione pubblica gli afrancesados prima i josefinos poi, finirono col differenziare ancor più i destini delle due penisole4.
Vero è, però, che talune esperienze politico-costituzionali del primo Ottocento pur diversamente accolte dai due popoli, come gli statuti napoleonici di Baiona del 1808 o il testo elaborato nel 1812 dalle Cortes di Cadice, i primi per le illusioni da cui erano derivati e per la loro mancata attivazione e il secondo per il mito che avrebbe successivamente portato alla sua esaltazione, avrebbero talvolta autorizzato e favorito qualche accostamento nell’interpretazione storiografica di quelle vicende. Accostamento che in realtà, per l’ambiente in cui quelle esperienze si svolsero, le circostanze che le connotarono e le modalità della loro fine, resta, malgrado le analogie dei testi costituzionali, alquanto problematico.
È noto che le due costituzioni di Baiona, concesse da Giuseppe Bonaparte l’una il 20 giugno 1808 per il Regno di Napoli e di Sicilia5, l’altra per la Spagna il 7 luglio 1808 mentre abbandonava il trono del Mezzogiorno italiano per assumere quello iberico6, sembravano inserirsi a pieno titolo nell’aspirazione napoleonica a uniformare more geometrico il regime politico degli Stati ruotanti intorno al grande Impero creando in essi ordinamenti fondamentalmente simili, modellati almeno nelle grandi linee sulle costituzioni date alla Francia dall’anno VIII (1799) all’anno X (1802) e all’anno XII (1804)7. Questa aspirazione nasceva dalla formazione razionalista dell’imperatore che, figlio dell’Illuminismo ed erede della Rivoluzione, era formalmente legato agli schemi e ai postulati del costituzionalismo allora elaborati e da lui interpretati in una linea coerente con le esigenze del proprio potere8. E se da quelli talvolta parve allontanarsi per motivi pragmatici accettando l’introduzione negli ordinamenti degli Stati satelliti di qualche variante ai modelli francesi – come nel caso della rappresentanza corporativa prevista dai Comizi nazionali di Lione nel 1801 per la costituzione della Repubblica italiana e successivamente imitata da altri testi9 o nel 1803 quando con l’Acte de Médiation favorì il ritorno della Svizzera a una forma confederale ripudiando l’idea «giacobina» della Repubblica elvetica «una e indivisibile»10 –, il suo modo di pensare continuava a riflettere di massima quegli schemi e quei postulati nonostante i dissensi che sollevava e le opposizioni che suscitava11.
Questa e non altra, quindi, la ragione per la quale, dalla pace di Presburgo del 1805 a quella di Schönbrunn del 1809, al momento dell’apogeo del Grand Empire, nell’illusione di poter omologare in qualche misura gli ordinamenti di vaste aree d’Europa allora assoggettate alla sua egemonia, cercò di favorire in diversi Stati del continente la recezione di quegli schemi e di quei postulati che la Rivoluzione aveva elaborato e tentato di diffondere sin dai tempi del Direttorio. Consapevole della loro superiorità, anche per i perfezionamenti ad essi apportati dal Consolato e dall’Impero soprattutto ad opera degli idéologues legati al potere, veri maîtres à penser in quegli anni di massimo consenso dell’opinione pubblica francese, volle che le istituzioni politiche e civili dei regni gravitanti nell’orbita imperiale fossero ispirate al modello rappresentato da quelle della nazione guida, fondate, come è noto, sulla costituzione, sul Code Napoléon e sull’amministrazione centralizzata prevista dalla legge 28 piovoso anno VIII12.
Era questa un’aspirazione destinata a rivelarsi ben presto illusoria, sia per gli ostacoli che avrebbe incontrato in molte realtà locali, anche ad opera di coloro che avrebbero dovuto applicarle, sia per la dura resistenza che avrebbe suscitato in popolazioni che in nome di forti sentimenti politici e religiosi le sentivano estranee alle proprie tradizioni e al proprio modo di concepire la vita associata. Lo statuto di Baiona, emanato per la Spagna poco più di un mese dopo la rivolta madrilena del 2 di maggio del 1808 e poco prima della disfatta francese di Baylen del 21 luglio13, avrebbe simboleggiato, nella sua pratica inapplicabilità in una nazione sconvolta dalla guerra, il fallimento di questa sua aspirazione14, mentre quello destinato al Regno di Napoli e di Sicilia non sarebbe mai stato attivato per le preoccupazioni e i timori di Gioacchino Murat che ne aveva assunto la corona15.
Lo statuto spagnolo di Baiona, immediatamente rifiutato da quella parte dell’opinione pubblica resistente e non collaborazionista in nome della tradizione nazionale e del buon diritto antico, perché dettato da Giuseppe, «el rey intruso», e imposto solo dalla forza delle armi straniere, era destinato, forse ancor più di quello per il Mezzogiorno d’Italia, rimasto di fatto inattuato per la mancata convocazione del parlamento16, a simboleggiare il fallimento dell’illusione napoleonica di dare agli Stati legati all’egemonia francese istituzioni fondamentalmente uniformi. Era un’illusione che anche altrove, e in particolare nei diversi Stati della Germania assoggettata, era egualmente destinata a svanire.
In questa nazione, ove l’assenza di un’effettiva unità rende più complessa la percezione di un quadro unitario delle resistenze e delle opposizioni ai disegni napoleonici di riordinamento statale, l’introduzione di costituzioni incontrò difficoltà non indifferenti ancor prima dello scoppio della rivolta nazionale del 1813. In Baviera, ad esempio, si era giunti, è vero, all’introduzione del testo del 1° maggio 1808 modernizzante e profondamente riformatore nell’ispirazione e nei contenuti: di fatto, però, al di là del valore programmatico delle sue norme attestanti le aspirazioni del potere, ben poco poté essere realizzato dal momento che mancava quell’ammodernamento della società civile che anche la recezione del Code Napoléon avrebbe dovuto favorire insieme all’attuazione del testo costituzionale avviando una rigenerazione politica e sociale della regione17. Insuccesso che si era avuto anche nel Baden per l’incapacità di emanare la costituzione reiteratamente promessa dal potere e nel Württemberg ove l’editto organico del 18 marzo 1806 dedicato al riordinamento burocratico del piccolo Stato non poteva avere il valore e il significato di uno statuto18.
Anche nella Confederazione del Reno dal 16 luglio 1806, data della sua istituzione, molto si era discusso dell’applicazione dell’atto costitutivo e, più ancora, dello statuto fondamentale che la Dieta avrebbe dovuto applicare per trasformare le strutture istituzionali ereditate dal particolarismo e dalla frantumazione sociale precedente. Ma le resistenze nobiliari all’eversione del feudo e lo scarso appoggio popolare avevano snaturato il piano originario trasformando il rapporto tra la Confederazione e la Francia in un vincolo meramente personale della prima nei confronti del suo ideatore e protettore, vincolo destinato a rompersi quando le fortune politiche e militari di Napoleone dopo la campagna di Russia sarebbero venute meno19. Analogo insuccesso dei disegni di riforma istituzionale si ebbe nel Regno di Sassonia dopo l’11 dicembre 1806, malgrado vi fosse un impegno della pubblicistica altrove non riscontrabile: i 43 scritti comparsi tra il 1808 e il 1815 mostravano una notevole partecipazione del ceto intellettuale di formazione illuministica alla trasformazione dello Stato e della società sassoni, partecipazione che, pur agevolando e insieme seguendo una certa modernizzazione del paese, non riuscì a imporre una riforma dell’apparato statale per adeguarlo alle esigenze contemporanee20.
Diverso il caso del Regno di Westfalia ove lo statuto costituzionale di modello francese del 1807 aveva ottenuto l’avallo del ceto burocratico, che vi aveva ravvisato lo strumento idoneo per la realizzazione degli obiettivi riformistici perseguiti sin dalla seconda metà del secolo precedente con la demolizione delle strutture particolaristiche e dei corpi intermedi21. Non a caso di qua e di là del Reno il Regno di Westfalia appariva un modello organizzativo da additare all’intera Germania occidentale in funzione antiprussiana: «Questo modo di governare – scriveva allora Napoleone al fratello Gerolamo – sarà un modo più potente per separarvi dalla Prussia di quanto non lo siano l’Elba, le piazzeforti e la protezione della Francia. Quale popol...
Indice dei contenuti
- Premessa
- I. Sulla formazione dell’unità dello Stato nel Risorgimento
- II. Dalle repubbliche «giacobine» ai regni dell’Italia napoleonica: il senso di un’esperienza costituzionale
- III. La società del codice civile
- IV. Tra Baiona e Cadice: illusioni e miti in due costituzionalismi
- V. I modelli costituzionali della Restaurazione e le istanze rivoluzionarie
- VI. Il modello politico inglese nell’Italia del Risorgimento
- VII. Nazione liberale e nazione democratica
- VIII. Il costituzionalismo democratico nel 1848-49
- IX. Il costituzionalismo del 1848-49 e la Venezia di Manin
- X. La monarchia subalpina e lo statuto
- XI. Laicismo e laicità nell’esperienza risorgimentale