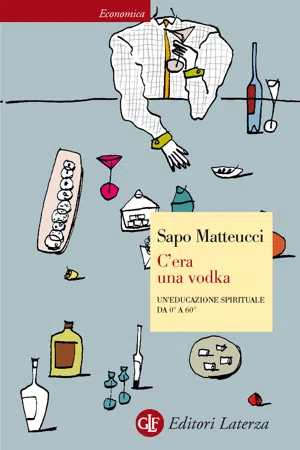Gli spiriti divini (da 12° a 16°)
Due o tre cose che so di lui
Il vino è ormai molto più d’un prodotto, di un’etichetta, di un territorio. Molto più del suo sapore. Simbolicamente lo era da millenni, a partire almeno dai culti predionisiaci, fino al sangue di Cristo, passando per Pulci, Rabelais e Redi, capace di scherzarci su in modo competente, di usarlo per esaltare il suo tempo e il suo mondo, sia pure prendendoli in giro. Soprattutto, capace di berselo.
Con l’affinarsi delle tecniche, del marketing, dell’impegno produttivo e della diffusione, il vino è diventato in molti paesi una questione d’identità, con un forte impatto sull’immaginario collettivo. Se nei film italiani di quarant’anni fa al massimo si vedeva in trattoria il mezzo litro «legale» col piombino nel vetro, in quelli americani il vino non entrava proprio. Nel film Revolutionary Road di Sam Mendes, con Di Caprio e Winslet, ambientato negli anni Cinquanta dei colletti bianchi, non vi sarà sfuggita la scena del Three-Martini-lunch: tre Martini tra colleghi a mezzogiorno, ecco il pasto. Nei film di oggi, invece, gli amici, i fidanzati, i colleghi, i coniugi non bevono cocktail, ma stappano bottiglie di vino e brindano a bianco o a rosso.
Il vino s’infila tra le questioni di Stato (complesse) e quelle private (leggere), sempre lì lì per trasformarsi da piacere in dovere. Status e consapevolezza contro divertimento e abbandono. Su di lui si appuntano spesso tic e ossessioni; si stilano editti, si marcano bolle papali. La conoscenza rischia di trasformarsi in mania. Il lessico degustativo ha raggiunto ipertrofie siderali. Pulci, Redi e Rabelais in confronto sono dei ragionieri; D’Annunzio un fiscalista. Solo il cosiddetto “retrogusto” genera fenomenologie frattali, alimenta una selva d’intrecci allegorici in cui da anni non penetra più il sole. Per “l’ingresso in bocca” e per i “sentori” non bastano né le arti del Trivio né quelle del Quadrivio. E i profumi? Non trovate la viola, va bene; vi sfugge il ribes; ma cogliete la pesca? Ecco la pesca! c’è la pesca! Già, ma quale? Gialla, bianca, romagnola, maremmana...? E la mela? Sarà una renetta? E il mirtillo? È quello palustre.
Mi piacerebbe che tutto questo appartenesse alle grandi catalogazioni fantastiche: si trovasse in qualche bestiario medievale, nell’iconologia del Cavalier Ripa, nella borgesiana Storia universale dell’infamia, in Gadda o in Queneau. Invece no. È tutto scritto e prescritto. Ci sono tomi su tomi, con spettri organolettici, metafore abissali, gradienti papillari, circumnavigazioni dell’acino, palpazioni del tappo. Le letture elementari, gli accenni al territorio, ma anche le suggestioni del paesaggio e del genius loci sono travolte da un imperativo scientista, da gradienti olfattivo-cromatici o da impalcature ideologiche: il mito dell’origine, la tradizione che non si tocca, i lieviti che vanno denunciati, il legno, il superlegno, il sughero, il silicone...
Si susseguono seminari platonico-lucreziani, in cui nei quattordici secondi di coprifuoco degustativo uno dei discenti potrebbe stramazzare a terra trafitto dalla transustanziazione delle bucce, travolgendo bottiglie, bicchieri e taralli neutri (insapori, quindi professionali), ma nessuno interromperebbe l’esperienza mistica. Il primo che si risveglia riemergendo da un’ade sensoriale si dispera perché magari è partita una bottiglia di Sfursat, ma il compagno svenuto, visitato dal dio del tannino, non giace nel vino, bensì in una pozza di sangue.
Il primo consiglio, allora, è che a un certo punto bisogna darci un taglio. Parlarne con più semplicità, scambiarsi idee, divertirsi a scoprire una nuova bottiglia, ritrovarne una antica, evocare i territori (anzi, meglio, praticarli). Ma proviamo a mettere la sordina all’iperanalisi olfattiva, iperdegustativa, iperdecantativa, iperschedativa. Col vino in bocca non si parla. Conoscere non significa analizzare allo stremo, dover dire sempre una parola nuova. Una radiografia non è un bel viso e un bel viso si descrive con pochi tratti. Soprattutto: un bel viso ci suggestiona e c’incanta, senza troppe ragionerie. Com’è bello vedere al primo sorso negli occhi d’un amico o d’una ragazza la gioia semplice, immediata del «mi piace!» e continuare a berselo insieme, contenti per averlo saputo scovare in qualche enoteca.
Rivendico un rapporto più franco e immediato col vino. Il che non vuol dire confondere il Masseto col Nipozzano o il Primitivo col Dolcetto, pensare che il Lessona sia un vino bollito e il Rossese di Dolceacqua un rosso un po’ annacquato. Vuol dire semplicemente che ci può piacere un vino di cui non si conosce nulla; che non bisogna essere vittima di nessun complesso di inferiorità se non si sanno inquadrare teoricamente gli antociani. Né rovinarsi la cena perché forse in quel Brunello c’è un po’ di Merlot e non ce ne siamo accorti, o perché il Barolo non è più quello di un tempo col suo ottocentesco tabarro di catrame. Significa essere felici di poter coltivare il nostro stupore di fronte a un vino che non si riconosce, magari perché è cambiato in meglio, come certe Barbere. Quindi, prima cosa: nessun senso di colpa. Semmai di polpa.
Seconda cosa: il vino da solo non esiste e non si sa mai cosa sia fino in fondo. Non a causa di un romanticistico, indefinibile noumeno, ma perché è come un racconto, un libro, una poesia, un quadro, una canzone. «Nessuno sa interamente cosa scrive» diceva Borges, anticipando il Lector in fabula di Umberto Eco, perché è il rapporto del testo col lettore, con la sua indole, il suo vissuto, la sua sensibilità che dà al medesimo racconto o alla stessa poesia mille facce diverse. Il libro, la fabula, sono gli stessi; ma i lettori, i lupi sono diversi uno dall’altro. A me personalmente ha messo sempre maggior allegria il Lambrusco dello Champagne. Per leggere non c’è bisogno di conoscere a menadito la filologia romanza o peggio d’inventarsi filologie romanze personali, spacciate per universali. Col bere è la stessa cosa: attenzione fa rima troppo spesso con ossessione e non con evasione. Anche se le ossessioni con le briglie conducono lontano...
Terzo: contano il tempo, il luogo e il momento. Sotto un capanno abusivo di fronte al mare, alle tre di pomeriggio d’un qualsiasi martedì estivo nei pressi d’Acciaroli, non cerco il Collio, ma nemmeno il Fiano. M’accontento (no, mi compiaccio!) di un San Lorenzo, di un Rosato del Cilento: perché non li conosco, perché ne voglio bere tanto in quanto semplici e beverini, e perché non sono sulla guida che detta le regole. Su nessuna guida, anzi. Da solo, in un bell’albergo di Rho fornito di maestosa cantina, nel cuore d’un piovoso febbraio, un editore, che sembrava interessato a qualcosa che scrivo, ha appena disdetto l’appuntamento della speranza. Sdraiato, guardo il soffitto, poi consulto la lista, alzo il telefono e ordino un Grand Cru Bâtard-Montrachet da 220 euro, con due toast da 8. Quindi, come corollario: sì alle guide, alle indicazioni sobrie, ai meridiani e ai paralleli con qualche bella suggestione. No al sestante, al puntamento satellitare, al canone scienteggiante, al lessico iniziatico del vinese. Soprattutto sì alle esperienze. Ai paesaggi della terra, a quelli della mente. E al caso.
È per questa ragione che da un po’ di tempo preferisco le sommelier ai sommelier. Perché con poche, magistrali indicazioni, vanno dritte al cuore dell’enigma, sentono cosa cercate e non inarcano mai il sopracciglio; non gliene frega niente se siete un po’ ingenuo, anzi. Vi parlano semplicemente, senza protesi dell’ego, come fanno invece gli uomini, che officiano e vi scrutano, v’inquadrano, vi prendono le misure, subito pronti al controcanto. Con le sommelier, avrei voglia di rompere l’interdetto. Come il paziente che vuol baciare il proprio psicoanalista, spesso vengo colto dal raptus d’invitarle al tavolo in cui mangio da solo. Non mi succede con nessuno. Con loro sì: mentre stanno lì in piedi, dopo avermi versato un po’ di vino nel bicchiere, in attesa d’un responso per lo più scontato, non penso mai a quel che bevo. Non le guardo, non ne ho il coraggio. Fissando il vuoto, sorseggio con l’idea fissa dell’invito (a tutta la categoria) e vorrei dire: «Per favore si sieda, beva un bicchiere con me». Di fatto prolungo spesso l’assaggio oltre il limite. Incatenato dalla perplessità, immetto, borbotto, riassaggio, nutro il mio atto mancato. Poi, mestamente, travolto dalla risacca della mia viltà, sono costretto al verdetto: «Va bene», dichiaro in un labile sibilo, estinto prontamente nel sottofondo chiassoso del mondo. «Come?» risponde lei, Giovanna d’Arco mentre brandisce la bottiglia, «guardi che se non è convinto gliela cambio». E io vorrei che la cambiasse, che andasse di là e ritornasse per un nuovo tappo, un nuovo bicchiere e un altro sorso ancora. Ma è un sogno, un sorso a occhi aperti.
Un altro comandamento da sfatare, un’ulteriore ossessione da irridere, è la temperatura. Oddio la temperatura! «È mezzo grado in più, è mezzo grado in meno... Eh no! Un filino caldo, ancora un po’ di freddo, giovine!». E avanti e indietro, dal freddo al caldo e viceversa. Conosco un illustre studioso, un umanista, che è anche un raffinatissimo gourmet. È severo, competente. Sa slanciare e contenere i suoi entusiasmi grazie alle briglie d’una sorvegliatissima condotta. Infatti è magro, dotato di fermo portamento e di un essenziale, affilato profilo, ma goloso. Un perfetto giansenista della crapula, insomma. Un giorno a tavola con lui, doppiamente allievo, seguivo quel duca che ordinò generosamente anche per me, trasformando il mio silenzio in immediato assenso. Fece tornare subito indietro gli spaghetti troppo tiepidi (a me bollenti però non piacevano); chiese che il pane «per favore» fosse presentato in ben altra foggia: statim fuori i grissini non artigianali (regredendo di fronte a tanta autorità, pensai stravolgesse l’inglese state, magari per dire «all’istante», invece era latino); vade retro anche il vino. Quello ordinato era un rosso del posto, di buona fama. Non l’aveva nemmeno assaggiato: aveva solo sfiorato la bottiglia, e allora perché mandarlo indietro?
«Caldo. Troppo caldo!». Scandì, senz’appello.
«Allora prenda questa. L’ho bevuto. Va bene». Gliela passai e fece una smorfia:
«Peggio dell’altra. Questa supera di certo i 19 gradi. Scusi, eh!», disse tirando fuori dal taschino interno della giacca un astuccio. Estrasse un termometro sottile che infilò nel bicchiere; poi lo riportò agli occhi e:
«19 gradi e 2», disse trionfante. La bottiglia fu scansata, spostata lontano da noi come un paria intoccabile. Senza pane, grissini, vino, restammo lì in attesa, naufraghi approdati su una disabitata tovaglia bianca. I camerieri stavano al largo, evitando silenziosi quella Scilla e Cariddi enogastronomica.
Guardando la bottiglia intoccabile, dissi stupidamente:
«Forse decantandolo».
«Che c’entra, scusi! Non è questione di ossigeno; e poi, anzi, nel decanter si scalderebbe ancora di più».
Nel deserto tovagliato, intanto, la conversazione andava avanti. Fu molto utile. Imparai, mentre la colite veniva a visitarmi, che stappare un vino importante, maturo, d’annata e di struttura imponente (un Barbaresco, un Taurasi...) non serve a niente: troppo modesto il pertugio libero nel collo della bottiglia. Al secondo morso colitico (il pane non tornava, i grissini erano condannati a un perpetuo ostracismo), appresi che la cantina deve essere ...