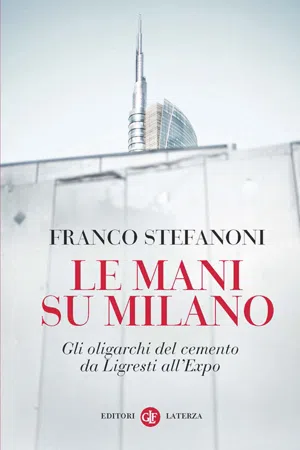La spartizione della città
Negli anni Duemila l’oligarchia del mattone porta sulla scena vecchi e nuovi protagonisti. Le macerie della bolla immobiliare degli anni Ottanta e di Tangentopoli dei primi anni Novanta hanno lasciato sul campo una città dove urbanistica e edilizia hanno significato soprattutto speculazione, mazzette, illegalità, prepotenze politiche e imprenditoriali. C’è dunque fame di fare e di lasciarsi per sempre alle spalle la Milano da bere e di Mani pulite. Quando, nella primavera 1993, s’insedia il sindaco leghista Marco Formentini, questi avverte subito che «Milano sarà il biglietto da visita dell’Italia», in cui l’urbanistica è il piatto forte. Il borgomastro, come viene chiamato, promette un nuovo piano regolatore con corposi progetti, dal riassetto della Fiera al passante ferroviario, dal recupero di aree dismesse all’edilizia residenziale.
Nel tentativo di dimenticare le antiche abitudini delle precedenti giunte a guida socialista, s’interrompe il dialogo con Salvatore Ligresti, quasi monopolista delle costruzioni in mezza città. Lui ci prova, ma resta deluso. E non va meglio con altri immobiliaristi, del passato e del presente. La Lega Nord appare prudente in una fase post-Tangentopoli che frena il mercato: vengono poste le basi per riqualificare l’area Bicocca degli storici stabilimenti della Pirelli e per trasformare in zona Portello i capannoni dell’ex Alfa Romeo, senza andare molto più in là. Con Formentini sono anni di annunci di strategie che, però, stentano a trovare uno sbocco in grande stile. Tra liti e baruffe politiche, dura opposizione in consiglio comunale, delibere bloccate e lotte intestine nel partito del Carroccio, il sindaco leghista diventa un emblema di immobilismo sia per gli interessati al business del cemento, sia agli occhi di tanti cittadini. Umberto Bossi lo striglia: «A Milano è mancato un po’ di decisionismo, di rapidità. [...] Io sognerei politici gagliardi. Quelli che vanno dall’imprenditore e gli dicono: ‘Vedi questa licenza per costruire? Vuoi edificare duemila metri quadrati, ti do la licenza soltanto se mi regali 40 mila metri quadrati di terreno’. [...] Io credo che l’intervento in urbanistica debba essere politicizzato». Ma il grande salto, l’occasione per aprire mille cantieri, non viene spiccato.
Dalla Lega a Forza Italia
Dopo quattro anni dal leghismo si passa al berlusconismo. Al potere sale la giunta del sindaco forzista Gabriele Albertini, ex dirigente di Confindustria, e il destino del mattone cambia. Durante il suo doppio mandato, dal 1997 al 2006, lo slogan è: «Ridisegneremo Milano». La sintesi politica e imprenditoriale, che con la Lega Nord non aveva portato da nessuna parte, ora tiene. Determinante sarà l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Lupi, di Forza Italia. Ex giornalista al settimanale «il Sabato», una carriera nel gruppo Fiera Milano, dove diventa amministratore delegato della società che si occupa di congressi, il milanesissimo Lupi è cresciuto nella Dc e poi nel Cdu, come consigliere comunale in opposizione proprio alla giunta di Formentini. Soprattutto, Lupi è di Comunione e liberazione, movimento cattolico che fa da mastice a molti appetiti economici, non ultimo quello del cemento. È lui che smista le miliardarie operazioni immobiliari dei primi Duemila, è lui l’inevitabile punto di riferimento per chi vuole farsi spazio nel business, anche se da qualcuno viene ricordato soprattutto per la domanda posta alla regina Elisabetta d’Inghilterra, in visita ufficiale in città: «Do you like Piazza Scala?», alludendo alla sistemazione urbana da lui gestita. A differenza degli anni Ottanta e primi Novanta, dove la politica ha cercato di imporsi e venire ai patti con le esigenze degli imprenditori del mattone, ora sembra non esserci più bisogno di trattare: i desiderata dei signori del cemento fanno già parte della sensibilità di chi governa Milano. È durante il mandato di Lupi che sono firmati, con la Regione di Roberto Formigoni, anch’egli di Comunione e liberazione, gli accordi di programma per gli interventi nelle immense aree ex industriali: «Passeremo dalla città del degrado alla città dei cantieri», promette l’assessore. È sempre con Lupi che vengono riviste le regole procedurali per gestire le questioni urbanistiche, nel segno della semplificazione e della deregulation: «È da Tangentopoli che tutto è fermo».
È di nuovo con Lupi che vengono applicati criteri innovativi per quantificare gli oneri di urbanizzazione a carico dei privati, che in un caso portano a un processo (con proscioglimento) per tentata truffa e abuso d’ufficio, motivato da una sospetta assegnazione di una cascina a un’associazione della ciellina Compagnia delle opere, con dimissioni offerte dall’assessore, respinte dal sindaco. Molto stimato da Silvio Berlusconi, il responsabile dell’urbanistica milanese proseguirà il proprio percorso politico in Parlamento. Nel 2001 verrà rimpiazzato dall’udc Gianni Verga, ingegnere, già segretario cittadino del Cdu, che andrà avanti nel solco tracciato dal predecessore. Ringrazierà e dirà: «In nove anni, nell’urbanistica con questo sindaco si è fatto più che in qualunque altro periodo storico». Insieme ad Albertini, Verga cercherà in tutti i modi (senza successo) il colpo grosso: far assegnare a Milano, l’organizzazione delle Olimpiadi del 2016.
Nel maggio 2006, lo scranno di sindaco viene scalato dalla forzista Letizia Moratti, figlia di assicuratori e moglie del petroliere Gianmarco, fratello di Massimo, presidente dell’Inter (dov’è socio Marco Tronchetti Provera, padrone della Pirelli). La nuova giunta di centrodestra, dopo una prima fase di attesa, rilancia sui grandi progetti edilizi sviluppati da Albertini e Lupi, anche con il sostegno di varianti urbanistiche e, soprattutto, avvia la stesura del nuovo Piano di governo del territorio (Pgt), mappatura giuridica ed economica su cui ridisegnare la città. Il Pgt è chiamato a sostituire il vecchio Piano regolatore generale, fermo al 1980, e impiegherà cinque anni per essere definitivamente varato. Si pongono le basi per distribuire ondate di cemento, infrastrutture e verde da spalmare sui 182 chilometri quadrati che costituiscono l’intera area di Milano. Il sindaco ha addosso gli occhi dei principali attori del mattone. È spronata da Silvio Berlusconi, che nel gennaio 2010 per discutere di urbanistica la convoca nella sua residenza di Arcore con tutti gli onori. In precedenza Letizia Moratti si era già pronunciata: «Ci sono momenti in cui le città possono dare una svolta irrinunciabile al loro futuro, e credo che il Pgt rappresenti questa occasione».
Il primo cittadino ascolta le ragioni di immobiliaristi e costruttori, in particolare Salvatore Ligresti, e in consiglio comunale difende il Pgt da migliaia di emendamenti contrari all’eccesso di cementificazione. Forse non a caso, l’impostazione sarà benedetta dall’ingegnere di Paternò: «Sembra un ottimo piano, perché rispecchia quelle che sono le esigenze attuali di Milano: creare molto verde e spostare volumi dove c’è bisogno». Si prevede di incrementare gli indici di edificabilità, con la promessa di non eccedere nel consumo di nuovo territorio. Com’è possibile? Riqualificando immense ex aree industriali ormai alla deriva. Il piano comunale si propone di innalzare 30 mila case a prezzi calmierati, recuperare sette scali ferroviari, riadattare 26 zone dove calare 18 milioni di metri cubi di cemento, individuare 22 aree verdi, puntare sui 42 milioni di metri quadrati in zona Parco agricolo Sud dove conta molto proprio Ligresti: infatti, con lo strumento della cosiddetta perequazione, l’ingegnere ha di nuovo la possibilità (come negli anni Ottanta) di cedere terreni a cui il Comune è interessato, ottenendo in cambio altro terreno da altre parti su cui costruire. Il fine è nobile: salvare zone degradate e aprire cantieri altrove.
A partire dal 2006, braccio destro di Moratti per affrontare l’impegnativo capitolo immobiliare è Carlo Masseroli, ingegnere, assessore allo Sviluppo del territorio, anche lui di Comunione e liberazione. Masseroli è stato presidente della commissione Bilancio e più di una volta ha detto: «Di urbanistica non capisco niente», salvo poi imparare alla svelta. Su Ligresti ha le idee chiare: «È una grande risorsa per la città». Programmi e piani si susseguono, nonostante la domanda edilizia non sia più quella di un tempo, sia nel residenziale sia nel terziario. Masseroli spinge per raddoppiare gli indici di edificabilità, che misurano la quantità di cemento da utilizzare sui terreni, promette prezzi calmierati e social housing (abitazioni concesse a utenza in difficoltà), il superamento del concetto di periferia, si batte per sfoltire il più possibile i lacci e lacciuoli che imbrigliano delibere e cantieri, punta a modificare in senso meno restrittivo il principio della destinazione d’uso, cavalcando l’idea che lo sviluppo urbano moderno debba comportare maggiore elasticità nelle decisioni, maggiore sussidiarietà. L’assessore Masseroli, tra l’altro, insisterà per scavare un fantascientifico tunnel, lungo 15 chilometri, che dall’aeroporto di Linate raggiungerebbe la zona destinata a ospitare l’Expo 2015, il quale, però, non andrà in porto. Immaginerà anche un cimitero avveniristico, ospitato in un grattacielo alto 34 piani, con un progetto battezzato «cielo infinito».
L’uomo di punta del sindaco Moratti prospetta un rimodellamento basato sul principio della grande metropoli, con più centri, nuove linee di traffico, polmoni verdi, centinaia di grattacieli a disegnare una città verticale. «Cambieremo il volto di Milano», assicura Masseroli, «passeremo dalla cultura del vincolo a quella della responsabilità e della libertà». Tutto questo nella previsione che gli abitanti, per il 2030, salgano da 1,3 a 2 milioni. Il Politecnico di Milano e altri importanti centri di ricerca avvertiranno della scarsa credibilità del calcolo, visto che negli ultimi 20 anni la città ha perso 400 mila residenti. Ma Masseroli tira dritto e Berlusconi si complimenta personalmente.
Il Pgt, alla fine, sarà approvato dalla giunta Moratti nel gennaio 2011 e ratificato dal consiglio comunale nel febbraio successivo, proprio nei giorni in cui scoppia lo scandalo che ha per oggetto Gabriele Moratti, figlio di Letizia, accusato di abuso edilizio nel merito di un immobile industriale di 450 metri quadrati trasformato in residenziale e ispirato nelle architetture alla casa-rifugio di Batman. Quando nella primavera 2011 il vento girerà e sindaco diventerà Giuliano Pisapia, a capo di una giunta di centrosinistra, il Pgt verrà messo in discussione e ampiamente rivisto. Aumenterà l’edilizia sociale, saranno tagliati gli indici di edificabilità, revisionati del 60 per cento i progetti di nuove costruzioni, rimodulati gli scambi di proprietà tra pubblico e privato. Tutto, viene detto, contro «la carneficina del cemento».
Il sacco di Milano
La Milano da bere diventa la Milano da mangiare. Negli anni Duemila, una serie di leggi regionali liberalizza ulteriormente il mercato immobiliare, già reso più malleabile ai tempi della scalata di Salvatore Ligresti. Il capoluogo lombardo risulterà cementificato per quasi il 62 per cento, secondo per intensità solo a Napoli. Durante le giunte comunali di Albertini e Moratti e fino all’approvazione del Pgt, la città ribolle. Sbarcano le banche internazionali, come Morgan Stanley, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Bnp Paribas, Lehman Brothers, Ubs, Goldman Sachs, Nomura, tutte pronte a investire miliardi a palate. I loro obiettivi sono le strutture cedute da gruppi pubblici come Ferrovie dello Stato, Telecom Italia, Poste italiane o Enel, oppure le aree dismesse. La politica nel segno del berlusconismo appare ricettiva. Saranno varianti urbanistiche, carichi di edilizia privata, palazzoni di ferro e vetro, ma anche costruzione di case popolari. Quasi ogni progetto è figlio di una non sempre chiara commistione tra pubblico e privato. Come leve giuridiche e strumenti negoziali, saranno utilizzati i Piani di recupero urbanistici (Pru) e poi i Programmi integrati d’intervento (Pii), che permettono ai privati di andare a bersaglio con interventi edilizi, anche di rilievo, disattendendo quanto previsto dai piani generali. Sono preziose varianti concesse in deroga a immobiliaristi e costruttori, che in cambio s’impegnano a fornire a proprie spese opere d’interesse pubblico, come parchi, tratti di metropolitana o altre infrastrutture. Solo tra il 2000 e il 2010, calcola il Politecnico di Milano, il Comune ne discute circa 150, di cui una novantina definitivamente approvati. Il bilancio pende a favore dei privati, che otterrebbero ciò che vogliono, ma risulterebbe meno favorevole al pubblico, poiché i «benefici per la città si vedono poco».
Da parte di chi ha più a cuore le sorti della metropoli, viene ripetutamente denunciata la mancanza di una regia politica forte, di una visione complessiva. Come ai tempi delle giunte socialiste e di Ligresti, torna l’accusa di atteggiamenti consociativi da parte di una fetta dell’opposizione seduta in consiglio comunale. A lungo, in assenza di un piano globale e nel vuoto di regole certe, la politica avanza a tentoni e litiga su come fare questo e quello. L’urbanistica, così, si sviluppa tenendo soprattutto conto del vantaggio di singoli soggetti, favorendo la nascita di un crogiolo di primedonne del calcestruzzo. A poco serviranno i ripetuti allarmi lanciati da ambientalisti come Michele Sacerdoti o da costruttori controcorrente come Luca Beltrami Gadola; cadranno nel vuoto le denunce di figure politiche come quelle dei verdi Basilio Rizzo e Carlo Monguzzi, consiglieri in Comune e in Regione, o nel Pd di Pippo Civati al Pirellone, e dell’ex sindaco di Pioltello e consigliere provinciale Mario De Gaspari.
Spesso la mano pubblica si limiterà solamente a rendere i terreni disponibili ed economicamente desiderabili, e a definire alla meno peggio gli oneri di urbanizzazione a carico di chi sviluppa le opere. Il privato investe nella prospettiva di lauti guadagni, contraccambiando con l’impegno a realizzare strade, fogne, rete idrica, elettrica, gas e illuminazione stradale. Su quanto e come bisogna contribuire ai lavori si misura la cifra della forza contrattuale in campo: si tratta di spostare l’asticella da una parte o dall’altra, dove la competizione si quantifica in chi offre di più in cambio della concessione di licenze che consentono di aumentare, anche del doppio, l’indice di edificabilità di una zona. E visto che a quest’ultimo è direttamente proporzionale il valore di un terreno, gli oligarchi del mattone si mostrano sempre più generosi con la prospettiva di ottenere ricavi da sogno. Solo che, non di rado, una volta centrato l’obiettivo edilizio primario, succede che le opere per i servizi pubblici siano rinviate in eterno, caricate di nuovi costi, cancellate.
Nel corso degli anni Duemila, Regione e Comune sono accusati di non essere in grado di produrre una coerente strategia per il territorio, così che ha la meglio chi sa farsi valere. Le giunte di Albertini e Moratti si difendono: rivendicano la bontà degli interventi approvati e l’equidistanza delle scelte. Sostengono che sulla scia di quanto accaduto a città come Berlino, Barcellona, Parigi e Londra, anche Milano abbia bisogno di un mutamento di grande portata. Sul fronte opposto, si alza la voce di chi teme il peggio: l’età dell’oro del mattone è destinata a scatenare appetiti e speculazioni. Le denunce di commistione e collusione tra pubblico e privato, a spese della città, provengono da docenti universitari, esperti di urbanistica, plotoni di cittadini e comitati di residenti, da esponenti dell’opposizione del centrosinistra in consiglio comunale, persino da Adriano Celentano: «Milano è stata distrutta, stravolta, e lo sarà ancora di più con i progetti che la Moratti ha nel cassetto».
L’annunciato sacco di Milano troverà un ostacolo sulla propria strada. A fine decennio, infatti, saranno dolori per chi ha troppi debiti, poiché la corrente, nel frattempo, avrà invertito la rotta a causa della crisi finanziaria mondiale che trascina giù prezzi e business. Sarà un disastro: non si venderà, le banche tireranno il freno a mano sui prestiti, gli operatori finanziari e assicurativi diluiranno gli investimenti, il mercato si fermerà, i fondi immobiliari perderanno fino al 75 per cento del loro valore, una parte delle imprese edili non sopravvivrà. Ciò nonostante, e in contrasto con il quadro generale, il cemento continuerà in qualche modo a spopolare, accontentando specifici protagonisti del sistema. Ancora nell’estate 2009, nel cielo di Milano svettano oltre 5 mila gru e 3.800 cantieri, quasi tutti privati. Nel 2013, secondo il Politecnico di Milano, in città e dintorni sono in corso o pronti a partire 43 progetti, ognuno superiore a 30 mila metri quadrati, per 5,5 milioni di metri quadrati totali da riempire. Sempre nel presupposto che gli abitanti aumentino, anche i Pgt approvati dai Comuni intorno alla metropoli prevedono colate di calcestruzzo: 2,3 milioni di metri quadrati a Gorgonzola, 1,6 milioni a Segrate, 550 mila a Rozzano, 400 mila a Melegnano, 330 mila a Cologno Monzese, 300 mila a Opera e a Basiglio.
Tutto questo in una città che, oltre a essere in costante calo demografico, risulta congestionata dal traffico e oppressa dall’inquinamento, con grandi imprese che traslocano verso l’hinterland e con crescita del numero di anziani e immigrati, da aggiungere all’espulsione dal centro urbano di coloro che non hanno redditi medio-alti, ormai raccolti nelle periferie con schiere sempre crescenti di disagiati di ogni età.
Sono gru, gru e gru, a perdita d’occhio. Non più fabbriche o capannoni, lande desolate e degrado, ma una foresta di cemento armato destinato a diventare appartamenti, supermercati, uffici, sedi di case di moda, di banche. Negli anni Duemila, il valore del mattone vola ancora e i big dell’immobiliare puntano su Milano e hinterland. Le grandi trasformazioni spaziano tra i quattro punti cardinali della città: sono aree dismesse dove s’intende costruire di tutto per «migliorare la qualità della vita dei milanesi». Vi rientrano, tra l’altro, oltre 40 cascine disabitate e in rovina, con terreni dentro i quali immaginare scenari a cinque stelle: Cascina Monluè, Cascina Triulza, Cascina Campazzino... Dilagano perizie generose nelle valutazioni, si danno un gran daffare architetti e geometri. Non tutti i desiderata si traducono in opere finali: qualcuno resta sulla carta, qualcuno si perde per strada, altri vengono molto modificati. Ma il grosso vede il traguardo. Grazie a un intenso volume di finanziamenti bancari e raccolta di quattrini con gli strumenti dei fondi immobiliari, che permettono di rastrellare risorse dal mercato nell’auspicio che producano rendimenti, si spostano investimenti pesanti di alcuni protagonisti del settore. Il mantra è: l’immobile non tradisce mai. Si guarda al centro metropolitano ma soprattutto alle aree limitrofe, alle sterminate periferie, ai quartieri collaterali e ai terreni un tempo ...