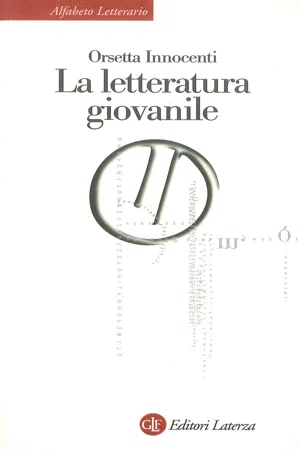1.
L’oggetto misterioso
Only the young have such moments. [...] One closes behind one the little gate of mere boyishness – and enters an enchanted garden. [...] And it isn’t because it is an undiscovered country. One knows well enough that all mankind had streamed that way. It is the charm of universal experience from which one expects an uncommon or personal sensation – a bit of one’s own.
J. Conrad, The Shadow-line
Scelte di lettura, scelte di vita
Nelle Confessioni d’un italiano (1867) Ippolito Nievo (1831-1861) ci fornisce un’indimenticabile descrizione delle letture giovanili dei tre cugini Carlino, Clara e Pisana che trascorrono al Castello di Fratta la loro adolescenza romanzesca. I poemi cavallereschi di Ariosto e Tasso diventano delle inesauribili miniere di avventure da rivivere, nei panni dei personaggi favoriti. Ecco le scelte di Clara:
e quando poi ella [=Clara] prendeva in mano o la Gerusalemme Liberata o l’Orlando furioso [...] l’olio mancava al lucignolo prima che agli occhi della giovine la volontà di leggere. Si perdeva con Erminia sotto le piante ombrose e la seguiva nei placidi alberghi dei pastori; s’addentrava con Angelica e con Medoro a scriver versi d’amore sulle muscose pareti delle grotte, e delirava anche talora col pazzo Orlando e piangeva di compassione per lui. Ma sopratutto le vinceva l’animo di pietà la fine di Brandimarte, [...]. Addormentandosi dopo questa lettura, le pareva talvolta in sogno di essere ella stessa la vedova Fiordiligi.
E quelle della Pisana e di Carlino:
non le dispiaceva [alla Pisana] di esser o Angelica seguita da Rinaldo, o Marfisa, l’invitta donzella, od anche Alcina che innamora e muta in ciondoli quanti paladini le capitano nell’isola. Per me [= Carlino] io m’aveva scelto il personaggio di Rinaldo con bastevole rassegnazione.
In queste pagine i tre ragazzi non fanno che riprendere e riadattare alle esigenze della loro singola esperienza un gioco vecchio quanto il mondo: quello (medievale) del «facciamo che s’era», detto anche più banalmente (o più modernamente) gioco di ruolo. Le regole del gioco sono ben note: si tratta di identificarsi in personaggi favolosi e straordinari, immaginando per loro imprese fantastiche da portare a termine rinnovando con la fantasia lo spazio domestico a disposizione. Ecco allora le scorribande di Carlino-Rinaldo e di Pisana-Marfisa:
e faceva le grandi battaglie contro filari di pioppi affigurati per draghi, o le fughe disperate da qualche mago traditore, trascinandomi dietro la mia bella come se l’avessi in groppa del cavallo. Talvolta immaginavamo di intraprendere un qualche lungo viaggio pel regno del Catajo o per la repubblica di Samarcanda; ma si frapponevano terribili ostacoli da superare: qualche siepaia che dovea essere una foresta; qualche arginello che figurava una montagna; alcuni rigagnoli che tenevano le veci di fiumi e di torrenti.
In questo contesto le scelte di lettura dei giovani protagonisti assumono un’importanza tutta particolare. La letteratura si propone infatti come un repertorio illimitato di situazioni e ingredienti romanzeschi destinati ad alimentare il mondo immaginario costruito dai due giovani. In poche parole, i libri prediletti sono per Carlino e la Pisana dei veri e propri manuali di romance, e la lettura costituisce, a un primo livello, la premessa essenziale di un’avventura fantastica. Ma c’è di più: le letture dei tre ragazzi sembrano avere quasi una funzione medianica perché le preferenze dei tre cugini anticipano di fatto il loro destino, nella ‘vita reale’ delle persone adulte. Le scelte letterarie, insomma, si riveleranno addirittura scelte di vita (Clara sconterà in un convento le conseguenze del suo amore infelice, mentre Carlino e la Pisana replicheranno, ciascuno a suo modo, il destino di Rinaldo e di Marfisa).
Abbozzi di definizione
Queste pagine di Nievo possono essere un ottimo punto di partenza per penetrare tra i segreti di quel complesso universo chiamato letteratura giovanile. Tanto per cominciare, la stessa ‘definizione dell’oggetto’ non è poi così pacifica. Il termine «letteratura giovanile» indica infatti comunemente (e indifferentemente) un insieme assai variegato di testi, non troppo omogeneo e nemmeno chiaramente delimitabile. Si tratta davvero di un oggetto misterioso e cangiante, non facilmente interpretabile attraverso i consueti criteri della storia letteraria. Generi diversi, paesi diversi, tempi diversi convivono infatti sotto un’analoga definizione. Inoltre, fattore non secondario, la definizione stessa ingloba in un’unica confortante etichetta tre significati anch’essi tra loro abbastanza diversi:
1. una letteratura ‘di educazione’: quel corpus di testi che gli adulti scrivono per i giovani, e che hanno per questo un intento più o meno velatamente formativo;
2. una letteratura ‘di elezione’: i libri effettivamente letti dai giovani per libera scelta (sia scritti in origine per giovani, sia scritti per adulti, e dai giovani scoperti e ‘conquistati’);
3. la produzione letteraria giovanile: i libri scritti dai giovani (e che prevedono, nella maggioranza dei casi, un destinatario giovane, complice, in un certo modo, dell’autore).
A questo si deve aggiungere un po’ di confusione terminologica anche tra gli stessi studiosi del campo, che finiscono molto spesso per catalogare i medesimi libri sotto approssimazioni simili, ma non del tutto identiche tra loro. Così la dizione «letteratura giovanile» si alterna indifferentemente a quella di «letteratura per l’infanzia», o «per ragazzi», senza una reale percezione dello slittamento di significato che questo scarto comporta. Non a caso è stata recentemente suggerita la definizione di «letteratura senza tempo», a sottolineare una volta di più la natura tutta particolare dell’oggetto in esame.
E in effetti sotto uno stesso titolo già si addensano parecchie contraddizioni. Da una parte, il nome «letteratura giovanile» sembra riaffermare l’univocità di un solo genere letterario, con un suo canone e una sua poetica ben delineati. Dall’altra però, come si è visto, all’interno di questo genere apparentemente compatto, si intravedono linee di tendenza divergenti, generi e modi diversi e contrapposti, che configurano una situazione assai più magmatica e composita. In questo repertorio Il Giornalino di Gian Burrasca (1912) di Vamba (pseudonimo di Luigi Bertelli [1858-1920]) va a braccetto con Dylan Dog di Tiziano Sclavi (n. 1953); Sulla strada (On the road, 1957) di Jack Kerouac (1922-1969) convive pacificamente con Pippi Calzelunghe (Pippi Langstrump, 1945) di Astrid Lindgren (n. 1907); la terra di mezzo (Il Signore degli Anelli [The Lord of the Rings, 1954-55] di John Ronald Reuel Tolkien [1892-1973]), il paese delle meraviglie (Alice nel Paese delle Meraviglie [Alice’s Adventures in Wonderland, 1865] di Lewis Carroll [1832-1898]) e Oz (Il mago di Oz [The Wonderful Wizard of Oz, 1900] di L. Frank Baum [1856-1919]) non sono altro che nomi diversi di una medesima geografia fantastica.
Appare chiaro, allora, che le leggi che regolano questo complesso universo si devono comporre quasi necessariamente anche di elementi extraletterari. Abbiamo infatti di fronte un corpus di testi del tutto peculiare, che si è costituito nel tempo quasi per cooptazione, attraverso la libera scelta dei giovani lettori (le letture appassionate di Carlino e Pisana). Questa affermazione tende ovviamente a privilegiare la seconda delle tre definizioni proposte di letteratura giovanile, senza tuttavia escludere del tutto le altre due. Per quanto riguarda la terza, cercherò di esaminare il suo significato nella seconda parte di questo libro, analizzando uno dei casi più singolari della contemporanea letteratura giovanile in Italia – Jack Frusciante è uscito dal gruppo (1994) di Enrico Brizzi (n. 1974).
Ma è soprattutto la contrapposizione tra le prime due definizioni che mi interessa mettere qui in rilievo. Assistiamo infatti a uno scontro tra una letteratura ‘di imposizione’ e una ‘di libertà’. Ovviamente, a un primo e più immediato livello, definire un repertorio di testi come il frutto di una deliberata ‘appropriazione’ da parte dei lettori, significa, apparentemente, concedere spazio solo alla letteratura che ho chiamato «di libertà». In realtà le cose sono un po’ più sfumate. Perché tra questi due grandi gruppi (letteratura per i giovani e letteratura scelta dai giovani) esiste una vasta zona grigia, uno spazio di interscambio che consente il mescolarsi – perlomeno parziale – delle due tipologie. Accade così che alcuni libri scritti per i giovani, con un intento in primo luogo educativo, vengano infine accolti spontaneamente a far parte dell’eletta schiera (un esempio significativo è Senza famiglia [Sans Famille, 1878] di Hector Malot [1830-1907], romanzo pedagogico – vinse un concorso del ministero della Pubblica Istruzione per far conoscere la geografia della Francia attraverso un’opera narrativa – viene letto e amato essenzialmente per la sua dimensione euforica, come una specie di Sulla strada [On the road] per i più piccoli). Allo stesso modo, con perfetta simmetria, alcune ‘libere elezioni’ giovanili sono state in seguito approvate dalla letteratura ‘ufficiale’ degli adulti (clamoroso in Italia il caso recente dei libri per ragazzi di Roald Dahl [1916-1990]).
Attraverso i pericoli del romanzesco
Ma è possibile trovare un elemento che accomuni in maniera definitiva l’universo che deriva dall’unione di questi due emisferi, questa sorta di Kindergarten letterario (la definizione è di Franco Moretti [n. 1950])? La risposta sta scritta nella natura irrimediabilmente elitaria del repertorio che sto cercando di mettere in luce. Perché il pegno da pagare per questo isolamento un po’ snob – coltivato dalla letteratura giovanile in modo più o meno consapevole – è il rischio del declassamento a paraletteratura, letteratura ‘di serie B’. La letteratura giovanile subisce da quella ufficiale un marchio indelebile di scarsa serietà, riceve, in altre parole, la più o meno esplicita definizione di romance. Il concetto di romance in letteratura indica sostanzialmente una narrazione di fatti fuori dall’ordinario, che appartengono a un orizzonte fantastico o comunque lontano da quello quotidiano del lettore. In questo senso la definizione si contrappone a quella di novel, il romanzo della grande tradizione realistica, che propone invece una narrazione di fatti del tutto immersa nella realtà concreta e verosimile.
A questo punto l’orizzonte in cui si muove il nostro ‘oggetto misterioso’ sembra schiarirsi notevolmente, mostrando di connettersi in maniera abbastanza esplicita con quello del modo romanzesco. La letteratura giovanile si configura così (insieme alla letteratura popolare e di appendice, i cosiddetti chapbooks) come una delle due sottoprovince che offrono rifugio al romance, messo al bando, tra Settecento e Ottocento, ...