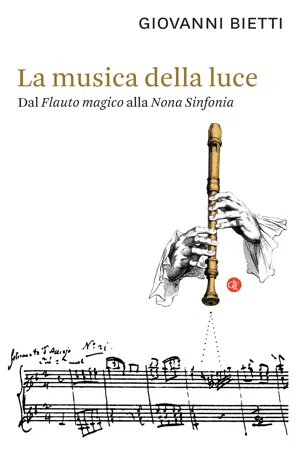1.
Musica e Illuminismo:
il contesto e le idee
Perché Vienna?
A prima vista, il fatto che i massimi risultati musicali dell’Illuminismo siano collegati all’ambiente viennese può sembrare sorprendente. Sulla carta l’Inghilterra, e soprattutto la Francia sarebbero stati luoghi più adatti, visto che si tratta dei paesi dai quali le idee dei Lumi si erano diffuse, e nei quali il dibattito politico e filosofico era più acceso. Nel nostro immaginario Vienna si lega piuttosto al Congresso del 1814-15, ossia all’atto di inizio della Restaurazione, che all’Illuminismo.
In quel coacervo di Stati e di entità geografiche che costituivano l’Impero e la monarchia asburgica le idee illuministe penetrano lentamente: si affermano soltanto nella seconda metà del secolo, sotto Maria Teresa e soprattutto sotto il figlio Giuseppe II, che sale al trono, regnando insieme alla madre per un quindicennio, nel 1765, e che morirà poco dopo la Rivoluzione, nel febbraio 1790. Nel 1756, anno della nascita di Mozart, scoppia la guerra dei Sette anni: l’Austria è alleata con la Francia, contro Prussia e Inghilterra. Come sottolineano alcuni storici, si tratta di una «rivoluzione diplomatica», visto che da secoli i francesi erano sempre stati nemici della monarchia asburgica. Questa mossa politica inaugura un periodo di stretti contatti fra le corti di Parigi e di Vienna, che culminerà nel matrimonio tra la figlia di Maria Teresa, Maria Antonietta, e il futuro re di Francia Luigi XVI, nel 1770. In questi anni, quindi, la cultura francese comincia gradualmente a penetrare nelle terre degli Asburgo, le idee e le pratiche illuministe raggiungono Vienna e le principali città imperiali. Dalla Francia giunge per esempio la moda dei salotti letterari, veicoli privilegiati della diffusione delle nuove idee (il primo salotto viennese, e uno dei più importanti, fu quello di Charlotte von Greiner, frequentato da Haydn). Allo stesso tempo cominciano a svilupparsi alcuni generi musicali tipici del gusto francese, e in modo particolare della corte parigina, come l’Opéra-comique.
Ma Vienna, comunque, non è Parigi. Non solo perché le finanze degli Asburgo sono, negli ultimi decenni del secolo, più floride di quelle della corona di Francia, o perché la burocrazia imperiale sembra più efficiente e più snella di quella francese. Sulle rive del Danubio si respira un’atmosfera completamente diversa rispetto ai bordi della Senna: la Vienna del Settecento è una città cosmopolita, di tradizione culturale occidentale che però guarda, anche geograficamente, verso oriente. Basta citare i nomi slavi di tanti aristocratici per cui compone Beethoven, come Lichnowsky, Lobkovitz, Razumovsky, Galitzin, o gli ungheresi Apponyi ed Esterházy, mecenati e datori di lavoro di Haydn. Tra le mura della capitale si parlano, accanto al tedesco, l’ungherese e il ceco. E non a caso echi della musica popolare, ungherese, ceca, croata o perfino russa risuonano nelle composizioni di Haydn, Mozart e Beethoven.
Inoltre l’aristocrazia viennese si dimostra più solida di quella francese (che sarà travolta dalla Rivoluzione), e probabilmente anche più amante della musica: una descrizione della vita musicale di Vienna, nel 1784, dice che la musica è «la sola cosa nella quale la nobiltà dimostra di avere gusto». I nobili viennesi adorano la musica, e compositori ed esecutori sfruttano questa favorevole situazione (Beethoven forse ancora più dei suoi predecessori: riuscirà addirittura a farsi assegnare una pensione annua dai suoi protettori aristocratici). Sostenuta da un sovrano, Giuseppe II, che la esegue e la apprezza, e promossa dall’aristocrazia, la musica si diffonde in città in ogni forma: opera italiana, francese e tedesca, musica strumentale, serenate, accademie (ossia concerti per sottoscrizione, come quelli che organizza Mozart a metà degli anni Ottanta per presentare i propri Concerti per pianoforte), oltre alla vivace attività privata che si svolge nei grandi palazzi nobiliari. (La musica viene promossa anche dalle logge massoniche, luoghi nei quali circolano molte delle idee più avanzate e progressiste: la prima loggia viennese risale al 1742, e all’inizio degli anni Ottanta la città ne conta ben sei, con diverse centinaia di membri in gran parte aristocratici. Ma già a metà del decennio l’imperatore comincerà a temere l’attività massonica, e quindi restringerà il numero delle logge unendone alcune tra loro. Nel 1794, cinque anni dopo la Rivoluzione, tutte le logge massoniche viennesi saranno – ufficialmente, almeno – chiuse.)
Una particolare caratteristica del contesto viennese nella seconda metà del Settecento mi sembra fondamentale per lo sviluppo di un «Illuminismo musicale»: il fatto, forse senza veri e propri precedenti, che in questo periodo la musica delle diverse classi sociali sia basata sui medesimi elementi, sul medesimo sistema di organizzazione dei suoni (la cosiddetta tonalità classica). Le melodie cantate dai contadini austriaci, dagli artigiani, dai maniscalchi hanno qualcosa in comune con le danze di corte, con i raffinati quartetti che si suonano nei salotti nobiliari, con le sinfonie che si ascoltano nelle grandi sale concertistiche, con le Arie d’opera, perfino con la musica sacra dell’epoca: tutte le classi sociali, per così dire, «parlano la stessa lingua» musicale (e questo è uno dei motivi per cui a proposito della musica di Haydn, Mozart e Beethoven si è voluta coniare l’espressione «classicismo viennese»: il termine «classico», nella Roma antica, aveva a che fare proprio con la classe sociale, con la cittadinanza).
Questo particolarissimo contesto spiega perché i tre grandi viennesi riescano a far dialogare nelle loro composizioni, e senza il minimo sforzo, tutte le diverse componenti della società: come vedremo, nel Flauto magico di Mozart si passa senza contraddizioni o fratture insanabili dallo stile «alto», contrappuntistico, allo stile comico e perfino al tono da canzone popolare. Nel Finale primo del Don Giovanni risuonano insieme, sovrapposte, tre danze: l’aristocratico Minuetto, la borghese Contraddanza e la popolare Deutsche Tanz. E la Nona Sinfonia di Beethoven celebra esplicitamente l’«abbraccio dei popoli», e il «bacio al mondo intero», auspicando quindi l’égalité, la conciliazione, l’armonia tra tutti gli uomini attraverso la musica. Forse un risultato tanto universale poteva essere realizzato solo nella Vienna di fine Settecento e di inizio Ottocento.
Musica vocale e musica strumentale
La posizione dei pensatori settecenteschi nei confronti della musica era ambivalente: musica vocale e musica strumentale, le due principali branche della produzione musicale dell’epoca, erano valutate in modo molto diverso. La prima veniva considerata decisamente superiore alla seconda, anche se negli ultimi anni del secolo questa gerarchia si modificherà radicalmente, come vedremo.
Negli scritti degli illuministi la musica vocale era in genere altamente stimata, tanto che in Francia l’opera lirica fu al centro di uno dei più accesi dibattiti culturali del secolo: la cosiddetta querelle des bouffons. Non possiamo qui occuparci in dettaglio dei contenuti di questa polemica, innescata dalla rappresentazione a Parigi, nel 1752, di un breve Intermezzo (una sorta di opera buffa in miniatura) di Giovanni Battista Pergolesi, La serva padrona. Basterà dire che la querelle coinvolse molti degli intellettuali e dei musicisti più in vista, come Rousseau, Diderot, d’Alembert e Rameau, e che la sua sostanza estetica – la difesa e l’esaltazione dello «stile moderno» dell’opera buffa italiana, vivace e dinamico, contro lo «stile antico» della classica Tragédie lyrique francese – nascondeva un evidente intento politico. Lo stile moderno rappresentava, tra le righe, la «filosofia moderna», e la critica allo stile antico, naturalmente, era una velata critica all’ancien régime. La querelle des bouffons, insomma, fu il mezzo attraverso il quale alcuni pensatori disseminarono nella società francese del tempo molte delle idee che oggi siamo soliti definire «illuministe».
L’importanza di questo episodio va molto al di là del suo significato contingente. Il fatto di considerare uno stile musicale come espressione di idee politiche e sociali non era in sé una novità: c’erano diversi precedenti, a partire almeno dagli scritti di Platone e di Aristotele. Ma forse non era mai successo che la musica venisse proposta come una metafora, esplicita, della possibilità di rinnovare la società civile, di cambiare il mondo. Fino a quel momento, semmai, l’opera lirica era stata al contrario un mezzo per affermare lo statu quo, per celebrare le virtù di uno Stato e del suo re: basta pensare ai molti libretti di Metastasio – per esempio La clemenza di Tito, titolo emblematico – che si concludono con un gesto di magnanimità da parte del sovrano.
Nel 1759 d’Alembert pubblica un saggio intitolato, significativamente, De la liberté de la musique. Vi troviamo queste decise affermazioni: «Tutte le libertà sono ugualmente pericolose. Libertà nella musica implica libertà di sentire, libertà di sentire implica libertà di pensare, libertà di pensare implica libertà di agire, e la libertà di agire è la rovina delle nazioni. Se vogliamo preservare il regno, dunque, preserviamo l’Opéra così com’è», conclude ironicamente il filosofo. Non a caso proprio a partire dalla seconda metà del Settecento, e fin oltre la metà del secolo successivo, l’oper...