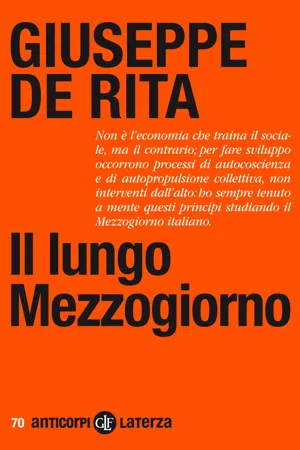La condizione del Mezzogiorno
vista da un sociologo
(2002)
Premessa: il Mezzogiorno “dal basso”
L’osservazione e l’interpretazione dei processi di sviluppo sul territorio si presentano sempre più come attività articolate e complesse.
La sinuosità delle traiettorie percorse dall’evoluzione delle diverse componenti fenomenologiche e soggettuali da considerare, infatti, rende il lavoro del ricercatore sociale particolarmente oneroso, dal momento che sono in continuo divenire:
– il concetto stesso di sviluppo, nella sua alternanza di collegamenti con le dinamiche della crescita orizzontale e verticale delle economie e delle società e la visione complessiva dei percorsi produttivi e settoriali che alimentano e sostengono il tessuto locale;
– la visione condivisa del contenitore territoriale cui riferirsi, oggetto di continue modificazioni e torsioni strutturali sotto la spinta trasversale delle numerose forze competitive che su di esso insistono;
– l’architettura e la composizione dei diversi soggetti che sul territorio operano, nella loro variegata combinazione di poteri di elaborazione progettuale, di governo, di spesa, di rappresentanza, di azione, di interdizione;
– infine, il grado di relazionalità che definisce le logiche di sistema e di rete tra tutte le polarità centrali e periferiche che, a vario titolo, risultano protagoniste del progresso e della storia di ogni area territoriale comunque intesa.
Gli ultimi cinquant’anni, in particolare, hanno rappresentato un periodo in cui si sono concentrati innumerevoli cambiamenti più o meno ciclici che hanno contribuito a incrementare sistematicamente le permutazioni dei diversi elementi base della convivenza economica e sociale, dando così luogo ad un ciclo lungo dello sviluppo che, nei fatti, è andato a convergere su una graduale complessificazione delle prospettive del fare comunità.
Non occorre certamente andare a scomodare le categorie più diffusamente utilizzate per verificare questa constatazione: globalizzazione delle economie, internazionalizzazione dei processi produttivi, aperture e inclusioni sociali, rincorrersi di logiche evenemenziali e processuali, solo per citarne alcuni, sono stati tutti ingredienti fondamentali di un continuo processo di trasformazione che, in particolare negli ultimi cinquant’anni, hanno condotto un po’ tutti i paesi, e in particolare l’Italia, a rivedere completamente il proprio posizionamento competitivo esterno – così come la propria visione comunitaria interna –, in un trascinamento esponenziale dal dopoguerra a oggi.
Sono cambiate finanche le colonne portanti della consueta convivenza socio-economica: la concezione prevalente della politica economica, della struttura imprenditoriale, del mercato del lavoro, del welfare, dei percorsi formativi, delle relazioni internazionali, dei flussi migratori, della gestione individuale della professionalità. Persino la concezione della pace e del ricorso agli strumenti bellici – o terroristici – ha assunto valenze affatto differenti dal passato, contribuendo nell’insieme alla ricombinazione dei fattori di riferimento.
Ragionare della condizione del Mezzogiorno, oggi, significa dunque in primo luogo inserire la continuità del processo di sviluppo meridionale nel più ampio scenario della trasformazione globale; per poi declinare, evidentemente, le specificità dell’area nei suoi tratti peculiari, problematici e di prospettiva.
Per chi, infatti, si occupa di Mezzogiorno da quasi cinquant’anni e ha assistito al dipanarsi delle numerose vicende programmatiche e attuative nel Sud, si innesta quasi in maniera compulsiva la memoria lunga dei processi, scevra dei diversi cicli di luce e di ombra che – per l’appunto ciclicamente – scandiscono i tempi di un dibattito economico e culturale che pare non giunga mai alla debita conclusione. Tanto più se la riflessione viene spesa in occasione del ricordo di chi, come Saraceno, ha contribuito alla sedimentazione e all’arricchimento di una simile memoria storica, con il suo pensiero ampio e di visione programmatica. Tanto più, poi, se a compierla viene chiamato un continuista per vocazione.
Per rimanere fedele alla mia storia, pertanto, non meno che a quella di Saraceno stesso e del Mezzogiorno nel suo complesso, non posso esimermi dal ripercorrere lo sviluppo meridionale con la passione di un narratore del territorio. Di quel territorio che per l’intero arco di tempo considerato ho avuto l’opportunità di girare in lungo e in largo, soffermandomi anche solo con lo sguardo in una protratta interpretazione di volti, paesaggi, città. In fedeltà a questa mia storia, quello che mi accingo a declinare è una sorta di racconto “dal basso” del Mezzogiorno, di ritessitura dei fili dello sviluppo locale così come si sono via via proposti all’osservazione, facendo perno su di una ripartizione a priori dell’orizzonte temporale di riferimento – il passato, il presente e il futuro – che faccia leva sulla parallela evoluzione del parametro territoriale. Nella convinzione che, accanto al capitale e al lavoro, il territorio interpreti un ruolo di crescente protagonismo tra i fattori che convergono sulle potenzialità di sviluppo economico e sociale.
In altri termini, nell’organizzazione del mio ragionamento vorrei sperimentare una stretta correlazione, a mio avviso tanto sostanziale quanto simbolica, tra quelle che sono state, in qualche modo, le diverse fasi dello sviluppo meridionale e la rappresentazione, accanto a ciascuna di esse, che ha avuto il contenitore territoriale nelle analisi e nel vissuto locale. In particolare, credo che il cammino di crescita continua del Sud sia stato contrassegnato da un’evoluzione con la confidenza e l’utilizzo intelligente del proprio territorio, accompagnata da una progressiva alimentazione del “saper fare comunità” per lo sviluppo ai diversi livelli: di sistema di impresa, di piattaforma logistica, di tessuto della convivenza.
In questo senso, il filo rosso che lega il passaggio dallo spazio al territorio al luogo credo possa ben restituire in immagine l’itinerario di crescita meridionale, dall’indistinto di una dimensione di atavica arretratezza, ad una più definita azione di sviluppo, sino a giungere alla scommessa futura di delimitare idealmente o materialmente specifiche comunità territoriali. L’itinerario cioè dalla questione meridionale al Mezzogiorno “a pelle di leopardo” – “i” Sud contrapposti “al” Sud –, fino a giungere alla prospettiva di un territorio meridionale composto di sinergici luoghi, in grado di crescere in quella dimensione di comunità che rende sistema la rete dei soggetti, dei territori, delle funzioni.
Da qui la scelta relativa all’impostazione della riflessione. Spazio come entità illimitata e indefinita nella quale sono situati i corpi (lo spazio euclideo, non euclideo, l’intuizione pura, ecc.). Territorio come porzione definita di terra. Luogo, infine, come porzione di territorio idealmente o materialmente delimitata; dove convivono segnali deboli e forti di segno alterno, testimonianza di una diversità di situazioni e condizioni, non raramente espressione di scenari di sviluppo locale di alto rendimento e qualità. E poi il Sud del domani, il Mezzogiorno delle scommesse di crescita al di là del sostegno nazionale ed europeo, alla prova del consolidamento delle reti sistemiche territoriali e della ridefinizione delle geometrie dello sviluppo.
Dunque spazio, territorio, luogo, come simboli di uno sviluppo reale e come base per una osservazione “dal basso” dei processi della crescita che nel contenitore territoriale hanno trovato e trovano tuttora le proprie coordinate di riferimento.
1. Lo spazio del passato: la faticosa uscita dal sottosviluppo
L’eredità della guerra non è stata generosa con il nostro Mezzogiorno. Non lo era stata, a dire il vero, neppure la deriva inerziale della storia moderna, che aveva gradualmente tramutato i segni tangibili di una cultura, antica prima, ridefinita poi, in graffiti di memoria corta sparsi in un’ampia desolazione.
Non credo sia utile, né tanto meno necessario, rievocare le immagini e le sensazioni di un’arretratezza aspra e resistente che, svolgendosi invero sull’intero territorio nazionale, trovava tuttavia proprio nelle regioni meridionali il suo apice di dura convergenza.
Ci si trovò, allora, di fronte realmente ad uno spazio indistinto di un misto sotto-produttivo fatto di artigianato e agricoltura, all’interno di una non-rete urbana e, soprattutto, sociale. E tutto sommato, dall’agevole condizione dell’analisi a posteriori degli accadimenti, non si può non notare come molte delle scelte che furono adottate non potevano che essere quelle di allora.
L’Italia intera scontava pesanti ritardi su più fronti dello sviluppo, e il divario tra Nord e Sud, a tutti i livelli, si presentava come un problema di rilevanti dimensioni. L’attenzione sulle dinamiche di crescita, quasi inevitabilmente, si concentrò su due assets portanti:
– l’infrastrutturazione del territorio, ovvero la costruzione graduale, in realtà accelerata, di tutta quella innervatura dorsale del paese che fosse in grado di ottemperare alle funzioni di base per la comunicazione;
– l’industrializzazione diffusa del paese, probabilmente violentando in parte la natura stessa dello sviluppo “dal basso” del Mezzogiorno, ma nella convinzione che il fattore industriale avrebbe comunque generato benefici effetti sul riequilibrio Nord/Sud – oltre che, evidentemente, su quello tra l’Italia e i suoi più diretti partners europei.
Certamente non fu accantonato il potenziale agricolo meridionale che, al contrario, fu oggetto di attenzioni specifiche nella politica dell’epoca. Forse soltanto il turismo, ma lo si può dire solo col senno del poi, avrebbe maturato da quelle scelte un handicap strutturale di non poco rilievo.
Non voglio, comunque, entrare nel dettaglio di quelle azioni e interventi che sono ormai patrimonio collettivo della memoria lunga meridionalista. Fu l’epoca dell’intervento straordinario, della Cassa per il Mezzogiorno, ma soprattutto furono gli anni Cinquanta, anche grazie a Saraceno, gli anni dello sforzo di programmazione per lo sviluppo del paese, e del Mezzogiorno al suo interno. E mi sarà permesso, ricordando i tanti appunti e “foglietti” su cui cominciai la mia vita alla Svimez e imparai il mestiere, richiamare quanto quello sforzo di programmazione guidato da Saraceno fu alimentato da Giorgio Sebregondi in termini di consapevolezza delle esigenze di crescita collettiva; e da Nino Novacco in termini di accumulazione dei germi di intuizione analitica. Mai più, come in quegli anni, gli anni dello Schema Vanoni, l’Italia avrebbe assistito ad un’operazione di intelligenza programmatica di ampio respiro.
Lo sforzo messo in campo, la volontà di ottenere una visione larga dei problemi, non meno dell’impellenza del momento storico e dell’urgenza di cogliere nuove opportunità, miscelati ad una buona dose di entusiasmo, rappresentano ancora, a mio avviso, uno degli esempi più meritevoli di cultura programmatica per il paese. Una programmazione di cui, ancora oggi, si rilevano effetti – nel bene e nel male – e della cui perdurante latitanza non si può che lamentare il vuoto.
In questa sede può avere senso soffermarsi su alcuni aspetti peculiari dell’impostazione della politica meridionalista di quegli anni:
– l’approccio “dall’alto” nell’affrontare i processi dello sviluppo territoriale;
– la preferenza accordata alle dinamiche di sviluppo longitudinale rispetto a quelle di raccordo trasversale. Dal punto di vista geo-economico, tale angolazione di prospettiva ha avuto declinazione soprattutto dal punto di vista infrastrutturale;
– il salto di continuità attuato con gli interventi programmati rispetto alla cultura antropologica endogena del territorio medesimo, alle sue capacità di assorbire gli stimoli provenienti dall’esterno e di tramutarli in un nuovo approccio dall’interno al problem solving necessario per la manutenzione dei livelli di competitività.
Prima di specificare meglio tali argomenti, vorrei spendere però alcuni ragionamenti per chiarire che, in qualche misura, ritengo che numerose delle decisioni intraprese si evidenziavano, nel loro contesto, con un elevato grado di “necessità” per affrontare i problemi di quegli anni.
Utilizzerò, a tal fine, una esemplificazione tratta dalla mia esperienza personale, con tutti i suoi evidenti limiti. Mi sono trovato, infatti, proprio di recente a ragionare di Frosinone e del suo sviluppo. Rileggendo le carte del passato, riflettendo insieme agli attori locali del presente, esaminando il territorio con gli occhi dei miei ricercatori del Censis, ho ritrovato un territorio longitudinale, “attraversato” dallo sviluppo, policentrico nella sua dimensione frammentata di sviluppo, per certi versi ancora invisibile quasi come uno spazio senza comunità. Ascoltando le diverse analisi ho avuto modo di ripercorrere con la memoria la storia dello sviluppo di quella provincia, le ragioni delle scelte di attraversamento infrastrutturale e di baricentramento su Roma, di interconnessione con la frontiera settentrionale delle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno.
Non credo che le scelte di allora fossero state sbagliate. Credo fossero opportune e necessarie per quella che poteva essere la visione disponibile di quegli anni. Anche se calate dall’alto e se perseguivano, nella loro dimensione strategica, ...