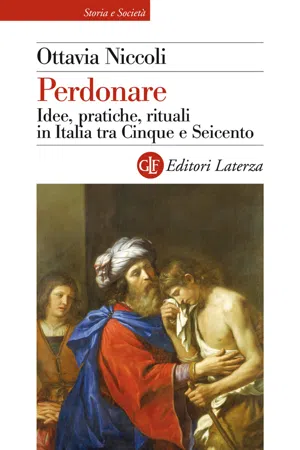1. Il dono e la grazia
Le parole del perdono
Come è stato detto, di serio non ci sono che le parole, il resto non sono che chiacchiere. Dunque per cominciare a parlare del perdono apriamo, secondo ogni buona consuetudine, i dizionari. Apprendiamo intanto che la parola «perdono» è relativamente nuova: il termine latino perdonatio è piuttosto tardo, preceduto comunque dal verbo perdonare, che è di epoca carolingia. Né l’uno né l’altro termine (perdonatio e perdonare) sono però presenti nella predicazione, cioè nel tramite culturale forse a maggior bacino di utenza del Medioevo, ma soltanto nei documenti giuridici e letterari1. Vediamo allora quali erano nell’antichità le parole del perdono; attraverso i loro significati secondari potremo cogliere le sfumature di senso che venivano attribuite a questo concetto.
Il lessico usato nel mondo classico insiste soprattutto sul tema dell’oblio dei torti subiti o dell’indulgenza per la debolezza umana: le parole greche per significare perdono erano infatti amnestia, dimenticanza, e syngnome, comprensione, mentre nel mondo latino il vocabolario del perdono comprende venia (indulgenza), oblivio (dimenticanza, oblio), excusatio (scusa), impunitas (libertà o sicurezza dalla pena), remissio (liberazione da un debito, da una tassa, da una pena). Perdonare si diceva ignoscere (non voler sapere); la Vulgata usa il verbo demittere (rilasciare), che traduce il greco apolyein, prosciogliere, o anche aphienai, che ha lo stesso significato. Remittere ha già il significato di perdonare in Plauto e Sallustio, e lo accentua in autori cristiani come Tertulliano e Ambrogio2. Se vogliamo, certo abusivamente, concentrare in un unico senso questi sensi molteplici, potremmo dire che in essi prevale la volontà di dimenticare: una dimenticanza così profonda che si confonde addirittura con la scelta di non sapere. Una sfumatura particolare, più positiva, di questa volontà di oblio è stata individuata nel termine greco mè mnesikakein, che è la formula alla base del giuramento degli Ateniesi nel 403 a.C., e indica la volontà di superare il ricordo dei mali compiuti e subiti per rendere agevole la ripresa della vita democratica nella città3.
Ma dunque, in conclusione, la memoria sarebbe inconciliabile con il perdono? Per perdonare occorre cancellare l’accaduto dalla memoria? È questo il punto sul quale si è esercitata la riflessione di tutti coloro che hanno trattato questo tema. La risposta però è costantemente negativa. «Forgiving does not imply forgetting», perdonare non è dimenticare4, ma, al contrario, implica la volontà di spezzare il tempo chiuso della sofferenza, di liberarsi dall’irreversibilità del passato agire, è insomma una memoria rinnovata5. Per usare le parole del filosofo ebreo Armand Abecassis, «il vero perdono implica la memoria. Il vero perdono è un atto positivo, grazie al quale la vittima ricorda il crimine di cui è stata oggetto, ma decide di non tenerne conto nelle sue relazioni con il colpevole»6.
Di fatto la parola «perdono» reca in sé, nella sua etimologia, qualcosa di molto diverso da una scelta di annullare il passato. Essa infatti ci colpisce perché mostra un significativo intreccio linguistico fra «dono» e «perdono» (il prefisso per- è rafforzativo, e indica quindi la larghezza, l’assoluta liberalità di tale dono); un intreccio che del resto è presente anche in altre lingue europee («forgiving», «pardon», «Vergebung»). «Perdono» e «perdonare» sottintendono dunque (o dovrebbero) non una cancellazione, ma un apporto positivo, una offerta libera e generosa, tanto più generosa in quanto chi ha sofferto ricorda e vuole ricordare l’accaduto7. L’uso concreto e quotidiano del termine, naturalmente, è più variegato e complesso; approdando nella lingua italiana attuale, la parola si configura infatti in un’ampia varietà di sfumature di significato. Si parte da «gesto umanitario con cui, vincendo rancori e risentimenti, si rinuncia ad ogni forma di rivalsa, di punizione o di vendetta nei confronti di un offensore»; si prosegue poi con «atto individuale di clemenza con cui un sovrano o una pubblica autorità (civile, religiosa o militare) condona una colpa a un suddito», «provvedimento generale di clemenza», «remissione dei peccati», per concludere con «indulgenza [...], giubileo»8.
I passaggi come si vede sono intricati; dietro il termine vi è uno sfondo religioso che non sembra presente nella terminologia classica, e che si fa percepire in quella attuale italiana in modo più o meno forte, a seconda del caso e del tempo. La parola insomma nella sua semplicità apparente pone molte domande. Ci chiediamo che cosa significhi oggi quel «gesto umanitario», per usare le parole del dizionario, che così spesso giornalisti e intervistatori televisivi chiedono indiscretamente ai familiari di vittime di efferati omicidi o tragici incidenti; e ci chiediamo come quel «gesto umanitario» si sia configurato nel passato, e soprattutto in un passato, come quello della prima età moderna, che svela ogni giorno di più la forza con cui ha generato le eredità buone e cattive di cui si alimenta il nostro presente.
Per rispondere a queste domande dobbiamo fare nuovamente molti passi indietro. Proviamo ad avvicinarci progressivamente al tema che intendiamo trattare, partendo da una pagina molto bella di Émile Benveniste che sottolinea l’importanza del concetto di «grazia» in ambito indoeuropeo. La grazia – scrive Benveniste – «consiste nel rendere un servizio gratuito, senza contropartita». L’idea di «grazia» si associa a quelle di «gratuità» e «riconoscenza», in un nodo «legato a rappresentazioni molto più vaste, che mettono in gioco l’insieme delle relazioni umane o delle relazioni con la divinità; relazioni complesse, difficili, in cui le due parti sono sempre implicate»9. È a quest’area concettuale, così ricca di complessità e anche di ambiguità, che dovremo fare riferimento inseguendo la storia delle istituzioni del perdono.
Grandgousier e Alpharbal
Ma torniamo per ora al concetto di «grazia». La sua rilevanza ci appare subito fortissima a livello antropologico. A prima vista esso coinvolge – ma è una vicinanza solo parziale – la grande tematica del dono (che sovraintende anche, come abbiamo cominciato a vedere, a quella del perdono). Così almeno potremmo credere leggendo ciò che nel pieno Cinquecento François Rabelais scriveva appunto dei doni e dei sentimenti che essi suscitano in chi li riceve:
E questa è la natura della gratitudine: il tempo, che tutte le cose corrode e consuma, aumenta ed accresce i benefici resi: giacché un atto di grazia, liberalmente usato ad un uomo dabbene, cresce continuamente mercé il suo nobile pensiero e la ricordanza10.
Ma Gargantua, al quale dobbiamo questa considerazione nelle pagine di Rabelais, vive come sappiamo nel mondo del paradosso. Inoltre la sua idea del dono, come dimostrano anche queste righe, è fortemente influenzata dal riverbero dell’idea religiosa della grazia propria dell’umanesimo cristiano di cui egli è partecipe11. Ma il dono, in realtà, nella società preindustriale in cui Gargantua è immerso (e non solo in essa, anzi, sostanzialmente in ogni cultura), si differenzia profondamente dalla grazia, in quanto rimane su un piano assai più terreno e legato alle comuni relazioni umane; e quindi, come sappiamo dalle ricerche di Marcel Mauss12, deve essere ricambiato, e in forma sovrabbondante. Ecco un esempio di questo modello culturale, e nello stesso tempo del suo opposto, proprio nel racconto di Rabelais. In esso alla disinteressata generosità di Grandgousier, il padre di Gargantua, viene ad essere contrapposta la mondana gratitudine di Alpharbal e dei suoi sudditi. Questi ultimi, infatti, si affrettano a ricambiare il gesto di Grandgousier, che «con incredibile bontà» e «ogni amichevole grazia» ha accolto benevolmente nel suo palazzo il loro sovrano che egli ha sconfitto, con «novemila e trentotto grandi navi onerarie» sulle quali «ogn’uomo in folla gettava [...] oro, argento, anelli, preziosi, spezie, droghe e aromi, pappagalli, pellicani, scimmiotti, civette, zibellini e porcospini [...]. Offrì i suoi presenti, e non furono accettati, perché troppo eccessivi»13. La generosità di Grandgousier voleva essere gratuita, essendo il frutto di una benevolenza spontanea (era un dono/perdono); l’assurdo puntiglio di ricambiarla mostra che essa in qualche modo non era stata compresa.
Proprio partendo dal racconto di questo episodio Natalie Davis ha messo in risalto come nelle società preindustriali questi scambi obbligati di doni si traducano «in una catena di eventi che coinvolge molti elementi tutti insieme: beni sono scambiati e ridistribuiti in società che non hanno specifici mercati; la pace viene mantenuta e talora anche la solidarietà e l’amicizia; lo status è confermato ovvero si entra in competizione per esso»14. È la reciprocità dunque il senso profondo e la molla del dono, ed anche il fondamento dei sistemi economici arcaici e della stessa assistenza caritativa, come hanno mostrato fra gli altri Karl Polanyi, Marshall Sahlins, Nathan Wachtel15: «il dono è alleanza, solidarietà, comunione, in breve, pace [...]. Il dono è il mezzo primitivo di conquistare la pace, che nella società civile è assicurata dallo Stato»16.
La grazia, invece, è tutt’altra cosa, come mostra il comportamento di Grandgousier nell’elargire e nel rifiutare il contraccambio. Essa è molto di più di un dono; ed è divina proprio in quanto si sottrae ai calcoli degli uomini, e per l’appunto, come ha osservato l’antropologo Julian Pitt Rivers riprendendo a sua volta Benveniste, esclude di sua natura ogni reciprocità17 (e quindi, potremo concludere, richiede solo di essere accettata). Per questo essa è unilaterale e marca con forza la disparità totale fra chi dà e chi riceve. Allo stesso modo il perdono, come ci dice questa parola, è un dono («chi perdona dona», scriveva nel 1563 Anton Francesco Cirni18), un dono iterato e intensivo tutto diverso da ogni altro dono; esso sfugge quindi alla logica dello scambio che richiederebbe di render male per male, ed è in qualche modo assimilabile alla grazia19.
La grazia del beneficio di Cristo
Queste notazioni antropologiche sono ovviamente tali da affascinare lo storico della prima età moderna, per gli echi che esse fanno suonare al suo orecchio con il grande dibattito teologico del periodo. In esso per l’appunto – non c’è bisogno di ricordarlo – la grazia si configura come libera e sovrabbondante effusione del beneficio divino che strappa gli uomini dai vincoli del peccato e del carcere infernale, richiedendo ad essi solo la sua fiduciosa accettazione: «Tutti quelli che credono in Cristo, ponendo tutta la loro fiducia nella grazia di lui, vincono con Cristo il peccato, la morte, il diavolo e lo inferno»20. Così il testo principe della Riforma in Italia, intitolato appunto Trattato utilissimo del beneficio di Giesù Christo crocifisso verso i christiani, un testo ricco di citazioni implicite da Lutero e da Calvino, sul quale la ricerca si è affaticata a lungo, tentando di definirlo e inserendolo alternativamente nella Riforma protestante, nella spiritualità benedettina o in quella valdesiana; ma tutta la riflessione religiosa del XVI secolo è incentrata, come sappiamo, su questo punto cruciale: sull’abbondanza e sulla gratuità del dono che deriva dal sacrificio di Cristo crocifisso. Così in un momento molto prossimo a quello della stesura del Beneficio, Michelangelo, nel ringraziare di un dono (probabilmente dei versi) Vittoria Colonna, dichiara di essersi in primo momento proposto di ricambiarlo; ma poi, «riconosciuto e visto che la gratia d’Iddio non si può comperare, e che ’l tenerla a disagio è pechato grandissimo»21, accettava il dono senza neppure tentare il contraccambio, in quanto fare altrimenti avrebbe significato mostrare di tenerlo in poco conto, addirittura di disprezzarlo. La grazia divina è dunque come un dono specialissimo, la cui eccezionalità risiede proprio nel fatto che essa esclude ogni tentativo di reciprocità e richiede solo di essere accettata ed accolta.
Proviamo a soffermarci per un attimo sulle implicazioni non solo strettamente teologiche, ma anche giudiziarie e politiche che questi concetti rivestono all’interno del Beneficio. Nell’operetta viene raccontata una sorta di parabola, in cui si fa l’ipotesi «che un re buono e santo faccia pubblicare un bando, che tutti i ribelli securamente ritornino nel suo regno, percioché egli per i meriti di un loro consanguineo ha perdonato a tutti»; solo «chi non dà fede a questo bando non gode di questo perdono generale»22 (ecco dunque affacciarsi ancora la nostra parola). Si trattava di una ripresa di un passo dalle Cento e dieci divine considerationi di Juan de Valdés, là dove si parla di u...