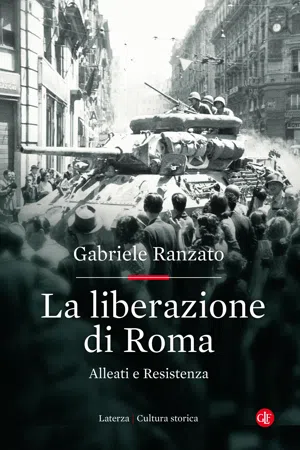V.
L’attività degli agenti alleati dentro la città
Durante i primi mesi della Resistenza nessuno dei partiti antifascisti aveva messo al primo posto tra i suoi obiettivi quello di sostenere il più possibile lo sforzo di guerra degli Alleati. Non solo perché le loro bande partigiane erano ancora in formazione e quindi non erano in grado di compiere, se non sporadicamente, azioni rilevanti di offesa e sabotaggio contro i tedeschi. Ma anche perché i vertici politico-militari angloamericani non riuscirono a predisporre tempestivamente una solida trama di collegamenti oltre le linee del fronte con le forze resistenziali, senza la quale esse, prive di rifornimenti e sostegno logistico, non avrebbero potuto dare un efficace contributo alle operazioni delle truppe alleate. Questo vuoto organizzativo può sembrare sorprendente soprattutto da parte britannica, se si considera che già nell’estate del 1940 il governo inglese aveva creato il SOE (Special Operations Executive), un corpo speciale di intelligence e sabotaggio a cui era stato affidato soprattutto il compito di favorire, attraverso il sostegno ai movimenti di resistenza, la sollevazione delle popolazioni dell’Europa invasa dai nazisti. E questo obiettivo aveva costituito a lungo un elemento essenziale nel quadro di un più ambizioso piano strategico che Churchill ancora alla Conferenza di Washington del dicembre 1941 aveva esposto in questi termini:
Noi dobbiamo prepararci a liberare i paesi prigionieri dell’Europa Occidentale e Meridionale mediante lo sbarco simultaneo o in successione, nei punti più adatti, di eserciti britannici e americani così forti da poter indurre le popolazioni alla rivolta [...]. Se l’incursione delle forze armate avrà successo, l’insurrezione della popolazione locale, che dovremo rifornire di armi, costituirà il grosso dell’offensiva liberatrice.
Questa strategia, che peraltro i comandi americani non avrebbero affatto condiviso, si basava sulla convinzione che vi fosse una generalizzata disponibilità all’insurrezione delle popolazioni soggette all’occupazione tedesca. Ma si trattava di un presupposto alquanto illusorio, perché se questa disponibilità era maggiormente diffusa nell’Europa orientale, dove la dominazione germanica era così intollerabile da spingere più facilmente alla rivolta, non altrettanto avveniva nei paesi dell’area occidentale, dove il regime imposto dagli occupanti era stato, soprattutto nei primi anni di guerra, più sopportabile. D’altra parte anche in Grecia, nei Balcani, e in particolare in Jugoslavia, dove il SOE giunse ad avere una più consistente presenza e una qualche influenza, esso fu ben lontano dal potere orientare le diverse componenti della Resistenza locale, non riuscendo neppure a evitare che esse si combattessero tra loro e a ottenere che mantenessero un impegno unitario nella lotta contro i tedeschi. Così anche in quell’ambiente più favorevole sotto il profilo della combattività della popolazione, gli uomini dei servizi britannici riuscirono ad agevolare un flusso più o meno continuo di armamenti per le forze partigiane e a realizzare con esse importanti azioni di sabotaggio, ma non a fare della Resistenza una forza prevalentemente funzionale ai disegni strategici degli Alleati. Del resto, come aveva detto Churchill a Washington, la lotta partigiana e l’eventuale insurrezione popolare avrebbero potuto avere un peso strategico solo in sinergia con degli sbarchi alleati; ma invano egli cercò, tra il 1943 e il 1944, di indurre gli americani a effettuarli sulla costa jugoslava, distogliendoli dal loro fermo proposito di fare dello sbarco nella Manica l’asse fondamentale della loro offensiva contro la Germania.
Sotto un certo profilo la Campagna d’Italia avrebbe potuto essere una verifica della tesi del Primo ministro britannico, vista la sequenza degli sbarchi alleati nella penisola. Perché, anche se né quelli né i successivi realizzati in Francia avrebbero potuto suscitare una vera e propria sollevazione popolare che costituisse «il grosso dell’offensiva liberatrice» – quel “grosso” era ormai costituito dall’esercito americano –, essi avrebbero però potuto accrescere nella popolazione l’attrattiva delle forze della Resistenza, contribuire ad aumentare il numero di coloro che fossero disposti a battersi nelle retrovie del nemico, ad attuare grandi e piccoli sabotaggi ai suoi danni, a fornire agli Alleati informazioni sui movimenti delle sue truppe, fino a creare una sorta di “quinta colonna” che operasse ai suoi fianchi e alle sue spalle. E così, in qualche misura, sarebbe stato in futuro. Ma più tardivamente di quanto avrebbe potuto avvenire, poiché anche dopo la caduta di Mussolini, e per parecchi mesi ancora, il SOE non riuscì a stabilire con le forze antifasciste italiane la rete organizzativa necessaria per trarne il maggior vantaggio per le operazioni delle truppe alleate.
Naturalmente quel ritardo dipese soprattutto dal fatto che, a differenza degli altri paesi europei in cui il corpo speciale britannico operò, l’Italia era stata un paese nemico, nel quale sarebbe stato senza dubbio molto più difficile creare nuclei di lotta clandestina tra una popolazione che, anche nei suoi strati più delusi dalla guerra o persino di sentimenti antifascisti, avrebbe provato una forte riluttanza, prima del 25 luglio e dell’8 settembre, a collaborare, sulla base di una scelta personale etico-ideologica, con i “nemici della patria”. E anche se questo non era vero – o era meno vero – per i militanti dei partiti antifascisti, essi, nei primi anni di guerra, e anche nei quarantacinque giorni del dopo-Mussolini, erano poco numerosi, privi di un solido tessuto organizzativo a cui i servizi alleati potessero raccordarsi. D’altro canto la prima esperienza diretta con l’ambiente dell’Italia meridionale non offrì agli Alleati la sensazione che gli italiani fossero disposti in gran numero a battersi nella guerra contro i tedeschi e a impegnarsi in attività così rischiose come la guerriglia, lo spionaggio e il sabotaggio. E peraltro la convinzione, diffusa soprattutto tra i comandi britannici, che gli eserciti alleati sarebbero arrivati entro la fine del 1943 fino a Roma ed oltre senza incontrare grande resistenza fece loro sottovalutare l’importanza e l’urgenza di favorire la guerra partigiana e lo sviluppo di attività di informazione e sabotaggio.
Questo però non significa che gli Alleati non cercassero fin dai loro primi passi nella penisola di stabilire contatti con la Resistenza. Già l’8 settembre, durante lo sbarco di Salerno, un piccolo manipolo di agenti del SO...