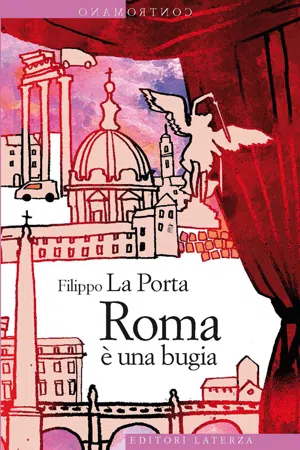Periferie dolenti o felici? (San Basilio, o cronaca di una catabasi urbana)
All’alba degli anni Settanta, in una limpida giornata di ottobre, partii dai Parioli con la mia 500 gialla per un viaggio che in linea d’aria non era più di quindici chilometri ma che si configurava come una vera catabasi urbana, una discesa agli inferi della estrema periferia romana, luogo allora per me intemporale, mitico, irrelato. Ciò che mi spingeva non era zelo missionario né curiosità antropologica ma la certezza che di lì a poco sarebbe avvenuta nel nostro paese una “rivoluzione sociale” capace di risolvere ogni problema personale, dalla abolizione del lavoro al sesso libero, dalla fine dello Stato al diritto inalienabile di ciascuno a essere un artista... E tutto cominciava lì, da quell’estrema periferia, e anzi dal quartiere più degradato della più degradata periferia, ovvero San Basilio, borgata semirurale nata alla fine degli anni Trenta a nord-est della Capitale, per ospitare i “deportati” degli sventramenti fascisti dei rioni del centro. Dopo la guerra il quartiere è stato riconvertito in un agglomerato di case popolari più decenti costruite con i soldi del Piano Marshall, e poi è diventato il simbolo di una realtà sociale criminaloide e riottosa a qualsiasi integrazione. Ovviamente la maggioranza dei suoi abitanti è ed era composta da persone oneste e perbene, ma l’immagine mediatica del quartiere era quella e ne faceva il primo capitolo del “romanzo criminale” della città.
Io appartenevo a un collettivo politico del gruppo del “manifesto”. Il nostro compito era modesto: mobilitare e organizzare le persone per ottenere un ambulatorio. Niente di illegale o particolarmente sovversivo. E anzi molto più Olof Palme che la Cina maoista. Però ciò che contava era “come” vivevamo quell’impegno. Mi sentivo ogni giorno un bolscevico che andava a dare la coscienza rivoluzionaria non tanto alla classe operaia quanto a un sottoproletariato incolto e spoliticizzato, privo di tradizione, condannato a sognare soltanto i consumi da cui era fatalmente escluso. Quando entrai per la prima volta nel quartiere fui preso da sgomento: come raccordare quella desolante, contagiosa “normalità” quotidiana, fatta di bar, negozi, biliardini, bocciofile, gente comune che esce dalle case scalcinate per guadagnarsi ogni giorno il pane, con i raggi ultravioletti dell’“utopia comunista” di cui parlava un filosofo marxista che amavamo molto, Ernst Bloch? Come conciliare il minimalismo (la “miseria”) dell’impegno quotidiano (quasi una forma di volontariato civico: di fatto eravamo volenterosi boyscout infarciti di citazioni e slogan) con il sole dell’avvenire e la rivoluzione planetaria? Certo per me si trattò anzitutto dell’incontro per più versi traumatico con una alterità sociale assoluta, con il più vasto sottoproletariato d’Italia. Mi aggiravo come in stato di sonnambulismo per i cortili polverosi dei “lotti” in cui era diviso il quartiere. Poteva anche accadere di incontrare un solitario Cesare Zavattini, che perlustrava a piedi San Basilio alla ricerca di storie da raccontare. Una volta prestai ingenuamente la mia vespa a dei ragazzi del quartiere, che la usarono – mi dissero in seguito terrorizzandomi – per fare qualche scippo in centro. In questo modo singolare mi diedero così – come si dice – il loro benvenuto nel deserto del reale.
Il problema era tornare ai Parioli. Un conto infatti è scendere nell’Averno e un altro conto uscirne, come sapeva bene Enea: “ma tornar poscia a riveder le stelle, qui la fatica e qui l’opra consiste”. Ma in ciò fui involontariamente aiutato. Suonavo ai campanelli di pianerottoli immersi nel buio, mi impegnavo – quasi sempre vanamente – a fare l’agitprop, mentre le brave donne del popolo, forse mosse a compassione, mi offrivano il Vov e il Marsala con i bicchierini del servizio buono, e così alla fine della giornata tornavo sempre un po’ ubriaco ai Parioli. Eppure avevo il senso di un universo sociale vitalissimo. Nei miei spostamenti di abitazione mi ero sempre mosso all’interno di un centro storico appena allargato, trascurando la sterminata periferia romana, che invece racchiude una miriade di microcosmi e costituisce la vera ossatura della città, ripiena di narrazioni, reali o potenziali. Un concorso letterario per giovani del 1997 – “Scrittura fresca”, legato alla manifestazione Enzimi (oltre seicento autori) – evidenziava il fatto che il 60% dei racconti pervenuti provenisse dalla periferia di Roma, contro il 40% dai quartieri alti e con maggiore livello di scolarizzazione.
Dopo la parentesi politica di San Basilio, istruttiva e anche un po’ irreale, ho ritrovato molto più tardi borgate e sobborghi romani accompagnando mio figlio piccolo nei tornei di calcio la domenica mattina. Ho scoperto come le tante scuole-calcio disseminate nel territorio sono oggi la possibile trama della periferia, e ce ne restituiscono una mappa capillare (mai vista una partita in un campetto del centro storico!). Avete mai iscritto i vostri figli a una scuola di calcio a Roma? Avete mai seguito qualche torneo sui polverosi campetti periferici? La mia impressione è che le scuole di calcio (socialmente molto più promiscue di qualsiasi istituto scolastico), i vapori dei loro spogliatoi in cui avvengono i riti “sadomaso” dell’adolescenza, le partite nei campi di gioco combattute fino all’ultimo sangue – genitori che incitano i propri figli ragazzini con urla belluine o che li insultano quando sbagliano un rigore (“Te vojo ammazzà!”) –, tutto questo ci schiude il greve sottomondo di Roma, la sua miniepica popolare e barbarica, la sua verità plebea oggi lievemente anacronistica. La sterminata periferia romana dei romanzi di Pasolini, via via disseminata di centri urbani e di shopping mall, sottoposta a processo di veloce gentrification, dunque pacificata e normalizzata, è perlopiù scomparsa, con le borgate dal dialetto imbastardito e i borghetti di baracche a ridosso degli acquedotti antichi. Fine di un’anomalia, progresso civile, ma anche pasolinianamente “genocidio culturale”. Eppure credo che l’universo brulicante delle scuole di calcio ne rappresentava ancora fino a pochi anni fa una voce superstite, indomita.
A mio figlio, che frequentava già dall’età di dieci anni una scuola-calcio deposta sui margini umidi e nebbiosi del Tevere, vicino la basilica di San Paolo fuori le mura, toccò però in sorte un istruttore assai saggio – Mario D.B., padre di un calciatore famoso – fondamentale per quell’età della vita, specie per un maschio. Nel Racconto d’inverno (1611) di Shakespeare il vecchio pastore dice: “Vorrei che non ci fosse età tra i dieci e i ventitré anni, o che la gioventù la passasse tutta a dormire, perché non c’è niente in mezzo se non ingravidare ragazze, dileggiare gli anziani, rubare e picchiare”. Ecco, quel maestro di vita e di pallone riuscì a canalizzare la minacciosa tempesta ormonale, l’energia ferina e distruttiva dell’adolescenza, in uno sport lealmente competitivo, giocato con impegno e insieme con un po’ di sano distacco. E soprattutto: essendo operaio di fabbrica, appartenendo cioè al “popolo” di una volta, con la sua etica della responsabilità e della disciplina, dichiarava continuamente – proprio lui che adorava il calcio! – l’enorme secondarietà di questo sport nella vita ed esprimeva la sua umile ammirazione per la cultura e lo studio, per il lavoro e la famiglia.
Accennavo alla “fisiologica” voglia di normalità degli abitanti del quartiere. In un romanzo degli anni Trenta di George Orwell, Fiorirà l’aspidistra, il protagonista Gordon, orgogliosamente spiantato e in guerra con i ricchi, rivendica il proprio disimpegno politico con Ravelstein, il compagno ricco e molto impegnato, pronunciando la sua estrema, insuperabile obiezione al socialismo. Più o meno suona così: è bellissimo, ma non lo vuole nessuno! Che significa? Provo a interpretarlo, sapendo ovviamente che lo stesso Orwell era socialista, benché senza partito. Significa che per ciascuno è naturale aspirare a una maggiore giustizia sociale, all’uguaglianza di diritti e a un maggior peso personale nelle decisioni che riguardano la collettività; però in ciascuno si trova sempre una resistenza altrettanto naturale verso tutti i modelli di società perfette (le utopie migliori sono quelle che non pretendono di essere realizzate), quasi la intima certezza che i principali mutamenti della società sono involontari e non dipendono dai nostri sforzi.
Quello che mi colpiva era proprio il fatto che le persone non volessero sentir parlare della rivoluzione, di eventi grandiosi e traumatici, di palingenesi corrusche e violente, che diffidassero di qualsiasi discorso che evocava scenari troppo futuri, scopi meravigliosi però lontani nel tempo (altra cosa ovviamente era la lotta per strappare diritti elementari, come testimonia almeno la rivolta di San Basilio, nel settembre 1974, in difesa delle occupazioni delle case). Inoltre notavo che anche dentro il “genocidio culturale” di cui parlava in quegli anni Pasolini – e cioè distruzione di subculture, di interi mondi sociali e linguistici – i momenti più significativi di “resistenza” fossero soprattutto quelli prepolitici, non organizzati, ad opera di individui o piccoli gruppi. Certo, la periferia romana alimenta da sempre una fiction truculenta: pensiamo al “gobbo del Quarticciolo”, bandito – partigiano immigrato dal Sud – e protagonista della prima narrazione epica alla fine della guerra. Ma perfino nelle sue pieghe si percepisce una realtà meno ovvia, capace ogni volta di sorprenderci, e intrecciata con l’epopea antiborghese dei ragazzi di vita pasoliniani.
Prendete Romanzo criminale (la serie tv), quella narrazione sanguinosa di ragazzi della via Paal feroci, brutali, incoscienti, disposti ad ammazzare per un nonnulla come in un videogioco, e anche sventati, allegramente menefreghisti e camerateschi. In essa ritrovate la felice ambiguità antropologica cui accennavo. Il personaggio di Dandi, interpretato da Alessandro Roja, sembra perfino nei tratti somatici un lontano discendente dei borgatari pasoliniani: giocoso e irriverente, “compagnone” e provocatore, ma passato attraverso la “mutazione”, e quindi precipitato senza alcuna difesa dentro l’universo dei consumi borghesi. I ragazzi che allora conobbi gli somigliavano molto, al tempo stesso innocenti e corrotti. Ossessionati dall’arricchimento facile, barbaricamente incapaci di mediazione, ma presi uno per uno erano persone normali, e cioè socievoli, desiderose di una quieta normalità e di affetti solidi, non particolarmente sanguinarie o violente né inclini a entrare in una guerra permanente con gli altri. Anche oggi, pur dentro un orizzonte di degrado civile, l’Hinterland romano presenta il massimo di risposta al degrado: se esplori da vicino i suburbs romani scopri innumerevoli iniziative di resistenza e comportamenti virtuosi che dal basso riprogettano i quartieri disegnati da architetti e urbanisti.
Vi chiedo la pazienza di fare un esperimento solo apparentemente rischioso. Un giorno provate ad andare al famigerato Laurentino 38, e salite sul sesto “Ponte”. Vi scoprirete una ricca vita sociale, forme di auto-oganizzazione di giovani, attività culturali. Gli abitanti del quartiere fanno un uso imprevedibile delle soluzioni imposte, riorientano le scelte architettoniche originarie – pure ispirate a Le Corbusier, però astratte, pensate a tavolino – verso altri obiettivi. A Corviale la gente sembra liberarsi dal maleficio che attanagliava il “serpentone” (un vagone ferroviario lungo ottocento metri, che pure nelle intenzioni del progettista consegnava ai meno abbienti uno spazio tra grande città e mare) e ha cominciato a prendersi cura di alcuni spazi collettivi. A San Basilio, in un’area a ridosso del Raccordo anulare, quasi nascosta alla vista, gli abitanti, perlopiù di origine contadina, hanno ripreso a coltivare ortaggi. L’urbanista Enzo Scandurra sa bene che certe strutture abitative, certi luoghi (o non-luoghi) tendono a dissolvere la coesione e il legame sociale: “Le persone non hanno nulla in comune tra loro”.
La colpa però – sottolinea Scandurra – non è sempre di architetti e urbanisti: Tor Bella Monaca è infatti realizzato con edilizia elegante e immersa nel verde, ma resta una enclave separata dalla città, in cui i grandi spazi alberati “non vengono riconosciuti” dagli abitanti, che preferiscono ritrovarsi in spazi meno aperti. Nel quartiere multietnico di Torpignattara, con i suoi nobili edifici e le sue casette abusive, con la più grande comunità cinese e indiana della Capitale, è nata una esperienza straordinaria di orto urbano: diversi giovani hanno trasformato un’area incolta in “laboratorio politico”, dove la domenica si canta, si balla, e si ascoltano i racconti dei vecchi abitanti. Lì si costituisce una convivenza ormai scomparsa dal paesaggio urbano.
Spesso si guarda a Roma come trista sineddoche, pars pro toto: nella sua corruzione e nel suo parassitismo si rispecchierebbe ahinoi la storia (mancata) della nazione. Non c’è scrittore, saggista, storico, politologo, ecc. che a un certo punto non abbia ceduto a questa immagine letterariamente suggestiva ma sociologicamente imprecisa. Prendiamo Alberto Moravia. L’autore di Gli indifferenti osservò nel 1975, ispirandosi probabilmente all’amico Pasolini, che negli ultimi anni a Roma era venuta su la piccola borghesia, “che è stata il disastro non soltanto di Roma ma anche dell’Italia”, una nuova classe incolta e devota ai consumi, “senza tradizioni, né ambizioni morali né rispetto umano”. Questa nuova classe è stata da allora descritta in innumerevoli libri, e certamente è cresciuta fino a diventare egemone, dal punto di vista dei modelli e dei sogni collettivi. Ci avvolge tutti e detta regole e stili di vita. Però la sua egemonia è più apparente che di sostanza. Riguarda più l’immaginario che i comportamenti concreti delle singole persone. La teoria di Moravia somiglia a una profezia che si autoavvera: poiché sappiamo che apparteniamo tutti, fatalmente, a questa nuova classe, allora ci comportiamo in modo più o meno cinico, arrogante, incivile.
Ma a volte questa piccola borghesia omologata mi sembra solo una patina sottile, superficiale, che nasconde molte differenze, e che genera continuamente reazioni e controspinte. Guardiamoci intorno: tra il cielo e la terra di Roma ci sono innumerevoli esperienze, individuali e collettive, al centro e in periferia, che smentiscono quella teoria. Ad esempio: in questa città più che in altri luoghi ho capito che il razzismo è una sovrastruttura, che non ha un vero fondamento reale, ma serve solo come alibi, come argomento in più alle persone quando entrano in conflitto violento per i più svariati motivi. E mi piace ricordare che Roma, che pure ha conosciuto episodi recenti di intolleranza, non è razzista. Per il semplice motivo che la sua storia è quella di un patto di cittadinanza, non di un’etnia. Al Campidoglio c’era un tempietto che ospitava tutti gli immigrati di allora (latini, sabini, etruschi). Ha avuto imperatori africani e serbi, e grandi scrittori spagnoli e berberi. L’identità romana, come quella americana, era una costruzione artificiale, una identità che si forma per consenso e non è legata al sangue, alle radici. Di qui anche la capacità di assimilazione di altre culture. Dopo la fase brutale della conquista si pensava a costruire il consenso e l’integrazione. E certo la sua intera storia, apparentemente sonnolenta, appare scandita da conflitti, tensioni, antagonismi, ribellioni, da Menenio Agrippa a Giordano Bruno, dalla Repubblica romana alla Resistenza...
Ma torno alle ragioni...