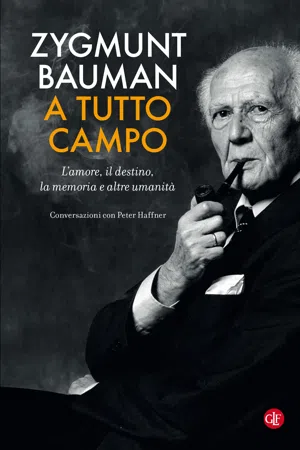Società e responsabilità
Solidarietà: perché ognuno è diventato nemico dell’altro
Peter Haffner Dal Suo primo libro sul movimento operaio britannico alle riflessioni sulle questioni dell’etica postmoderna il Suo centro d’interesse si è spostato dalle classi sociali all’individuo. Quel che conta alla fine, si direbbe, non è tanto il posto che uno occupa nella società quanto quello che egli fa indipendentemente da esso.
Zygmunt Bauman Non si tratta semplicemente di uno spostamento di prospettiva, di uno scivolamento del fuoco dalla classe all’individuo. Sono arrivato alla conclusione che le classi oggi sono prodotti della statistica e non della vita. Sul piano statistico possiamo costruire tutte le classi che vogliamo. Possiamo dividere le persone per reddito, per formazione, per stile di vita, per rispetto e prestigio di cui godono nella società, secondo un qualsiasi criterio a piacere. Ma questa non è la realtà della vita, bensì una catalogazione. Che è quella che creiamo anche nel processo di privatizzazione e di individualizzazione. Le funzioni che molto tempo fa erano funzioni sociali, sono diventate individuali. Per Max Weber, che, come quasi tutti al suo tempo, accettava l’idea che la società sia divisa in classi, la cosa importante era invece soprattutto l’obiettiva somiglianza delle condizioni di vita. Le persone appartengono alla stessa classe se si trovano insieme nella stessa barca.
P.H. Karl Marx, cui risale il concetto di classe, parlava della «classe in sé» e della «classe per sé», nel senso di Hegel. Diventare «classe per sé» significa sviluppare una coscienza di classe.
Z.B. Per salire dalla «classe in sé» alla «classe per sé», una classe deve diventare politicamente attiva, deve rendersi conto che gli appartenenti alla classe sono tutti insieme nella stessa barca, hanno un destino comune e possono combattere per il miglioramento della loro situazione. In molti luoghi oggi non è più così. I sindacati sono esautorati, e strumenti di lotta come lo sciopero, per rafforzare la posizione dei lavoratori nel negoziato, non sono più disponibili.
P.H. Quali sono le conseguenze?
Z.B. La perdita di forza dei sindacati ha indebolito l’autoprotezione collettiva. Con l’abbattimento dei sistemi di sicurezza statali contro i colpi del destino e i fallimenti individuali, sono state seppellite ancora più a fondo le basi sociali della solidarietà comunitaria. Adesso tocca al singolo cercare da solo una soluzione a problemi che non ha provocato. Egli è lasciato completamente a sé stesso, senza gli aiuti e le risorse che sarebbero necessari per questo compito. Come si può cementare una solidarietà se il lavoratore oggi è costretto a cambiare continuamente posto di lavoro?
P.H. Come si è arrivati a questo punto?
Z.B. Cinquanta-sessant’anni fa il modello classico delle relazioni fra capitale e lavoro era la fabbrica fordista. La caratteristica più importante della fabbrica fordista era la dipendenza reciproca del proprietario della fabbrica e dei suoi lavoratori. I lavoratori nella capitale dell’auto Detroit dipendevano da Henry Ford, nella cui fabbrica di Dearborn essi si guadagnavano il sostentamento. Senza Ford, sarebbero stati privi di mezzi. Ma Ford dipendeva altrettanto da loro. Senza i lavoratori non poteva andare avanti, essi lo aiutavano ad accumulare la sua ricchezza, il suo potere. Benché né l’una né l’altra parte ne parlassero, benché né Ford né i lavoratori articolassero esplicitamente i loro sentimenti, tutti sapevano benissimo che erano condannati a vivere insieme, e anche per un lungo, lunghissimo tempo. Sapevano che si sarebbero reincontrati all’indomani, e poi nel mese successivo, e per i vent’anni a seguire. Se un giovane faceva il tirocinio presso la Fiat o la Peugeot, poteva essere sicuro che dopo quaranta o cinquant’anni sarebbe andato in pensione nella stessa impresa e magari avrebbe ricevuto persino un orologio d’oro per il suo fedele servizio.
P.H. Cosa che un operaio o un impiegato di oggi non può più aspettarsi.
Z.B. Ognuno oggi deve mettere in conto la possibilità che una grande ditta assorba la sua piccola ditta, o che i dirigenti della sua ditta per un motivo qualsiasi spostino il loro capitale in altri paesi, dove ci sono lavoratori che si accontentano di un salario di due dollari al giorno e non scioperano mai. Il contratto non scritto fra capitalista e lavoratore è stato stracciato unilateralmente. I capi possono andare dove vogliono, e fanno quello che vogliono, mentre gli operai e gli impiegati continuano a essere legati al territorio. Sono «glebae adscripti», come nel Medioevo si designavano i semiliberi legati alla terra e i servi.
P.H. Ma ci sono anche lavoratori che espatriano. Vengono chiamati allora migranti economici.
Z.B. Possono emigrare, in effetti, ma a quale prezzo? Sono costretti a pagare immense somme a trafficanti di uomini, ad affrontare il rischioso viaggio attraverso il Mediterraneo per essere poi bloccati alle frontiere, rinchiusi in campi di accoglienza o rispediti a casa. I poveri, che cercano un impiego, che vogliono guadagnare un po’ di denaro e migliori scuole per i loro figli, continuano a essere dipendenti dai padroni d’azienda, che comprano la loro forza lavoro. I padroni, invece, non sono più dipendenti da loro. Se ne possono andare là dove trovano le condizioni più vantaggiose per loro. Dove ciò porti, lo vediamo chiaramente: gli unici che ancora scioperano ogni tanto sono gli impiegati statali, che hanno un posto di lavoro sicuro, un contratto a vita. Sanno di essere praticamente non licenziabili. I mercati del lavoro in territori lontani, all’estero, invece, sono del tutto privi di regole. Nessuno può rischiare di scioperare. Perché i padroni non si presentano al tavolo delle trattative per trovare una soluzione concordata.
P.H. Ciò significa che i soli a poter contare sulla compatezza e la solidarietà sono in pratica quelli che non ne avrebbero bisogno.
Z.B. Il proletariato non è più, come ai tempi di Marx, una «classe per sé», perché ora ognuno è responsabile di sé stesso. Anziché solidarizzare, sviluppare un senso di comunità fra i dipendenti di una fabbrica, oggi accade il contrario. Ogni compagno di lavoro è un potenziale concorrente, tutti sospettano di tutti e ognuno spera che, quando arriverà il prossimo giro di razionalizzazione, ridimensionamento e outsourcing, non sia lui a essere colpito ma il suo collega. Che non sia lui a rientrare fra gli esuberi, ma l’altro. Questo è l’interesse dell’attuale lavoratore di fabbrica, che in generale non ha nulla da guadagnare a tenersi stretto agli altri. Così ognuno diventa potenzialmente nemico dell’altro, e la possibilità che questa classe si elevi da «in sé» a «per sé» è minima. Nella precedente modernità solida, al contrario, la fabbrica fordista produceva anche – quale che fosse il bene prodotto – solidarietà. Una solidarietà obbligata, che si collocava nella logica dei rapporti. La fabbrica attuale, quale che sia il bene prodotto, produce invece rivalità.
P.H. Adesso anche il ceto medio, un tempo stabile, teme di essere risucchiato in questa massa di lottatori singoli, che possono perdere il posto di lavoro da un giorno all’altro.
Z.B. Che la diseguaglianza stia aumentando, nessuno più ormai lo mette in dubbio. Di qualunque scuola siano gli economisti e per quanto diverse possano essere le misure che essi propongono, i risultati delle loro ricerche sono straordinariamente univoci. Dal principio del nuovo secolo in avanti l’incremento di valore della crescita economica scivola quasi esclusivamente nelle tasche dei più ricchi – l’uno per cento della popolazione, se non meno –, mentre il reddito e le sostanze del rimanente 99 per cento sprofondano o sono minacciati. Nei cosiddetti paesi sviluppati dell’emisfero settentrionale la situazione non è più oggi tanto lontana da quella degli anni Venti. Adesso anche il ceto medio rientra nel cosiddetto precariato. Si trova nelle sabbie mobili, non ha terreno solido sotto i piedi, qualunque sia il suo status al momento. Chi appartiene al precariato, vive nell’incubo costante di svegliarsi il mattino successivo e accorgersi che il posto di lavoro che aveva non c’è più. Da un giorno all’altro, senza preavviso, si può perdere la propria occupazione. Io ho spostato l’attenzione dalla classe all’individuo non perché le mie visioni siano cambiate, ma perché le condizioni sono cambiate.
P.H. Anche se la lotta di classe appartiene al passato, l’impegno politico, la presa di posizione a favore o contro qualcosa, non si sono affatto affievoliti, anzi.
Z.B. Le persone si impegnano per tutte le cause possibili, per questioni ecologiche, etiche o religiose. C’è un revival del locale, ci si batte per ottenere sovvenzioni statali per questo o per quello, entrando in concorrenza reciproca. Ci sono tutti i tipi di conflitti e antagonismi, ma nessuno è tale da poter essere incasellato nel concetto di classe. Se c’è una cosa che ricorda la lotta di classe, questa è la contrapposizione fra poveri e ricchi. Di questo mi sono occupato nel mio libro Retrotopia; cioè delle «due nazioni» di cui parlava Benjamin Disraeli, lo statista e scrittore conservatore britannico, nel suo romanzo apparso nel 1845 Sybil, or the Two Nations. In esso troviamo un operaio di tendenze radicali, di nome Walter Gerard, il quale parla di «due nazioni» nel paese, che non hanno fra loro nessun rapporto, nessuna affinità, e che conoscono pochissimo l’una le abitudini, i pensieri e i sentimenti dell’altra, come se vivessero su pianeti diversi. Sono state educate con criteri diversi, si nutrono di cibi diversi, seguono comportamenti diversi, e non sono rette dalle medesime leggi, si dice nel libro. In questa descrizione sono intesi – precisava Charles Egremont, uno dei principali personaggi del romanzo – i ricchi e i poveri. È una rappresentazione molto appropriata della situazione che viviamo oggi, a più di 170 anni di distanza. Ma anche i poveri e i ricchi non costituiscono delle classi, anche se la lotta fra di loro può essere espressa in termini sociali. Inoltre, contrariamente a un’opinione molto diffusa, le rivoluzioni non vengono fatte dalle persone che vivono in povertà. I poveri servono come fanteria, mentre l’idea di unirsi sotto una bandiera, una bandiera di classe, viene dall’intellighenzia, da persone colte, che hanno tempo per riflettere. Ma oggi non c’è né un’intellighenzia capace di proporre alcunché, né una fanteria significativa che possa accogliere l’eventuale proposta. Questa è la mia risposta alla Sua domanda sullo slittamento del centro focale delle mie riflessioni. Io penso che la realtà sociale sia cambiata.
P.H. Fino a qualche tempo fa sembrava che, almeno nei paesi industrializzati occidentali, la lotta alla povertà fosse stata quasi vinta.
Z.B. Dall’epoca dell’analisi di Disraeli sono stati fatti sforzi per eliminare la povertà, e nei primi decenni dopo la guerra si è creduto che la «divisione in due nazioni» sarebbe stata rapidamente superata. Il lavoro a salari fissi fu la ricetta per uscire dalla povertà, e si pensò che compito del governo fosse di assicurare la piena occupazione attraverso programmi di lavori pubblici, dal momento che l’economia – se mi è concesso di esprimermi con una buona dose di semplificazione – non lo faceva da sola. La «lotta alla povertà», questa era la convinzione, dev’essere lanciata dallo Stato e dev’essere condotta con armi politiche.
P.H. Difficilmente oggi questo è possibile. Prima di tutto, perché il potere e la politica, come Lei dice, si sono frantumati. Come siamo arrivati a questo punto, e che cosa significa?
Z.B. Quando studiavo, più di mezzo secolo fa, lo Stato nazionale era ancora l’istituzione suprema. Era sovrano sul suo territorio sotto ogni aspetto, economico, militare e culturale. Oggi le cose non stanno più così. Il potere è trasmigrato dalla politica. In primo luogo nello spazio globalizzato, dove dominano imprenditori transnazionali. In secondo luogo nel mercato dei consumi, che non possono essere gestiti e controllati democraticamente. E in terzo luogo sui cittadini, che cercano di risolvere i problemi sociali per via privata – la life politics, appunto – piuttosto che con la politica tradizionale.
P.H. Mentre quelli che detengono realmente il potere, le banche e gli imprenditori, operano a livello globale, l’influenza dei politici rimane locale. Come si può contenere il potere entro dei limiti, se non ci sono i mezzi per farlo?
Z.B. Come rimettere insieme politica e potere, è la più grossa sfida di questo secolo. I problemi che la globalizzazione ha provocato o aggravato, non possono essere risolti a livello locale. Possono esserlo solo a livello globale. Ma il presupposto è che la politica abbia il potere necessario.
P.H. Cosa che non ha, come Lei stesso ha più volte affermato.
Z.B. È un sistema impotente. Ciò che il politico decide, ciò che le popolazioni di Zurigo, di Budapest o di Stoccolma decidono, vale solo nell’ambito di potere delle istituzioni locali. Sono l’equivalente delle comunità locali di quattro secoli fa. Il potere è ormai globalizzato, mentre la politica continua a essere locale come prima. Chi decide del Suo futuro e di quello dei Suoi figli non sta dentro i confini del Suo paese e, soprattutto, oggi ad operare a livello globale sono proprio le forze che più di tutte influenzano le condizioni di vita dell’uomo e le prospettive del futuro. Esse agiscono nel già menzionato «spazio dei flussi» e ignorano disinvoltamente i confini, le leggi e gli interessi delle unità politiche. La politica continua invece a muoversi nello «spazio dei luoghi». E mentre perde sempre più potere, le forze agenti si emancipano sempre più dalle limitazioni e dai controlli politici. Nessuno ha accesso ad esse. E le cose non cambieranno nel futuro prossimo. Ci troviamo così prigionieri in questa situazione, una situazione in cui abbiamo bisogno di tutte le nostre risorse private individuali per combattere, per affrontare i problemi che non siamo stati noi a creare. Siamo una società di individui costretti a prendere le decisioni da soli e a portare il peso delle loro conseguenze.
P.H. In passato, le cose erano più semplici?
Z...