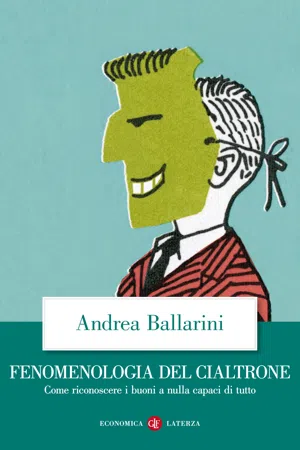2. Il codice del cialtrone ovvero
La katana e le cazzate
Il vocabolario della lingua italiana Zingarelli di qualche anno fa recita: «Cialtrone. s.m. 1. Individuo spregevole, volgare negli atti e nelle parole. SIN. Mascalzone. 2. Persona pigra e trasandata o senza voglia di lavorare». Il dizionario della lingua italiana Sabatini Coletti invece dice: «Cialtrone. s.m. 1. Persona sciatta, trasandata; estens. Persona che lavora poco e male. Sin. Ciabattone, pasticcione. 2. non com. Villano, mascalzone, gaglioffo».
Al di là di un comune e severo giudizio di valore, entrambe le definizioni – ancorché corrette – non riescono a circoscrivere la proteiformità del cialtrone e, soprattutto, a individuare la caratteristica che più di ogni altra differenzia la categoria aristotelica del «cialtrone» da altre figure che popolano le nostre vite: i malvagi, gli imbroglioni, i pelandroni, gli inetti, i furbastri, i ciarlatani eccetera. Scopo della parte preliminare di questa ricerca è rendere manifesto come la caratteristica precipua del cialtrone – ciò che ne definisce il codice genetico – sia la totale mancanza di senso critico.
«Citatio praecox»
Il cialtrone si avvantaggia degli effetti di una tale moratoria dell’autocritica ricavandone una straordinaria capacità di penetrazione del reale. Laddove personalità più complesse si impanierebbero in snervanti tenzoni con se stessi, ritardando la consegna al pubblico giudizio, che so, della ponderosa tesi sui Minnesänger cui stanno lavorando da anni, perché non si sentono in pace con la propria integrità professionale a citare un’opera monografica della metà dell’Ottocento senza averne letto per intero l’unica copia conosciuta che, sfortunatamente, è conservata al museo civico di Königsberg, il cialtrone consegnerà con la più olimpica tranquillità interiore una tesi raffazzonata in due o tre giorni, contenente un temerario parallelo tra La canzone del falcone di Der von Kürenberg (XII secolo), là dove dice:
volò fuggendo il falcone in altro cielo.
Vidi allora volare il bel falcone:
lacci di seta brillavano alle zampe,
tutte le piume eran rosse e d’oro:
unisca Dio chi si vuole amare!
e i versi del Mio canto libero, là dove Giulio Rapetti, in arte Mogol, si spinge a scrivere:
nasce in mezzo al pianto
e s’innalza altissimo
e va
e vola sulle accuse della gente
a tutti i suoi retaggi indifferente
sorretto da un anelito d’amore
di vero amore.
L’analogia, del tutto gratuita e non giustificata se non da sfrontatezza e superficialità, varrà, nondimeno, all’autore il plauso del colto e dell’inclita e, con ogni probabilità, la laurea a pieni voti in Scienze della comunicazione; ché il cialtrone, pur se non dotato di particolari facoltà intellettive, sarà tuttavia stato tanto astuto dal tenersi alla larga dalle facoltà più inutili (lettere classiche e/o moderne e tutte quelle scientifiche), orientandosi strategicamente su discipline di più pronta spendibilità sociale. Con le debite differenze, in omaggio al ben noto adagio gesuita, si potrebbe dire Nisi caste, saltem caute, e cioè Se non castamente, almeno cautamente.
Rispettare il limite di lentezza
Il cialtrone è dotato dalla natura della sopraffina e istintiva capacità di individuare la velocità di crociera ottimale da tenere nelle differenti circostanze che la vita gli presenta. Agli appassionati del fuoristrada è tristemente nota la micidiale distesa di cunette, dossi, solchi, avvallamenti in perenne mutazione a causa del vento e dei segni lasciati dal passaggio di altri viaggiatori, designata con locuzione francese tôle ondulée, ovvero lamiera ondulata. Nelle sterminate piane del Nord Africa centinaia e centinaia di chilometri di tolla rugosa decimano le sospensioni anche delle più resistenti Land Rover e distruggono i nervi degli ardimentosi che osano percorrerli. Sballottati come all’interno di una gigantesca zangola, la resistenza di oggetti e persone è messa a durissima prova. Per procedere su questo tipo di terreno estremo senza avanzare col passo esasperante di una lumaca non v’è che mantenere una velocità opportunamente elevata, tra i 65 e gli 80 chilometri all’ora, così da viaggiare al di sopra degli avvallamenti, avendo cura, è ovvio, di non uscire di strada. Come un esperto rallista, il cialtrone è per predisposizione naturale incline a tenere una velocità di crociera esistenziale che gli consente di restare in superficie, senza curarsi d’approfondire il superfluo, superfluo che dalla sua particolare Weltanschauung corrisponde a pressoché qualunque cosa.
E la percepibile disinvoltura, la sprezzatura si sarebbe tentati di dire con termine caro al Cortegiano del Castiglione, con cui lambisce senza addentrarvisi le più impervie contrade del pensiero influenza l’ambiente circostante. La sua intima convinzione d’essere nel giusto – anche perché non v’è alcuna possibilità che egli immagini vi possa essere una posizione difforme dalla sua – permea l’atmosfera intorno a lui di un’aura positiva che dispone favorevolmente l’uditorio, attraverso vie che sono sottili fino all’impalpabilità, ma non per questo meno reali. Questa sorta di fluido emanante dal cialtrone produce effetti in tutti gli ambiti e in tutte le fasi della vita, dalla sfera privata a quella professionale, dalla più tenera età fino alla decrepitezza. A questo proposito è illuminante il racconto di Massimo S. di Milano, studente di liceo scientifico, 18enne.
Testimonianza n. 1
La B*, la prof. di francese, era una iena. Brava, eh, non c’è che dire, brava, ma una iena. Lei avrebbe voluto fare le interrogazioni programmate, che riteneva meno umilianti sia per noi che per lei, ma nella nostra classe eravamo troppo animali e quindi non c’era mai nessuno che si metteva in lista, così lei una volta perse la pazienza e decise motu proprio il calendario delle interrogazioni a suo insindacabile giudizio. Ci concesse sette minuti di interrogazione: se rispondevamo bene saremmo stati promossi, altrimenti saremmo stati bocciati. La B* ci aveva dato da leggere durante l’anno una serie di romanzi dell’Ottocento francese, La certosa di Parma, Le illusioni perdute, Madame Bovary, Il ventre di Parigi, L’uomo che ride ecc.
Ricordo ancora come fosse oggi l’interrogazione di Angelo C. Lui aveva letto sì e no una metà dei romanzi su cui avrebbe dovuto essere interrogato, ma poiché era un ragazzo simpatico e brillante, dalla battuta pronta, la B* lo aveva preso in simpatia. Arriva il giorno della sua interrogazione e Angelo si presenta: la faccia come il culo, bello, sorridente, traspirante fiducia nei propri mezzi. L’interrogazione comincia con qualche accenno generale al realismo ottocentesco e poi, stringendo gli occhi fino a farli diventare una fessura, la B* mena il suo fendente: «Qual è quel personaggio di Madame Bovary che fa la fioraia?».
Ora, questa è una domanda a cui si avrebbe difficoltà a rispondere anche conoscendo bene il romanzo in questione, poiché Cadine – questo il nome del personaggio men che secondario – occupa si è no una ventina di righe in un romanzo di quattrocento e passa pagine scritto pure piccolo piccolo. Figuriamoci cosa poteva saperne Angelo, che il romanzo non l’aveva neanche aperto. Nondimeno l’infingardo simulò un’intensa concentrazione e, dopo aver riprodotto con impressionante risultato mimetico lo sforzo di un caterpillar che scava nei meandri del suo cervello, se ne uscì proclamando coram populo: «Madame Bovary».
La povera B* balzò sulla sedia come se le avessero sparato e lanciò un grido di agonia, poi, dopo aver deglutito a vuoto un paio di volte disse, con le mani nei capelli e l’espressione stravolta di una fantesca sopravvissuta alla calata dei lanzichenecchi: «Mais monsieur!».
Che voto avrebbe preso un altro che non avesse avuto la faccia come il culo di Angelo C.? Quattro? Zero? Meno tre? Ma invece lui ribaltò la situazione con una di quelle fulminee intuizioni che sono il marchio del genio: «Ah, già, è vero, mi scusi. È che ieri sera ho visto My fair lady e mi sono confuso con Eliza Doolittle».
Una valutazione anche solo gentile avrebbe radiato Angelo C. da t...