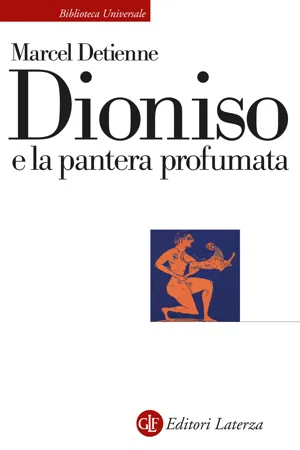II.
La pantera profumata
1. La lezione di storia
Nella storiografia odierna, la singolarità dello storico dell’antichità pare quella d’essere ghiotto di autopsia1. E non ci riferiamo certo a quell’autopsia praticata dagli accoliti inguantati e vestiti di bianco che l’inchiesta giudiziaria incarica di scrutare nel corpo del delitto, bensì di quella propria di un testimone che si fa occhio vivente. «Se fosse possibile assistere personalmente a tutti gli avvenimenti, questa sarebbe di gran lunga la miglior forma di conoscenza»2. Per Eforo di Cuma, autore nel IV secolo a.C. di una delle prime storie universali, il modo irreale del verbo equivale ad una confessione che l’esilio nel presente, nel momento in cui l’assenza pare ormai già sommergere la parte maggiore della realtà, pungola il desiderio di un sapere fondato sulla visione diretta delle azioni umane. In una tradizione rispettosa del Padre, e convinta che la storia è «restata fondamentalmente la stessa» dai tempi di Erodoto3, uno sguardo particolare, appartenente a dei contemporanei, intende appuntarsi sul campo al tempo stesso definito dalla testimonianza di colui che sa per aver visto e rivelato dall’epoptia clamorosa conferita dalla presenza effettiva all’avvenimento. Così per un grecista, dotto epigrafista4, l’iscrizione, dall’Attica alla Battriana, costituisce una testimonianza diretta: «Sotto l’acqua mista a carbone che scivola dolcemente su di un marmo quasi cancellato, una città che si credeva a centocinquanta chilometri di distanza appare in un’iscrizione della Ionia»5. Le pietre non solo parlano – con una voce ben diversa da quella d’oltretomba che pare assegnar loro la maschera della fredda opacità –, ma mostrano addirittura lo spettacolo del passato, si assommano a comporre il caleidoscopio6 grazie al quale lo storico-antiquario viene a essere trasportato tra gli antichi: egli diviene contemporaneo del lapicida, del magistrato, del benefattore...7. Non si tratta più di ricercare e di interrogare le tracce sfuggenti di un assente; l’‘acqua della giovinezza’8 che scaturisce dalla pietra epigrafica conferisce allo storico il privilegio di contemplare gli avvenimenti direttamente con i propri occhi. L’epoptia, d’altra parte, non è limitata al solo decifratore del documento primario: «Ogni lettore dell’iscrizione può risentirla a sua volta; il documento, una volta stampato su carta, è diretto come quando è inciso sulla pietra»9.
In questo discorso metodologico, affidato nel 1962 a un volume collettivo sulla Storia e i suoi metodi, un certo ‘realismo’ conosce il suo apogeo: la narrazione degli avvenimenti passati si eclissa davanti alla visione collettiva di un mondo che ci si immaginava assente e che sorge dalla superficie leggibile delle parole tracciate sul marmo. È vero che il documento epigrafico non è un monumento tra gli altri disposti lungo le strade percorse dalla Storia: per la sua massa, per la sua natura, che impone la presenza reale del passato, esso dà quasi automaticamente allo storico l’emozionante sensazione di assistere di persona a tutti gli avvenimenti, tagliando corto con «le interminabili discussioni su testi tormentati da quattro secoli»10. La sola ombra che venga talora a turbare una tanto solida felicità è quella, sapientemente congiurante, delle ‘pietre erratiche’11 che rotolano per il mondo, che si spostano da una località all’altra, e che, separando il documento-testimonianza dal sito e dalla geografia originari, possono infirmare il privilegio, proprio agli epigrafisti, di «far scaturire la storia»12.
L’illusione del reale di rado raggiunge una forza così grande, o un tale splendore, e tuttavia, in modo più o meno insidioso, il realismo dell’‘è successo’ non cessa di dominare il sapere ben articolato degli storici, che oggi vogliono essere o si sperimentano ‘antiquari’.
Agli occhi di un ‘realismo’ visionario, un progetto di analisi strutturale dei miti non può non destare il sospetto. Su questo terreno, lo storico non è forse di primo acchito privato del ricorso ad una cronologia continua, che non riesce ad organizzare i miti come riesce ad ordinare il susseguirsi degli arconti? Da quando gli eredi di K.O. Müller hanno scoperto che un mito non è necessariamente il prodotto dell’ambiente storico, sociale e geografico dal quale pare sorgere spontaneamente, la mitologia, rifiutata, sembra non avere che una realtà dubbia, né carne né pesce, e la scrittura, svezzandola dall’oralità, non l’ha tuttavia purificata dalla sua appartenenza all’immaginario. Alla sfiducia istintiva che, dal tempo di Ecateo di Mileto e delle Storie di Erodoto, lo storico-scrittore nutre di fronte al mythos, davanti alla storia raccontata dal mito, viene ad aggiungersi l’inquietudine positivista provocata, nelle società dominate dalla scrittura, dalla natura ‘storica’ del mito, dalla sua realtà di fronte ai fatti, dalle sue relazioni con la cornice sociale, politica o anche economica. Il sospetto – cosciente o meno – nutrito nei confronti della figura del Mito dallo storico ‘realista’ era ovvio si precisasse a contatto con una analisi che privilegia, nella sua pratica, le relazioni concettuali latenti e rifiuta, in una prima istanza, il senso esplicito del racconto. Non sorprende, dunque, che le principali obiezioni mosse ad un saggio sulla mitologia degli aromi in Grecia13 si raggruppino attorno alle ‘realtà’ storiche, ora neglette ora radicalmente incomprese. In una serie di osservazioni che invitano al dialogo, Pierre Lévêque14 lamenta che la decifrazione dei differenti piani semantici non si realizzi «in un quadro più attento alle realtà storiche»15. In una lunga critica romana, violenta fino all’anatema, Giulia Piccaluga, richiamandosi ad un’interpretazione del ‘metodo storico-religioso’16, denuncia il fallimento del tentativo strutturalista, che falsificherebbe sistematicamente le relazioni tra mito e storia. La convergenza di queste due critiche, dagli intenti e dalle aspirazioni ben diverse, indica l’importanza della disputa, la cui posta altro non è che il rapporto nodale tra Demetra e Adone, a tutti i livelli e nei differenti piani dell’insieme mitico analizzato. Per Pierre Lévêque, attento al processo storico di genesi del culto, le Tesmoforie, festa demetriaca, hanno tutte le probabilità di risalire fino al II millennio, laddove evidentemente il semita Adone è l’ultimo arrivato in terra di Grecia17. Il baratro aperto dalla cronologia tra la divinità greca autoctona ed il dio straniero d’Oriente renderebbe impossibile all’opposizione Adone/Demetra di designare una struttura portante della mitologia greca. Due termini di età diversa non possono costituire che una cattiva coppia.
Per Giulia Piccaluga, il cui quadro di riferimento è molto più ampio, l’analisi misconoscerebbe una realtà storica essenziale: nel corso dei millenni, per le culture più diverse, ed in Grecia come altrove, la cerealicultura, la sfera demetriaca, non può instaurarsi prima che sia sparita la civiltà dei cacciatori-raccoglitori18. In altri termini, il cacciatore Adone appartiene a una storia il cui senso è dato appunto dall’emergere di una economia cerealicola. Entrambe le critiche scelgono come banco di prova la realtà storica, ma – ironia del caso o astuzia della storia – la principale obiezione di G. Piccaluga è il contrario di quella formulata da P. Lévêque: l’uno mi rimprovera di aver trascurato la precedenza temporale di Demetra rispetto ad Adone, l’altra mi accusa di aver ignorato che quella stessa divintà dell’alimentazione a base di cereali è posteriore rispetto ad Adone. La contraddizione tra i due storici non intacca il credito di cui gode generalmente la cronologia. Tutt’al più il disaccordo invita ad interrogarsi sui rispettivi presupposti del ricorso, nel caso specifico, alla diacronia e sulla configurazione implicita, nell’uno e nell’altro caso, del richiamo alla realtà della Storia. La discussione, allora, si incentrerà sui procedimenti di analisi e sui problemi di metodo, in maniera da mettere ampiamente a nudo il gioco dei problemi che ciascuna interpretazione mette in moto al fine di analizzare i miti e assegnar loro un posto nell’insieme delle produzioni mentali e simboliche d’una società.
Per P. Lévêque, il riferimento alla storia non è, in questo campo, né accidentale né pretestuoso; è, al contrario, la via regia di...