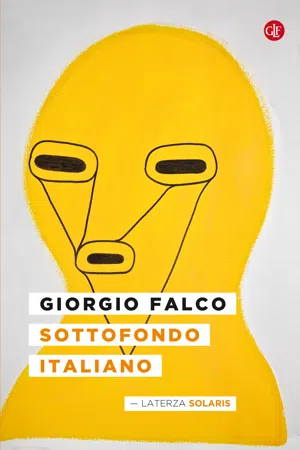Giocavamo nell’hinterland milanese, su terreni ritagliati tra capannoni, parcheggi di supermercati, fabbriche, ciminiere novecentesche, scritte rosse sui muri soppiantate da simboli neri, campanili di chiese in cemento armato edificate negli anni Sessanta, cascine e quanto restava dell’esperienza millenaria di irrigazione dei campi tramandata da monaci cistercensi del Diciassettesimo secolo; all’inizio, nelle categorie Pulcini ed Esordienti, eravamo forti, sembrava così semplice vincere medaglie e sollevare al cielo i trofei, aggregarsi alle urla, frasi sconnesse di giubilo e dominio. Un paio di noi sarebbero andati a giocare nelle giovanili dell’Inter e del Milan. Uno in particolare, pochi anni più tardi, da ventenne centrocampista di una squadra di serie B, avrebbe marcato uno svogliatissimo e appesantito Platini, in una partita estiva di Coppa Italia.
Noi invece avevamo smesso di allenarci seriamente, iniziando a pensare al vuoto in cui stavamo crescendo. Una specie di depressione si era insinuata per sempre e ci faceva arrivare in ritardo sulla palla, fiacchi, svagati, le gambe molli, ci muovevamo in una crepa, succubi del gioco avversario: bastavano pochi minuti, una finta, una triangolazione veloce per tagliare fuori centrocampisti e difensori, e subire il primo di una lunga serie di gol.
Non è successo niente, ripeteva l’allenatore, mentre si alzava dalla panchina e calpestava la linea bianca del fallo laterale, e batteva le mani per rincuorarci, senza credere alle parole, al gesto. Non volevo vincere coppe e campionati, ma non desideravo nemmeno perdere: forse volevo soltanto smettere di giocare, uscire dal meccanismo. Le prime volte recriminavo contro me stesso, raggiungevo il pallone finito in fondo alla rete, mi chinavo e lo raccoglievo, volevo mangiarlo, a volte lo stringevo tra le mani e lo colpivo con la fronte, a testate, come avevo visto fare nei film di kung fu. Gli avversari festeggiavano ancora, sbuffavo verso l’orizzonte definito dai ganci e dalle sbarre dietro la porta, mi lamentavo con il portiere e i compagni di reparto, e a salire fino ai centrocampisti e agli attaccanti, che non avevano pressato come avrebbero dovuto fare.
Nello schema calcistico di quell’epoca, ero definito «libero» o «battitore libero», il giocatore schierato alle spalle degli altri difensori, il tappabuchi senza marcature fisse, sempre pronto a intervenire sugli attaccanti sfuggiti al controllo dello stopper e dei due terzini. Il libero aveva anche compiti di organizzazione, era il regista difensivo che interrompeva l’azione degli avversari, tramutandola in un contropiede d’attacco. «Si sgancia in avanti», era la frase tipica di quegli anni, quando il libero lasciava per qualche secondo la posizione arretrata per ribaltare l’inerzia di un’azione a proprio favore.
Dai, andiamo su, via, tieni il nove in mezzo, occhio all’undici sul secondo palo, dai, adesso su, tutti in linea, andiamo, accorciamo, saliamo, su!
Parlavo molto più di quanto toccassi il pallone, coordinavo gli altri, mi sentivo responsabile di tutto, anche della nostra pochezza: volevo reagire, e ciò che mi infastidiva di più era proprio la flemma dell’allenatore. Apprezzavo il fatto che non ci accusasse davanti ai giocatori e ai tifosi avversari, ma da lì a negare la realtà! Non è successo niente?
Una giornata di campionato giocavamo su un campo fangoso, in trasferta. Era ricavato dentro un’enorme voragine ubicata tra la ferrovia e il cavalcavia di una circonvallazione. Quando rifiatavo e alzavo lo sguardo, vedevo gli scarichi delle automobili e degli autobus che galleggiavano sopra le nostre teste tra allucinazioni azzurrine, come se giocassimo su un’altura sudamericana; anni dopo sarebbe diventato un parcheggio, un parcheggio adiacente a un altro parcheggio. Quel giorno avevamo appena subito un gol, a pochi minuti dall’inizio della partita. Prima che il gioco riprendesse, mi ero avvicinato alla panchina dell’allenatore, lo avevo affrontato con decisione. «Allenatore – mai avrei potuto dire mister – come fa a dire che non è successo niente? Sono passati cinque minuti e stiamo già perdendo!» L’allenatore aveva ribadito: «Tu stai tranquillo, e pensa a giocare».
Alla fine, sebbene recalcitrante, avevo eseguito gli ordini. Ero tornato a testa bassa in difesa, l’unico gesto di sfida all’esistente era stata l’andatura un po’ ciondolante, la camminata da annoiato, quasi come quella dei ragazzi di questi anni contemporanei, la postura indolente a simulare distacco, le braccia lungo i fianchi, in attesa che gli avversari scendessero di nuovo sulle fasce, con sovrapposizioni che li rendevano infiniti e vanificavano il mio rintuzzare sempre più goffo, tardivo. Sono andato avanti così, ancora per un paio di campionati, poi ho smesso di giocare.
Poco prima dell’inizio della stagione calcistica, il presidente passava da casa, mi citofonava, e mentre rispondevo già sentivo attraverso la cornetta il suono del motore dell’Alfetta sulla quale ero salito tante volte per andare in trasferta. Il presidente pensava che volessi smettere per un anno, in modo da diventare proprietario del mio cartellino e propormi a una squadra più forte: ciò che nell’attuale terminologia sportiva è definito parametro zero. Non voleva perdermi senza intascare i soldi della vendita del cartellino, e così si tutelava, passava da casa ogni anno per farmi firmare. Scendevo in pantaloncini e ciabatte da mare portando con me la penna che usavo per i compiti delle vacanze. Il presidente, appena mi vedeva, spegneva il motore e chiacchieravamo per qualche minuto: i risultati sportivi della stagione trascorsa, le prospettive del campionato seguente, il nuovo allenatore molto più ambizioso. «Torna, vedrai, non te ne penti».
Quando penso alla fine degli anni Settanta, riverberata come sempre capita fino ai primi due o tre anni del decennio successivo, conservo l’immagine del cofano caldo dell’Alfetta. Il presidente, l’ultima volta che era passato da casa, come se fosse stato un postino e il mio cartellino la ricevuta di una raccomandata, mi aveva fatto firmare sul cofano, senza nemmeno spegnere il motore dell’Alfetta, su cui mi ero chinato tranquillo, in pantaloncini e ciabatte da mare, per siglare la mia esclusione.
Siamo cresciuti, soprattutto coloro che sono nati da metà degli anni Settanta in poi, terrorizzati dall’eventualità del conflitto sociale. Non so quali istituzioni abbiano più influito nell’educare all’inerzia collettiva, alla sottomissione: la famiglia, la scuola, la parrocchia, il bar, il riflesso degli schermi dei videogame, il suono della moneta che cadeva nella fessura di una qualsiasi dipendenza, la televisione, i settimanali colorati, i cortili, la compagnia sulle panchine dei parchetti.
Stai tranquillo. Non immischiarti. Fatti gli affari tuoi. Pensa solo a te stesso, all’affermazione della tua individualità o al tuo gruppetto di amici, con cui ti spalleggi difendendo le posizioni acquisite e aggredendo qualche singolo sventurato, utilizzando la medesima logica del branco. Gioca con il linguaggio, assegna a questo branco il nome di rete, di talento relazionale. Lascia perdere qualsiasi altra cosa, a meno che non serva a darti maggiore visibilità. Coltiva la tua biografia, irrorandola d’acqua e di fertilizzante chimico, devi stare in piedi forte e rigoglioso, come una rosa malata di sé, ma sempre pronta a essere recisa, per rinascere in un nuovo giardinetto. Vivi senza l’aiuto di niente, tranne che dei tuoi amici. Insieme siete disposti a fare qualsiasi cosa, a travolgere chiunque, pur di primeggiare, pur di salvarvi. Pensi che, in fondo, aveva ragione Margaret Thatcher: la società non esiste.
Eppure da bambino, quando uscivo di casa, incontravo grandi magazzini, supermercati, catene di abbigliamento, concessionarie, il luccichio del Natale si estendeva in ogni giorno dell’anno, ma vedevo l’impossibilità di molti – delle generazioni precedenti la mia – a conciliarsi con tutto questo: sentivano la necessità di un dialogo comune per risolvere questioni personali, che avevano un valore esemplare, diventavano pubbliche, e grazie alla discussione i problemi privati erano ciò di cui la politica doveva occuparsi.
Ma i problemi personali non si trasformavano mai nel caso clinico e pietistico, confessionale pubblico dove sventolare le proprie miserie compiaciute. Se non arrivava una soluzione condivisa, allora prorompeva la rabbia, per la disuguale distribuzione della ricchezza, dell’accesso allo studio, alla sanità, alla casa, e la necessità di scontro diventava vitale, come l’aria inquinata che respiravamo. Ma tutto questo sentire comune era condiviso da una parte minoritaria del mondo che mi circondava. In quale democrazia vivevo?
Sdraiato sulla sabbia adriatica, fissavo il segno dei corpi, forme allucinatorie del pomeriggio ancora infantile, le rifrazioni della luce sull’acqua grigia degli anni Settanta del Novecento. Ero supino, dinnanzi alle medesime dinamiche – che ignoravo fossero lavorative e produttive, ancor prima che umane – di pausa momentanea dall’aggressività, dalla competizione, e invece l’apparente sospensione provvisoria, la distrazione di massa, l’evasione da se stessi, l’ideologia del ritornello erano la celebrazione di un fantasma minaccioso, degli undici mesi precedenti e degli undici successivi: le ore nelle fabbriche, negli uffici, nelle aule scolastiche, la vita.
Accanto a me, persone un po’ più giovani dei miei nonni, un po’ più vecchie dei miei genitori, e coetanei devastati da geometriche lentiggini. Turisti tedeschi occidentali, soddisfatti delle quattro settimane di ferie, dardeggiavano le proprie lingue alle estremità di cialde industriali, leccavano il medesimo gelato con cui mi identificavo, parlavano una lingua ostile solo in apparenza; gli italiani con gli occhi socchiusi e appagati dalla propria abbronzatura brasiliana tenevano il tempo del ritornello urlato dai jukebox, con impercettibili movimenti dei piedi nella sabbia calda. Chi erano questi uomini nati nei primi decenni del Ventesimo secolo? Come avevano attraversato il nazifascismo? Ne eravamo davvero usciti?
Nonostante le scritte rosse sui muri, che leggevo come un rosario dal finestrino dell’autobus, ero circondato dal fascismo. Sono stato fortunato, ho avuto una maestra elementare che è stata fondamentale nella mia formazione di essere umano. Era nata nel 1923, e già dai primi anni di scuola ci aveva parlato della nostra storia, da dove venivamo. E questo instillava in un bambino di sette anni una consapevolezza oggi impensabile.
Di notte non sognavo mai la mia maestra, ero chiamato alla lavagna da un uomo di età indefinibile: poteva avere quaranta o cinquant’anni, un militare nato in pieno fascismo, tra il 1925 e il 1935. Usciva da un enorme uovo nero, posto su un...