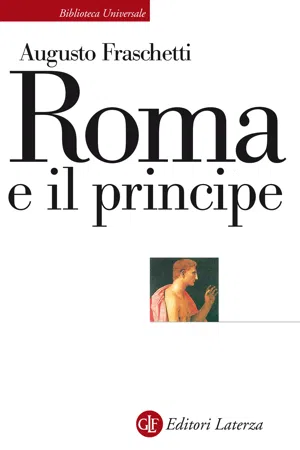
- 380 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Roma e il principe
Informazioni su questo libro
Distruggere l'essenza repubblicana mantenendone in vita le sembianze: i modi e le forme in cui si realizzò l'ambiguo progetto di Augusto, nella nuova edizione di uno studio che è ormai un classico della storiografia sull'antica Roma.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Capitolo secondo.
Il tempo del lutto
1. Morte del principe e tumulto
Augusto morì a Nola, in Campania, il 19 agosto del 14 d.C.: «giorno tristissimo», come esso fu registrato in un calendario. Secondo Suetonio, in quel «giorno tristissimo», poco prima di morire, il vecchio principe si sarebbe preoccupato e avrebbe chiesto ripetutamente («identidem exquirens») se fuori ci fosse già tumulto a causa sua («an iam de se tumultus foris esset»); se all’esterno, dunque, ci fosse già tumulto in previsione della sua scomparsa. Nonostante l’allarmato e ripetuto affiorare di questa preoccupazione, è probabile che coloro che gli erano accanto (anche Tiberio accorse per tempo al suo capezzale) lo abbiano tranquillizzato. La morte di Augusto infatti fu composta, «dolce e come sempre l’aveva desiderata»: «chiese uno specchio, dette ordine che gli pettinassero i capelli e che gli aggiustassero le guance che cadevano; quindi, domandò agli amici ammessi in sua presenza se a loro parere avesse recitato bene il mimo della vita». Con alcuni versi in greco, «aggiunse anche la formula finale: se il gioco vi è piaciuto, applaudite e tutti accompagnatemi con gioia»1. Dopo la conclusione del mimo lungo e stupefacente della vita di Augusto, mentre a Roma si preparavano i suoi fastosissimi funerali, Tiberio – come ricollegandosi alle ultime preoccupazioni del principe scomparso – indirizzò un editto al popolo («populumque edicto monuit»). L’editto consisteva in un ammonimento nel 14 d.C., forse apparentemente singolare ma, comunque, carico di significato: che non pretendessero che il corpo di Augusto fosse cremato nel Foro invece che al campo Marzio, nel luogo già prescelto per l’innalzamento della pira; che non si ripetessero, nel corso di questi funerali, i disordini avvenuti un tempo durante i funerali del divo Giulio, turbati allora con troppo ardore e con eccessiva passione2. La notizia dell’editto di Tiberio è riportata da Tacito, insieme alle voci cui esso avrebbe dato origine. Secondo Tacito, chi aveva vissuto di persona il giorno dei funerali di Cesare o ne aveva udito il racconto dai genitori, nel giorno dei funerali di Augusto rise di cuore alla vista dei soldati disposti come a presidio, ridendo implicitamente tanto di Tiberio quanto del suo editto: «dopo un lungo dominio, dopo avere anche procurato la fortuna degli eredi a danno della repubblica, ora il vecchio principe doveva essere addirittura protetto con l’aiuto dei soldati per riuscire ad avere una tranquilla sepoltura». Dunque, nel 14 d.C., da parte di Tiberio, si sarebbe trattato secondo Tacito di preoccupazioni assolutamente inutili, in maniera certo molto diversa dal giorno dei funerali di Cesare: quando – ormai quasi sessant’anni prima – la servitù per i Romani era esperienza ancora recentissima e appunto in quella circostanza, grazie all’assassinio del dittatore, si era anche provveduto a rivendicare la libertà, sebbene in prospettiva – e alla luce dei risultati che ne erano conseguiti – con esito infelice («diem illum crudi adhuc servitii et libertatis improspere repetitae»)3.
Le preoccupazioni di Augusto poco prima di morire «se all’esterno ci fosse già tumulto a causa sua», l’editto di Tiberio al popolo con l’esplicito richiamo – come a un precedente irripetibile – ai funerali di Cesare e ai tumulti effettivi che li avevano accompagnati, evidentemente chiariscono bene perché lo stesso Augusto si fosse preoccupato per tempo di raccogliere in un apposito scritto «le disposizioni sui suoi funerali» («mandata de funere suo»)4. Più in generale, se nonostante lo scetticismo di Tacito non si trasportano meccanicamente periodizzazioni di storia politica in contesti di storia urbana, questi stessi elementi possono introdurre nel loro complesso a una problematica caratteristica (nella prospettiva che indicheremo) dell’età di Augusto e di Tiberio. Dopo il tempo della festa, delle nuove feste che come le antiche debbono dare gioia ai cittadini e invadono i calendari, è d’obbligo ora il passaggio al tempo del lutto pubblico, ai suoi apparati e ai suoi dispositivi simbolici, entrambi sotto il segno non solo della tristezza ma anche della degradazione; quando a Roma, nell’età di Augusto e di Tiberio, per la morte del principe o di altri membri della sua famiglia, il lutto pubblico deve scendere sulla città e avvilupparla in toni eminentemente lugubri.
Tuttavia, per comprendere meglio la forma specifica di questo tipo di tempo (che ha anch’esso riverbero nei calendari), la sua funzione, le sue scansioni e le sue modalità anche di natura cerimoniale, è necessario in primo luogo – come suggerisce implicitamente lo stesso editto di Tiberio del 14 d.C. – ripercorrere di nuovo i funerali di Cesare nella loro caratteristica di giornata per eccellenza irripetibile; ricostruire quindi gli sforzi successivi volti a cancellare, in avanzata epoca augustea, almeno alcuni tratti di memoria sia di quel giorno sia di quei funerali: nel luogo geometrico della vita cittadina che a Roma è rappresentato dal Foro; con maggiore esattezza, in quel punto del Foro dove nel 44 a.C. i ceti pericolosi della città avevano cremato il corpo di Cesare e dove era sorto in seguito l’altare del tempio del divo Giulio. Dopo un simile percorso, come attraverso una filigrana di sottili ma tenacissimi contrasti, è necessario in secondo luogo esaminare le assunzioni di lutto pubblico a Roma in occasione della scomparsa di Augusto, di altri membri della «domus Augusta» o di personaggi eccellenti comunque imparentati con il principe. Poiché, appunto da questo esame, emergerà con forza il nucleo più ampio dei problemi che le assunzioni del lutto pubblico possono riflettere – e talvolta eventualmente esse stesse provocano – all’interno della città: più in particolare, dei suoi ordini e delle sue componenti istituzionali; ormai, in modo quasi irresistibile, nella scansione degli stessi rapporti tra cittadini e casa del principe.
Da tempo è stata messa in rilievo la stretta connessione che intercorre a Roma tra lutto pubblico, tumulto e iustitium. Con una definizione evidentemente giusta (ma che per l’età di Augusto e di Tiberio all’evenienza può anche essere ampliata), un commentatore antico di Cicerone intendeva per iustitium l’arco di tempo in cui cessa «in re publica» la trattazione di «civilia negotia», per il sopravvenire – dobbiamo aggiungere – di disgrazie pubbliche gravissime che si abbattono (o che si intende che si abbattano) su tutti i cittadini5. In terzo luogo, dunque, alla fine del nostro percorso, sarà ripresa in esame anche la connessione tra lutto pubblico, tumulto e iustitium, con l’avvertenza preliminare che essa in epoca augu...
Indice dei contenuti
- Prefazione alla nuova edizione
- Premessa alla prima edizione
- Parte prima. Il tempo
- Capitolo primo. Il tempo della festa
- Capitolo secondo. Il tempo del lutto
- Parte seconda. Lo spazio
- Capitolo terzo. Le articolazioni dello spazio urbano a Roma in epoca tardorepubblicana
- Capitolo quarto. Spazio urbano, ceti pericolosi e riorganizzazione augustea
- Parte terza. Culti della città e culti della casa del principe
- Capitolo quinto. Gli eroi di famiglia
- Capitolo sesto. «Cognata numina»
- Abbreviazioni bibliografiche
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Roma e il principe di Augusto Fraschetti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a History e Ancient History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.