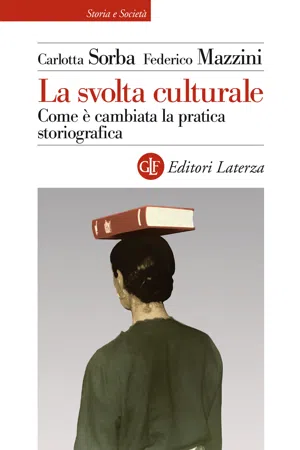1.
Genesi e sviluppi di una svolta culturale
Sessualità, immaginari, emozioni, paure. Riti funerari, abbigliamento, videogame, tifo sportivo. Quarant’anni fa tutti questi e tanti altri argomenti sarebbero stati da molti ritenuti indegni dell’impegno di uno storico professionista. Oggi questi temi sono oggetto di legittima e in alcuni casi frequente attenzione storiografica. Molto hanno inciso in questo cambiamento gli indotti di ciò che chiamiamo svolta culturale, una trasformazione profonda che ha coinvolto oggetti di studio, strumenti e fonti. È dunque importante, in questo primo capitolo, delinearne a grandi tratti la genesi e i primi sviluppi, per concentrarsi poi nei capitoli seguenti sui suoi principali riferimenti teorici.
Sebbene le sue tempistiche e le sue forme siano state in parte diverse nei vari contesti nazionali possiamo dire che una svolta culturale è stata ben visibile nella storiografia, a livello globale, negli ultimi due decenni del XX secolo. Un approccio rinnovato agli studi storici che è stato definito «nuova storia culturale» si è affermato a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, interagendo con un corpo di riflessioni teoriche che ne hanno nutrito gli sviluppi e per certi versi forgiato la fisionomia. Una serie di suggestioni concettuali e metodologiche provenienti dal dibattito più ampio delle scienze umane (dallo strutturalismo prima, e dal poststrutturalismo poi) ha raggiunto quasi ovunque la storiografia e contribuito a modificarne l’agenda e gli approcci. Queste influenze si sono intrecciate con la specificità delle diverse tradizioni storiografiche e filosofiche nazionali, producendo traiettorie non del tutto omogenee. Come numerosi studi hanno mostrato, i percorsi nazionali sono stati diversi, sia nei tempi di affermazione sia nelle aree di ricerca privilegiate, e persino nei rapporti più o meno conflittuali con altri approcci considerati «concorrenti» (la storia sociale, innanzitutto, ma anche la storia politica e delle idee).
La nuova storia culturale ha assunto dunque fisionomie diverse in Francia o in Australia, in Gran Bretagna o in Canada, per cui risulterebbe inutile individuare una sorta di «ortodossia» che definisca una volta per tutte questo approccio di ricerca. Ciò che si è prodotto è piuttosto il definirsi di uno spazio di scambio e di riflessione in cui si individuano sollecitazioni teoriche e metodologiche indubbiamente comuni alla cui sfida si risponde con un inventario articolato di approcci, fatto di specificità nazionali e insieme di incroci più o meno inaspettati, di prestiti e appropriazioni reciproche.
Eppure nelle premesse di quei percorsi si individuano almeno due matrici originarie, segnate anch’esse da fitti scambi, che hanno quantomeno preparato il terreno alla svolta stessa e ne sono state importanti battistrada. Da esse vale la pena partire per dare uno spessore temporale più lungo al nostro ragionamento. La prima si colloca nel solco della scuola delle Annales e in particolare nell’intuizione, legata in primo luogo a Lucien Febvre, che fosse possibile e necessario per gli storici allargare il proprio sguardo alle mentalità e al mondo affettivo. La seconda invece è individuabile in Gran Bretagna, nel quadro di una storia del lavoro di matrice marxista che a partire dagli anni Sessanta conosceva nuove importanti sollecitazioni proprio sul fronte della dimensione culturale.
1. In Francia: l’interesse per la dimensione mentale e sensibile
Sviluppatasi in Francia tra le due guerre, la scuola delle Annales ha introdotto nel lavoro storico una serie di radicali novità. Ricordiamone qui solo alcune che l’hanno caratterizzata fin dalle origini e poi accompagnata nelle diverse fasi/generazioni che si sono susseguite nel corso del Novecento. Un primo elemento di grande innovazione consisteva nel dialogo serrato e nell’interazione con le scienze sociali, in modo particolare con la geografia, la sociologia, l’antropologia, quelle «discipline sorelle» che dovevano consentire un abbandono deciso della narrazione cronachistica ed erudita in direzione di una storia-problema, una disciplina che doveva configurarsi come una «scienza dei problemi da porre». Ciò doveva avvenire nel quadro di una decisa apertura verso le fonti più diverse e non solo scritte, e in nome di una critica profonda alla storia evenemenziale. Era un rifiuto del primato della storia politica e diplomatica in favore di una histoire totale che accordasse grande attenzione alla dimensione economica e sociale delle società del passato, ma anche, e arriviamo qui al punto, a quella mentale.
È Lucien Febvre a porre le premesse teoriche di un approccio alla storia delle mentalità che avrà un ruolo fortemente simbolico negli sviluppi della scuola stessa. Lo fa in due saggi chiave, comparsi rispettivamente nel 1938 (Histoire et psychologie) e nel 1941 (Comment reconstituer la vie affective d’autrefois), in cui sostiene l’impellente necessità di allargare il lavoro dello storico allo studio di strutture mentali e sensibilità del passato, verso ciò che definisce con una espressione molto efficace l’outillage mental (l’attrezzatura mentale) di una società, di cui rivendica il carattere storico e situato. L’espressione allude ad un insieme di strumenti intellettuali (parole ma anche simboli, immagini, concetti) a disposizione del pensiero in una determinata società. Nonostante non si nasconda le difficoltà del compito, lo studioso ne fa un elemento irrinunciabile di ridefinizione del lavoro storico intorno ad un obiettivo fondamentale: lo studio dell’essere umano nel passato come essere sociale in permanente interazione con il contesto in cui si colloca e al contempo inventivo rispetto ad esso.
Si tratta dunque per Febvre di indagare intorno ai sistemi di rappresentazione di un’epoca, ad un insieme di categorie della sensibilità, dell’espressione e della concettualizzazione che possono essere colte misurandosi in modo privilegiato con la biografia individuale. Sia l’opera su Martin Lutero del 1928 che ancor più quella su Rabelais pubblicata nel 1942 (Il problema dell’incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais) testimoniano di uno sforzo rivolto a cogliere innanzitutto il rapporto dialettico tra rappresentazioni individuali e condizionamenti collettivi. Il fuoco sul grande umanista francese è infatti per Febvre, ben più che un affondo sulla sua personalità, un modo di accedere alla strumentazione mentale degli uomini del XVI secolo e di delimitare l’universo dei possibili relativamente al tema del credere o del non credere religioso. Se dunque l’interesse principale rimane per la dimensione sociale e collettiva, essa tuttavia si esprime per Febvre essenzialmente nella coscienza individuale e nella sua relativa autonomia e qui va indagata.
Anche per l’altro fondatore della rivista e della scuola, Marc Bloch, l’attenzione per le attitudini mentali di un’epoca è parte rilevante di una nuova aspirazione alla ‘storia totale’ in cui tutti gli aspetti di una società interagiscono tra loro. E tuttavia l’approccio adottato è diverso, come risulta già evidente nel famoso studio sui Re taumaturghi pubblicato nel 1924. Qui egli affronta un tema importante della mentalità medievale, la credenza nel potere magico e guaritore dei re, ricollegandolo al più ampio processo di costruzione della sacralità della figura regale e alla volontà di consolidarne il potere. Come risulta ancora più evidente nei volumi successivi sulla Società feudale (1939), lo sguardo di Bloch è prioritariamente incentrato sulle strutture sociali, politiche, giuridiche e della parentela che contribuiscono a costruire, in modo anche non cosciente, i sistemi di rappresentazione. Se quello di Febvre è stato definito un esercizio di psicologia storica, quello di Bloch è piuttosto un approccio di antropologia storica che ricostruisce i sistemi di rappresentazione a partire da riti e pratiche simboliche collettive fortemente innestate nel sostrato sociale e dipendenti dalla loro logica.
Si impostano così in quella fase originaria del lungo percorso annalistico due diversi modi di intendere la storia delle mentalità, al tempo non adeguatamente esplicitati, che contribuiranno nel lungo periodo ad una certa indeterminatezza concettuale della nozione stessa. Dopo una sua eclissi nella fase successiva, dominata dal magistero di Fernand Braudel e da altre priorità tematiche e metodologiche, lo studio delle mentalità riappare infatti con forza negli anni Sessanta e Settanta. A George Duby va il merito di avere ripreso le sollecitazioni di Febvre e di averne sottolineato le potenzialità di arricchimento se intrecciate con le nuove traiettorie della psicologia sociale americana (1961). Ma se si eccettua il riconoscimento a Febvre della paternità teorica della nozione, gli studi che si moltiplicano in quegli anni, in direzioni anche molto diverse, mostrano una maggiore affinità con l’approccio antropologico di Bloch. Sotto la nozione unificante di mentalità si sviluppano così studi su alcuni sentimenti (l’amore o la paura), su alcune forme di credenza (il Purgatorio e il diavolo), sull’universo gestuale e comportamentale di un villaggio occitanico, ma anche su istituzioni sociali importanti come il legame feudale stesso.
Pur non acquisendo una forza epistemologica del tutto coerente la storia delle mentalità risulta particolarmente efficace nel combattere l’anacronismo ancora molto diffuso negli studi storici, invitando cioè a prendere atto della distanza che ci separa dall’esperienza di chi ci ha preceduto e ad evitare di proiettare nel passato le categorie mentali e comportamentali del presente. È dunque con la storia della mentalità, che otterrà grande diffusione e successo a livello globale, che compie i primi passi una storia culturale alla francese che troverà sollecitazioni del tutto nuove nel successivo confronto con il poststrutturalismo (vedi box a p. 28), ma continuerà a presentare se stessa in una linea di forte continuità con l’eredità lunga della scuola delle Annales.
Le sollecitazioni di Lucien Fevbre troveranno poi nuovi sviluppi in Francia nella direzione di una «storia della sensibilità» attenta anche agli intrecci tra fattori psichici, corporei ed emozionali. Sono in particolare gli studi di Alain Corbin che a partire dagli anni Ottanta hanno messo al centro dell’indagine storica la dimensione percettiva e sensoriale nel passato. Odori e odorato, suoni, rumori e relativi paesaggi sonori possono essere considerati dei costrutti sociali e come tali essere studiati, aprendo squarci importanti sulla vita vissuta di uomini e donne del passato.
Come ricostruire la vita affettiva di un tempo
di Lucien Febvre
«Storia e sensibilità. Ecco un argomento nuovo. Non conosco un libro che ne parli. Non vedo neppure qualche pubblicazione dove si trovino formulati i molteplici problemi che esso implica. Ed ecco dunque – si perdoni ad un povero studioso di storia questo grido da artista – ed ecco dunque un bell’argomento!». Così inizia il saggio pubblicato da Lucien Febvre sulla rivista «Annales» nel 1941, poi raccolto nel volume principale dei suoi scritti teorici e divenuto una sorta di incipit simbolico dell’approccio storico al sensibile. Il breve scritto ha quasi il registro di un manifesto in cui lo studioso si dice persuaso che la sfida di accedere alla vita mentale e sentimentale del passato doveva necessariamente essere accolta dagli storici del suo tempo. Si trattava, scrive, di «un’impresa seducente e, in pari tempo, terribilmente difficile», sia perché niente appariva più rigorosamente individuale delle emozioni, sia perché le tracce documentarie per accedervi erano rare e difficili da maneggiare.
Entrambi i problemi potevano però, e dovevano secondo Febvre, essere superati. Se infatti la vita sensibile ed emozionale ha caratteri di estrema soggettività, essa è però anche il risultato della vita sociale, il prodotto di «un sistema di incitamento interindividuale che si diversifica a seconda delle situazioni e delle circostanze», dunque della costante interazione tra l’individuo e le reti di relazioni in cui è incardinato. E le risorse per accedervi non sembravano mancare, se ad uno sforzo potente di erudizione si associavano l’immaginazione e la mobilitazione di fonti specifiche, da utilizzare con tutte le precauzioni critiche del caso. Egli inizia dunque a segnalarne alcune, sicuro che altre si aggiungeranno: lo studio del linguaggio dei sentimenti e delle sue trasformazioni; le opportunità aperte dall’iconografia artistica, già utilizzata ad esempio per cogliere le variazioni ...