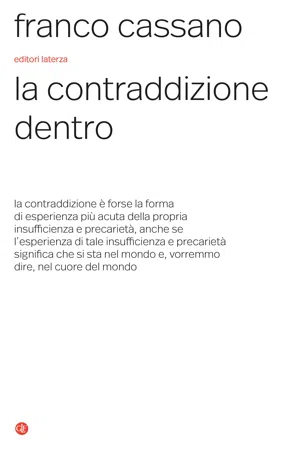1.
Nella mischia
Partiamo subito dal punto che riteniamo da sempre più importante e che temiamo si perda: la centralità della contraddizione, sempre riaffermata anche nei momenti apparentemente più conciliati e distesi. Non sempre essa ha la stessa intensità e non sempre assume la stessa forma, ma è fuori discussione che sia il fuoco intorno a cui ruota tutto il resto. Ogni tentativo di capire non può vivere senza una costante esperienza della contraddizione, che non può essere lasciata all’ingresso per entrare poi nel regno armonico e sterilizzato del pensiero corretto, né può essere superata, come una semplice tappa, un incidente o un errore. La contraddizione è forse la forma di esperienza più acuta della propria insufficienza e precarietà, anche se l’esperienza di tale insufficienza e precarietà significa che si sta nel mondo e, vorremmo dire, nel cuore del mondo. E le contraddizioni attraversano tutta la strada su cui camminiamo. Ecco quindi un’osservazione preliminare: abbiamo sempre cercato non solo di non eludere le contraddizioni, ma di collocarci nel loro fuoco, senza nessuna tensione spettacolare ed esibizionistica, così oscena ma oggi anche così frequentata.
Una prima forma della contraddizione discende da quello che è stato il filo teorico del nostro lavoro e dalla spirale relativistica che avvolge dentro di sé la sociologia della conoscenza: se ogni pensiero è condizionato socialmente, come si può enunciare la validità in-condizionata di tale affermazione senza cadere in ostaggio di una contraddizione? E da questo confronto è discesa una nostra costante confidenza con le contraddizioni, gli ossimori e le antinomie, specialmente quando ci siamo accorti che c’era capitato di praticare l’antinomia del mentitore (“io sto mentendo”) prima ancora di averne nozione, nel corso delle prime, embrionali e rozze riflessioni di adolescenti. E confessiamo che tutti, anche i più notevoli tentativi di superare quell’antinomia ci hanno sempre insospettito, ci sono sempre sembrati un tentativo di mascherare l’imbarazzo del pensiero di fronte all’evidenza della propria fragilità.
Questa contraddizione ne comporta un’altra, quella, inerente al succedersi delle generazioni, tra l’imprinting originario, le esperienze e i valori della propria generazione e la consapevolezza, solo in apparenza ovvia e banale, che ogni generazione ha una sua impronta originale, che ne segna la differenza rispetto a quelle precedenti e a quelle successive. Ma questa contraddizione “sociologica” non va da sola perché ne comporta almeno altre due, strettamente contigue ad essa. La prima è quella che discende dall’incidenza epistemologica esercitata dalla differenza di età, differenza più volte sottolineata dai classici fino a diventare proverbiale, e che ama contrapporre ad una gioventù rivoluzionaria una vecchiaia conservatrice, in cui si fronteggiano una giovinezza che, disponendo di un immenso futuro, crede di poter mutare radicalmente il mondo, e una vecchiaia che, avendolo invece totalmente dietro alle spalle, guarda ogni mutamento con apprensione e timore.
L’altra contraddizione collegata all’età è quella che segna una generazione, formatasi dentro le alte speranze degli anni Sessanta, e il movimento sorprendente se non deludente della storia, la percezione, dopo tutti questi scarti, della tensione sempre più acuta tra il tener fede ai valori e la necessità di apprendere, tra quelli che pensano che mutare significhi tradire, e quelli per i quali invece resistere è sbagliato e patetico, tra quelli che non apprendono neanche di fronte all’evidenza contraria e quelli che si adattano a tutto cantandone le lodi. Ebbene noi, che pure apparteniamo a quella generazione, siamo tra quelli, non molti, che pensano invece che stare dentro questa tensione abbia costituito e costituisca una risorsa. In altre parole ricordiamo di non essere stati a suo tempo così giovani come lo erano i nostri coetanei, così come sappiamo di non essere oggi così vecchi, come lo è la maggioranza dei nostri coetanei. Abbiamo sempre percepito e avvertito come una spina e come uno stimolo la presenza dentro di noi delle ragioni che ci sfuggivano, l’esistenza delle ragioni in contrasto.
Più che una filosofia diremmo quindi che si tratta di uno stile filosofico, uno stile metodologico, che presuppone una precisa visione del mondo e dell’esistenza, dell’unico modo a nostro avviso per fronteggiare seriamente la molteplicità del mondo. Nulla di nuovo, perché si tratta di un atteggiamento filosofico che non fa che ripetere il movimento che fu già di Socrate, lo staccarsi dalle certezze collettive che ogni società produce, certezze necessarie all’esistenza quotidiana, ma non certo capaci di farci guardare il mondo in modo libero. All’inizio di ogni pensiero c’è questa partenza, questo distacco, questa solitudine, la presa di distanza dalle rassicurazioni e consolazioni, la scoperta che l’uomo è una creatura fragile e mortale gettata in un universo che lo sorpassa e non si cura di lui, e che pensare non significa nascondersi sotto le coltri di queste rassicurazioni comuni.
Il pensiero ha la sua dimensione iniziale in questa mobilità dolorosa, diversa dalla sua versione iper-moderna, nevrotica e bulimica, che sempre più rassomiglia ad una forma di dis-trazione, in una mobilità che nasce da uno strappo che fa abbandonare le cose amate e fidate, perché avverte che il mondo è largo, più largo delle nostre certezze. Questo movimento è in primo luogo trascendenza, capacità di uscire da sé, di guardarsi da un punto di vista superiore e più comprensivo. Ma anche questo approdare ad un punto di vista più alto non è un sedersi sul tetto dell’astrazione, da dove si crede di vedere tutto da un punto di vista superiore, stabile e definitivo, e quindi di capire. È una mobilità inquieta, che non si acquieta; sa che quel tetto è solo la sommità di una casa e che il mondo è pieno di case.
L’universo è grande, e nonostante i progressi della conoscenza, rimane circondato da una cornice indecifrabile: basta ricordare quanto recente sia l’affermazione del paradigma del big bang dopo secoli di universo newtoniano, eterno ed infinito, ma sempre uguale a se stesso, basta seguire il dibattito cosmologico più recente tra gli scienziati, per capire che noi umani non siamo gettati neanche al suo centro, ma in una sua periferia dalla collocazione incerta. Qui Pascal, ma anche Leopardi, sono completamente attuali, dei maestri da tornare continuamente a rileggere, non gli unici, ma quelli che stanno all’inizio, prima degli altri.
A questa fragilità e solitudine la religione costituisce la prima risposta. Con la religione l’uomo ha fatto di tutto per togliere questo smarrimento e mettere se stesso al centro dell’universo: le diverse forme di “centrismo” sono una risposta alla paura, alla percezione della nostra marginalità, l’auto-conferimento di una condizione speciale, l’auto-assegnazione alla protezione di una superpotenza capace di tutelare la nostra debolezza. La religione è soprattutto questo, il modo attraverso il quale l’uomo si auto-assegna un posto privilegiato nel mondo e nel cuore di Dio. Essa non potrà mai sparire dalla faccia del mondo perché “consiste nel credere che tutto quello che ci accade è straordinariamente importante”, perché riesce a dare all’uomo la convinzione che la sua vita possiede un significato speciale. “Ognuno è a se stesso un tutto – dice Pascal – perché, lui morto, tutto è morto con lui”.
Nulla però è più insopportabile del silenzio e dell’assenza di Dio. Questa esigenza di essere visibile a un Dio è un bisogno primario dell’uomo, e va rispettata, ma non può portare a confondere le cose. Ci si segna all’inizio e alla fine di un incontro di calcio e si ringrazia Dio per un goal come se gli altri, quelli che il goal l’hanno subito, non meritassero anch’essi di essere ascoltati. Non si tratta di un esempio marginale perché in questo sentirsi in presa diretta e in un rapporto privilegiato con Dio si manifesta quello che sta all’origine della religione. In questo “centrismo”, di cui l’uomo ha bisogno per orientarsi, per squadrare il foglio bianco del mondo, ci sono insieme la costruzione di un’identità e allo stesso tempo la spinta a buttare fuori campo l’avversario. Questa dimensione del sacro lo accompagna, perché ordinare vuol dire in primo luogo gerarchizzare, fondare una differenza tra centro e periferia (Berger, Gehlen, Eliade), noi e gli altri. Questo modo di usare Dio è molto diffuso e addirittura popolare: Dio è il mio protettore, tra me e lui c’è sempre un patto di protezione, anche se si tratta, per dirla con Woody Allen, di un patto mafioso tra soggetti disuguali a danno dei terzi.
Per parte nostra non riusciamo ad usare la parola Dio se non per sottolineare quella zona apparentemente ai margini ma immensa, in cui la luce della conoscenza dell’uomo non riesce ad arrivare, per segnalare l’esistenza di uno scarto tra quello che conosciamo e un fondo che rimane pur sempre oscuro e misterioso. La parola Dio è quindi per noi sinonimo di un insuperabile invito alla modestia. Così come non è difficile capire come e perché Dio possa essere l’unico amico o più modestamente l’unico appiglio nei momenti d’indigenza, in cui ci si sente perduti e senza aiuto, il destinatario del messaggio che infiliamo nella bottiglia che gettiamo in mare. C’è un oscuro e fitto traffico di rapporti tra la fragilità del mondo e i superpoteri attribuiti a Dio. Dio è senza dubbio, per i più deboli e non solo per loro, un’assicurazione contro le malattie, le disgrazie...