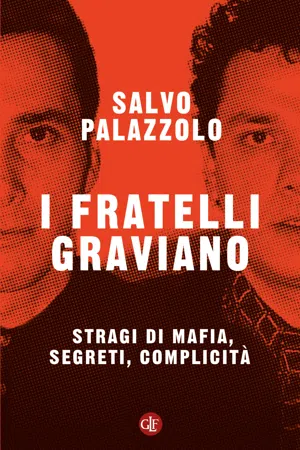1.
L’inizio sbagliato
I giorni della trasferta
Roma, Fontana di Trevi
Febbraio 1992
L’appuntamento è per le 15, confusi fra i turisti. Giuseppe Graviano è un po’ in anticipo, guarda le vetrine di un negozio di abbigliamento, gli piacciono le giacche e le camicie firmate. Ha potuto metterne poche nel bagaglio leggero che si è portato dalla Sicilia. È arrivato di buon mattino, in treno, e non sa ancora quanto dovrà fermarsi.
Il suo fidato accompagnatore, Cristoforo Cannella detto Fifetto o anche Castagna per la somiglianza con il presentatore televisivo, osserva invece attorno. Roma non è Palermo. E Fontana di Trevi non è Brancaccio, la periferia diventata il regno della famiglia Graviano. La prudenza non è mai tanta. Anche perché Giuseppe, che ha 28 anni, è un mafioso ricercato ormai dal 1984, uno dei più pericolosi dice la sentenza del maxiprocesso istruito dal pool guidato dai giudici Falcone e Borsellino, che il 30 gennaio è diventata definitiva. E ancora molto altro non si sa del giovane padrino condannato a 5 anni e 4 mesi, che passeggia tranquillo per il centro di Roma: ad esempio, a proposito degli omicidi che ha commesso, degli affari ereditati dal padre Michele ucciso nel 1982. Ben poco si sa, soprattutto, della fiducia sconfinata che il capo dei capi dell’organizzazione, Totò Riina, ripone in Giuseppe e in suo fratello Filippo, che è rimasto a Palermo, lui si occupa del lato finanziario delle operazioni.
Ora, c’è tanta gente attorno a Fontana di Trevi. Giuseppe Graviano continua a guardare le vetrine, in attesa che arrivino le persone con cui ha appuntamento. Che devono fare a Roma?
È da un po’ che ripenso con insistenza all’inizio del 1992. Trent’anni fa. In quei giorni, sentii i loro nomi per la prima volta. Don Pino Puglisi disse: «Qui a Brancaccio vivono dei giovani che esercitano una grande influenza negativa, potrei descriverli come una cappa su un quartiere che non ha neanche la scuola media. Sono i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano». Ma non capii di chi stava parlando, e non immaginavo che fossero i depositari dei segreti più profondi della mafia. In realtà, non sapevo neanche dove ero finito di preciso con i miei compagni della Fuci, la federazione degli universitari cattolici, i “ragazzi della contestazione perenne”, così ci chiamava qualche monsignore della Curia, e non era un complimento. Oggi, quei giorni a Brancaccio mi sembrano solo una storia storta, da qualsiasi parte la inizi a raccontare: come fai a frequentare un posto per tanto tempo e a non renderti conto di dove ti trovi?
Don Pino era stato nominato parroco di San Gaetano alla fine di settembre del 1990. Me lo ricordo quel pomeriggio. Alla riunione che tenevamo al pensionato San Saverio aveva iniziato a raccontare una delle sue solite barzellette sempre un po’ dissacranti su vescovi e cardinali. Poi, all’improvviso, era diventato serio e aveva detto: «Mi mandano a Brancaccio. Venite anche voi a darmi una mano? O volete restare per sempre qui dentro a discutere su come cambiare la città, la Chiesa e il mondo?». Momento di silenzio. Parrino, ma dov’è Brancaccio? «Vi ci porto io», sorrise. E da un giorno all’altro, ci ritrovammo all’estrema periferia orientale di Palermo, una zona carica di storia – ci informò don Pino – diventata ormai un quartiere popolare disagiato. Non c’era neanche un campetto di calcio, un cinema o un consultorio. Non c’era niente. Solo casupole e palazzoni venuti su troppo velocemente lì dove nel decimo secolo c’erano i giardini rigogliosi del castello di Maredolce, il palazzo dell’emiro Ja‘far, poi diventato una residenza del re normanno Ruggero II.
Erano le nove di sera quando arrivammo, non si vedeva anima viva in giro. Come se qualcuno avesse imposto il coprifuoco. È la prima immagine che ho di Brancaccio, una strada deserta e tante persiane chiuse. I fratelli Graviano, i mafiosi delle stragi e delle complicità eccellenti, si nascondevano lì dietro. Ma questo l’ho saputo anni dopo.
Pedinamenti
Adesso, lungo la strada che si affaccia sulla Fontana di Trevi – si chiama via delle Muratte – si fa avanti un giovane con occhiali Ray-Ban, foulard e sigaretta Merit fra le dita. Sembra un turista straniero, invece è Matteo Messina Denaro. Anche lui è un figlio d’arte parecchio apprezzato dal vertice di Cosa nostra, suo padre Francesco è l’anziano capomafia della provincia di Trapani che vorrebbe andarsene in pensione da quando ha saputo i piani di Riina. Matteo ha anche un vantaggio rispetto a Giuseppe Graviano: per la giustizia italiana è ancora un illustre sconosciuto, o quasi. E dunque pure lui ha buone ragioni per camminare sorridente per le vie della Capitale. Ha viaggiato tutta la notte in auto, su una Fiat Uno Diesel di colore azzurro, ma non sembra per nulla stanco. Gli ha fatto da autista un altro uomo di Brancaccio, Renzino Tinnirello detto u Turchiceddu per la carnagione scura.
«Amunì». Graviano fa cenno a Messina Denaro di sbrigarsi. Sono già le 15, e il lavoro che li aspetta è tanto. Ma all’appuntamento mancano altri due giovanotti appena arrivati da Trapani, loro hanno preso l’aereo e poi hanno affittato un’auto a Fiumicino, una Y10 bianca. Sono Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci. Uno fa il sicario, l’altro è un affermato grossista di gioielleria. Un giorno, Messina Denaro ha detto a Geraci: «Un amico vuole regalare alla fidanzata una parure da cento milioni. Provvedi subito, i soldi te li do io». Era il regalo di Giuseppe Graviano alla sua donna, Rosalia Galdi, che amici e parenti chiamano Bibiana. E Geraci consegnò la parure. Valore cento milioni di lire appunto, come chiesto, ma l’acquisto fu scontato del 50 per cento. Qualche tempo dopo, il boss palermitano fece avere i soldi a Matteo Messina Denaro, ma lui li rifiutò. E non volle sentire ragioni. «Noi siamo amici inseparabili», tagliò corto.
A Roma, i due amici hanno una missione da portare a termine. Quella che Salvatore Riina, u zu Totò, ha comunicato quattro mesi fa, nell’ottobre 1991, in una villa di Castelvetrano, nel cuore della provincia di Trapani. Giornata solenne, per pochi. Giuseppe Graviano si è presentato con il fratello Filippo, gli unici palermitani ammessi all’incontro. Non è cosa da poco. Per le questioni importanti si muovono sempre insieme i fratelli di Brancaccio. Messina Denaro è arrivato invece con Mariano Agate, storico padrino di Mazara del Vallo. Riina ha accolto tutti con un grande abbraccio. E ha detto: «È arrivato il momento». Vuole uccidere il giudice Giovanni Falcone, che adesso lavora al ministero della Giustizia, a Roma. E anche il giornalista Maurizio Costanzo: si è permesso di dichiarare che i padrini ricoverati in ospedale stanno in perfetta salute e che dunque sono degli impostori. Il capo dei capi è andato su tutte le furie. E pretende pure altre punizioni esemplari.
Ha incaricato Graviano e i suoi fidati di pedinare il ministro della Giustizia Claudio Martelli, poi giornalisti e uomini di spettacolo che parlano male di Cosa nostra: Michele Santoro, Enzo Biagi, Andrea Barbato, Pippo Baudo. Cosa c’è dietro? Delirio di onnipotenza di un capomafia arrivato all’apice del terrore o l’inizio di una nuova strategia della tensione pianificata chissà con chi?
Nel Natale del 1991, Giuseppe Graviano è alla riunione della commissione provinciale, la “Cupola”, che Riina ha convocato per gli auguri a casa di Girolamo Guddo, dietro a Villa Serena, una clinica privata molto nota a Palermo, si trova sulla circonvallazione: questa volta, una riunione al gran completo, con tutti i capi delle famiglie. Si discute della Cassazione sul maxiprocesso prevista per fine gennaio, in molti pensano che non porterà niente di buono per Cosa nostra. È a quel punto che Riina dice: «Li ammazzo tutti, gli faccio vedere io». Ma è quello che aveva già deciso con i più stretti. Che riconvoca, solo loro, poco prima della partenza per Roma. A casa di Salvatore Biondino, mafioso autorevole di San Lorenzo. Lo sappiamo perché anni dopo l’hanno raccontato Geraci e Sinacori: finiti in manette, hanno scelto di collaborare con la giustizia. E tanti segreti hanno svelato.
A casa Biondino, Riina ha spiegato la sua strategia: «Vogliono fare la super procura? E noi facciamo la super cosa». Lo ha detto mentre guardava Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro. «Voi dipendete direttamente da me». E loro hanno annuito soddisfatti. A Roma, hanno fatto arrivare un camion carico di armi ed esplosivo, l’hanno nascosto nello scantinato di un condominio di via delle Alzavole 20, zona Casilino. E si sono messi a cercare i loro obiettivi.
Un gruppo va al ristorante Il Matriciano, in via dei Gracchi, Riina ha detto che Falcone va sempre lì. Ma non è un’informazione corretta, il giudice frequenta La Carbonara di Campo de’ Fiori. Un gruppo si dirige verso la trattoria Sora Lella, un altro va al bar Doney, in via Veneto. Fingeranno ancora di essere turisti. Una sera, Graviano e Messina Denaro si concedono pure un momento di relax, vanno al teatro Parioli, al Costanzo Show. Ormai, sono la “super cosa”, la Cupola dei segreti. Riina, Graviano e Messina Denaro. Il primo è morto il 17 novembre 2017, il secondo è al 41 bis dal 27 gennaio 1994, il terzo è diventato un fantasma.
Don Pino
Tornò a parlarmi dei due fratelli un anno dopo, il giorno che andò a fuoco il cantiere per la ristrutturazione della parrocchia, era la fine di maggio del 1993. «Hanno mandato un segnale per me», disse. In quelle settimane progettava di organizzare una grande manifestazione per le strade del quartiere, come mai si era fatta: un fiume colorato di giovani nel primo anniversario delle stragi Falcone e Borsellino. «La chiameremo Brancaccio per la vita», annunciò con il suo solito sorriso. I fratelli Graviano avevano già dato mandato di ucciderlo.
Sette giorni prima dell’omicidio, una sera di inizio settembre, telefonai a don Pino per preparare il consueto incontro settimanale. Mi disse: «Quest’anno non sarò con voi». Pensai che si riferisse alle tante attività che faceva con i giovani, non solo in parrocchia. Gli risposi: «Sono sicuro che troveremo un modo per conciliare tutti gli impegni con le nostre riunioni». Disse ancora: «Quest’anno non sarò con voi». Sapeva di essere nel mirino della mafia, aveva ricevuto delle minacce, ma non le aveva denunciate, mi sono sempre chiesto perché, forse per proteggere chi stava attorno a lui. Quella sera, mi chiese com’erano andati gli esami per la scuola di giornalismo di Milano: «Vuoi davvero andare via dalla Sicilia? – sussurrò – Qui c’è così tanto da raccontare». Una settimana dopo, ero alla stazione di Milano. Da una cabina telefonai a un amico, Rino Cascio, oggi è il capo della redazione siciliana della Rai. Mi disse che avevano sparato a don Pino. In un attimo, che mi sembrò interminabile, mi resi conto di non aver capito proprio nulla delle sue parole. E mi tornarono subito in mente quei nomi.
Chi sono davvero Giuseppe e Filippo Graviano, continuavo a chiedermi su quel treno che correva veloce nella notte verso Palermo. Sapevo poco o nulla di loro. Arrivato in città cercai al palazzo di giustizia il sostituto procuratore che indagava sull’omicidio di don Pino, Luigi Patronaggio, per raccontargli le parole del parroco sui fratelli di Brancaccio. Tempo dopo, ho appreso che in quelle ore Cosa nostra stava invece avviando la macchina del depistaggio, mettendo in giro la falsa notizia che il sacerdote era stato ucciso nel corso di una rapina commessa da un tossico; perché la versione fosse credibile i killer avevano portato via il portafoglio della loro vittima. Una messinscena che venne spazzata via quattro anni dopo, quando il sicario del parroco, Salvatore Grigoli, fu arrestato dalla squadra mobile e subito confessò.
Ma in quei giorni del settembre 1993 il quadro era ancora confuso. Uscito dal palazzo di giustizia, corsi alla redazione del quotidiano La Sicilia, che avevo iniziato a frequentare da qualche mese, e mi misi a cercare fra gli atti del maxiprocesso e le collezioni dei giornali, volevo capire che cosa fosse davvero la famiglia mafiosa dei Graviano. Mi resi conto che c’era anche un terzo fratello, Benedetto. Insomma, una storia ancora da raccontare. Perché non avevo iniziato prima questa ricerca? Pagina dopo pagina, articolo dopo articolo, mi sembrava di essere finito dentro una corsa. Ma da che parte andare? Continuavo a chiedermelo. In quei giorni, avevo solo una certezza, che era un’amara sensazione addosso: avevo iniziato nel peggiore dei modi il mestiere di cronista, non capendo quello che accadeva attorno a me.
Un profondo senso di colpa finì per travolgere anche i ragazzi della Fuci, ci ripetevamo che nessuno di noi aveva capito quanto fosse importante la battaglia di don Pino. Non andammo più a Brancaccio e per molto tempo non ci siamo neanche rivisti. Attorno, invece, sentivamo roboanti dichiarazioni sul “martire, simbolo della Chiesa contro la mafia”. Era sì martire e già santo don Pino, ma era solo il simbolo di una grande solitudine all’interno della Chiesa e della città. Per mettere su il centro sociale “Padre nostro” pagava ogni mese le rate di un mutuo con il suo modesto stipendio di insegnante di religione, e intanto mandava lettere su lettere alle istituzioni per la scuola media e gli altri servizi che continuavano a mancare.
Segreti
Trent’anni dopo aver sentito i loro nomi per la prima volta, è arrivato il momento di tornare a farmi quella domanda che non rivolsi a don Pino: chi sono davvero Giuseppe e Filippo Graviano?...