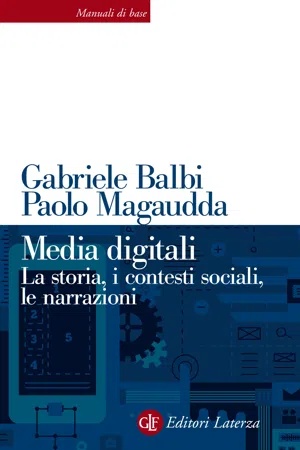
eBook - ePub
Media digitali
La storia, i contesti sociali, le narrazioni
- 264 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Un manuale imprescindibile per i corsi dedicati ai media digitali: per la chiarezza espositiva e la prospettiva storica entro la quale si osservano gli aspetti sociali e culturali che la digitalizzazione ha prodotto e continua a produrre.
La maggior parte degli strumenti didattici sui media digitali si concentra generalmente sui fenomeni del presente o sugli ultimi anni dell'evoluzione della digitalizzazione. Questo manuale vuole essere innovativo e guardare alla relazione tra società e media digitali in un arco temporale di lungo periodo, nella convinzione che sia necessario fornire un quadro ampio e coerente dei modi in cui i media digitali sono diventati così rilevanti per le società contemporanee.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Media digitali di Gabriele Balbi,Paolo Magaudda in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Computer Science e Information Technology. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1. Studiare i media e la società digitale
in prospettiva storica
1.1. Contestualizzare, definire e decostruire il «digitale»
A partire dagli anni Duemila i media digitali sono diventati un elemento centrale delle riflessioni e dell’immaginario delle società contemporanee, una possibile soluzione a buona parte dei problemi economici e sociali, una delle principali «ossessioni» del nostro tempo: connettersi (o essere sempre connessi) in rete, scambiarsi like o commenti sui social media, acquistare prodotti on line, scaricare un’app, aggiornare il proprio profilo virtuale, scambiare email, SMS o messaggi WhatsApp o WeChat, fare brevi video su Instagram o TikTok, cercare informazioni sul web sono solo alcune tra le infinite attività e i gesti abitudinari entrati a far parte della vita quotidiana di miliardi di persone, modificando le possibilità d’accesso alle informazioni, le opportunità economiche, la forma delle relazioni sociali e i processi di costruzione dell’identità. I media digitali e il loro uso sono diventati potenti metafore per descrivere e dare senso alle società contemporanee a cavallo del millennio: il filosofo francese Stéphane Vial (2013) ha parlato in proposito di «ontofania digitale», adattando un’espressione traslata dalla semantica religiosa (dal greco on che significa essere e faneia apparizione) per indicare quanto l’universo digitale appaia oggi come una delle «fedi» e delle «mitologie» più rilevanti del mondo contemporaneo, in grado di condizionare nel profondo la percezione e l’esperienza della realtà.
Gli «effetti» veri o presunti delle tecnologie digitali hanno assunto dimensioni positive o negative, in relazione ai differenti periodi storici e ai contesti culturali in cui sono state adottate. Per un verso, ad esempio, il digitale è stato acclamato per aver permesso la creazione di nuove «comunità», formate da persone che prima non avevano modo di interagire tra loro, ma dall’altro verso ha anche contribuito alla formazione di nuove barriere e disuguaglianze. Questa dimensione controversa dei media digitali in ambito sociale è diventata oggetto di discussione e di attenzione generale, a cominciare dall’immaginario popolare, grazie a serie TV come Black Mirror (prima stagione nel 2011), che ha offerto una lettura spesso distopica e inquietante sulle conseguenze della digitalizzazione nel presente o nel prossimo futuro.
Proprio per la forza che ha esercitato nel costruire il mondo contemporaneo, per il suo potere trasformativo e la sua forza metaforica, per il fatto di essere impiegata frequentemente nel discorso pubblico ora con toni trionfalistici ora con timore e paura, la digitalizzazione richiede in primo luogo di essere definita e decostruita. Da dove proviene, dunque, la parola «digitale»?
L’aggettivo «digitale» deriva dal latino digitus (dito) e, come ha sostenuto Ben Peters (2016b), gli esseri umani sono «naturalmente» digitali, perché fin dalle origini hanno dovuto contare, indicare e manipolare con le proprie dita. Il termine digitale non nasce quindi con i computer o altri strumenti tecnologici, ma è connaturato alla stessa natura umana. Eppure, nella società contemporanea, il termine «digitale» è spesso usato in contrapposizione ad «analogico», quasi si trattasse di due estremi di un continuum. Un esempio concreto tratto dal mondo della musica ci aiuta a chiarire questa distinzione: la differenza tra il disco in vinile analogico e il compact disc digitale. Gli appassionati del vinile sanno che il suono del disco è prodotto dal contatto tra la puntina e i solchi incisi sul disco stesso. Questi solchi sono continui, nel senso che non ci sono interruzioni nella spirale su cui sono incise le frequenze che contengono musica e parole. Tra il suono e il solco c’è quindi un’analogia fisica, una similitudine: se il solco è più o meno profondo produce un suono diverso. Nel caso del CD, invece, la traccia audio è scomposta (o meglio campionata) in una miriade di punti, e quindi in unità discrete e non continue, i cui valori sono registrati sulla superficie del supporto in formato binario, sotto forma di 0 e di 1. Il suono è prodotto dalla lettura che il laser fa dei valori di questi singoli punti che, tradotti poi in frequenze sonore, possono essere ascoltati in sequenza, ricreando così la continuità dell’ascolto.
Questa distinzione presuppone che analogico sia tutto ciò che non è digitale e viceversa. Tuttavia, come ha mostrato lo storico dei media Jonathan Sterne (2016), la distinzione tra analogico e digitale è molto più intricata e meno scontata. In primo luogo, «l’idea dell’analogico come non-digitale è più nuova dell’idea stessa di digitale» (p. 32), poiché la contrapposizione analogico/digitale si è definita con forza solo negli ultimi decenni, ed è quindi successiva alla creazione dei primi computer che oggi definiamo «digitali». Ciò che intendiamo oggi con la parola «analogico» è più il risultato storico di una serie di distinzioni culturali e mutamenti dei confini simbolici del termine, piuttosto che una caratteristica tecnica oggettiva: negli anni Cinquanta del Novecento il termine «analogico» indicava tutto ciò che riguardava i computer, negli anni Settanta il termine iniziò a significare un contrasto con i nuovi dispositivi elettronici (ma non per forza digitali) e, infine, solo dagli anni Novanta ha iniziato a essere utilizzato con la connotazione di «vecchio stile» e anche «vintage». In altre parole, le definizioni di analogico e digitale si sono evolute insieme e sono cambiate nel tempo in un rapporto dialettico e reciproco.
Il significato che oggi attribuiamo comunemente al digitale è legato anche a due processi che spesso vengono confusi: la numerizzazione e la binarizzazione (Lister et al. 2009). La digitalizzazione è un fenomeno che coinvolge in primo luogo la numerizzazione (tanto che in italiano e in francese, ad esempio, si usano i termini numerizzazione e numérisation), ovvero la conversione in cifre di contenuti che prima erano espressi in linguaggi differenti. Con le tecnologie analogiche, ad esempio, video, audio e testo erano trasmessi come segnali continui e ciascuna di queste tre forme di contenuti era differente dalle altre; con la digitalizzazione video, audio e testo sono invece tutti codificati come dati numerici e risultano quindi indistinguibili tra loro. Scomposti in numeri, non riusciamo infatti a capire se la stringa di cifre sia riferita a un video o a un testo.
Vi è poi la binarizzazione: spesso si crede, erroneamente, che digitalizzare equivalga a convertire dati fisici in informazione binaria. In realtà, la digitalizzazione, come indica la sua seconda etimologia tratta questa volta dall’inglese digit (cifra), è la semplice assegnazione di valori numerici, così come l’abbiamo su descritta. D’altra parte, il fatto che si sia pensato di digitalizzare i contenuti attraverso stringhe di 0 e 1, chiamate bit, ha enormemente semplificato il processo di codifica e decodifica, perché riduce ogni componente a due stati: acceso o spento, passaggio o non-passaggio di corrente, 0 o 1. I programmi che vediamo sulle nostre TV digitali non sono altro che sequenze di 0 e 1, in cui sono scomposte le onde continue generate da suoni e immagini, trasformate in stringhe di valori che non hanno più alcuna relazione analogica o meglio nessuna analogia con gli originali. Sono dunque le TV o i decoder a tradurre e ricomporre la sequenza di 0 e 1 in suoni e immagini comprensibili e consumabili nelle nostre case.
I fenomeni di numerizzazione e di trasformazione in codice binario hanno diverse importanti conseguenze per la circolazione dei contenuti mediali. In primo luogo, trattare tutte le forme di comunicazione allo stesso modo permette apparentemente di «smaterializzare» i contenuti dei media; comprimerli e quindi trasferirli più in fretta; manipolarli o modificarli in maniera semplice; conservarli in supporti che occupano poco spazio perché l’informazione digitale è densa – si pensi alla differenza tra le ore di audio-video che possono essere contenute in una cassetta VHS e in un hard disk esterno da alcuni gigabyte, o ancora allo spazio potenzialmente infinito in cloud. Una delle differenze spesso evidenziate tra i media analogici e quelli digitali è che, con quelli analogici, tutti questi processi erano più complessi e costosi, come dimostra la necessità di dover tagliare e copiare supporti fisici (si pensi alle bobine cinematografiche) o trasferirli da un luogo all’altro attraverso sistemi di trasporto (si pensi al giornale cartaceo). Tuttavia, questa ipotesi può essere contestata con una prospettiva storica: le onde radio o i cavi telegrafici e telefonici permettevano già di trasferire informazioni in maniera istantanea oppure i primi computer necessitavano di supporti grandi e pesanti come le bobine di nastro magnetico per immagazzinare la memoria (cfr. Capitolo 2).
Ciò detto, è forse più interessante decostruire un’altra argomentazione di frequente collegata alla digitalizzazione: quella che essa causi immancabilmente la smaterializzazione dei contenuti e della cultura. Al contrario, possiamo constatare che la digitalizzazione è stata accompagnata da un’esplosione della presenza di nuovi oggetti materiali e di nuovi hardware nella nostra società: dai personal computer agli smartphone, dai DVD alle penne USB, dai lettori MP3 alle fotocamere, dai cavi in fibra ottica ai grandi server che necessitano di essere raffreddati, fino a un’infinità di accessori all’apparenza superflui ma che fanno parte del mondo digitale come le custodie degli smartphone. Possiamo così decostruire un’idea assai diffusa attorno ai presunti effetti del digitale: anziché tradursi in una smaterializzazione della cultura, le tecnologie digitali sembrano invece stimolare la diffusione di un nuovo universo materiale, costituito da supporti e oggetti fisici. Oggetti che, nelle diverse culture, sono spesso circondati da significati, simboli e mitologie.
1.2. Digitale e modelli di società: una breve storia
Il digitale non è costituito solo da aspetti tecnici e materiali: per ricostruire i significati profondi che ruotano attorno alla digitalizzazione occorre anche considerare come si siano evolute le rappresentazioni e gli immaginari del digitale nella cultura contemporanea. Nonostante l’importanza culturale, sociale ed economica dei media digitali, infatti, fino a oggi le scienze storico-sociali si sono interrogate solo in modo parziale sulle radici, le correnti di pensiero, le metafore e le visioni che hanno favorito l’emergere di una società sempre più digitalizzata. In altre parole: quando e in che modo la nostra società ha iniziato a pensare a sé stessa come a una società digitale?
I primi tentativi di individuare il fulcro delle trasformazioni in atto nella società moderna nell’evoluzione del calcolo, della comunicazione e dei computer risalgono al periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale e, in particolare, al successo di due cornici teoriche emerse in quegli anni: la cibernetica e la teoria dell’informazione (Heims 1994). La cibernetica fu un innovativo ambito interdisciplinare che prese forma dagli anni Quaranta del Novecento. Etimologicamente, «cibernetica» proviene dal greco e rimanda al campo semantico navale e si può tradurre letteralmente come «l’arte di pilotare». Padre della cibernetica è considerato il matematico statunitense Norbert Wiener, che si occupò di studiare i fenomeni di autoregolazione dei sistemi di comunicazione nelle loro interazioni con l’ambiente sociale. Wiener riconobbe tra i fenomeni cruciali per le trasformazioni sociali sia l’evoluzione delle forme di comunicazione, sia il ruolo delle macchine e della loro interazione con l’ambiente sociale. Sempre nei medesimi anni, più precisamente nel 1948, l’ingegnere e matematico Claude Shannon tracciò le basi logico-matematiche di un modello di trasferimento della comunicazione, chiamato «teoria dell’informazione» e poi evolutosi nella «teoria matematica dell’informazione» con l’aiuto di un altro scienziato, Warren Weaver. Tali modelli, basati perlopiù sulle comunicazioni telefoniche, dal momento che i due matematici li svilupparono nei laboratori di ricerca della principale società telefonica americana, AT&T, rappresentarono un riferimento centrale dei nascenti studi sulla comunicazione e, più in generale, permisero di identificare «la comunicazione» come dimensione cruciale della società postbellica. È questo l’assunto di base di una tesi elaborata da Philippe Breton (1996).
Secondo lo storico francese, infatti, il successo delle tesi di Wiener, Shannon e Weaver fu possibile solo grazie all’eredità culturale della Prima e della Seconda guerra mondiale. All’indomani delle guerre mondiali, apparve chiaro come gli esseri umani nella prima metà del Novecento avessero assunto delle scelte irrazionali e fortemente autodistruttive. Meglio sarebbe stato, era anche la convinzione dei cibernetici, che queste scelte fossero compiute da macchine in grado di comunicare tra loro in maniera logica e razionale. La comunicazione tra macchine, in altri termini, assunse un valore post-traumatico – ovvero la capacità di rassicurare dopo il trauma delle guerre – e l’idea di comunicazione in sé cominciò a essere percepita come uno strumento salvifico e liberatorio, un valore centrale nella rifondazione dell’organizzazione delle società uscite dal secondo conflitto mondiale. Nel 1948 Wiener stesso, nell’introduzione a La cibernetica (1953, p. 23), scrisse che «la società può essere compresa soltanto attraverso lo studio dei messaggi e dei mezzi di comunicazione relativi ad essi». Fu insomma grazie alla cibernetica e alla teoria dell’informazione che le scienze della comunicazione cominciarono a essere considerate come discipline fondamentali nell’alveo delle scienze umane e sociali.
Nei decenni successivi, varie teorie e cornici interpretative misero a fuoco una serie di trasformazioni sociali e culturali che solo in seguito divennero caratterizzanti dell’odierna società digitale. Possiamo identificare almeno cinque differenti cornici teoriche o modelli di riferimento di nuove società emersi nella seconda metà del Novecento e che hanno in qualche modo aperto la strada all’idea di società digitale.
La prima è quella di società dell’informazione, una definizione che mette in luce la centralità dell’informazione quale risorsa e motore più importante dello sviluppo politico, economico e culturale della società contemporanea. Questa prospettiva vedeva l’informazione come una forza irresistibile in grado di rivoluzionare interamente la società e in particolare il mercato del lavoro e l’economia (Dordick, Wang 1993; Richeri 2012). Tale ...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. Studiare i media e la società digitale in prospettiva storica
- 2. Il computer
- 3. Internet
- 4. Il telefono mobile
- 5. La digitalizzazione dei media analogici
- 6. La digitalizzazione come mitologia contemporanea
- Bibliografia
- Appendice di dati