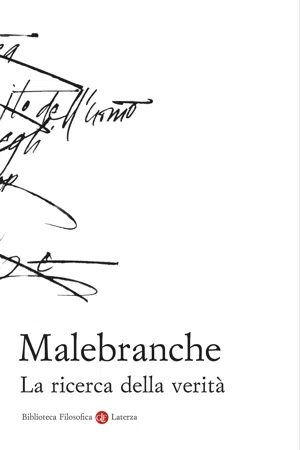
- 774 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La ricerca della verità
Informazioni su questo libro
La ricerca della verità rappresenta la summa del pensiero di Nicolas Malebranche, uno dei protagonisti del Seicento filosofico francese. Malebranche sottopose l'opera a continue revisioni nel corso della sua vita, fino a giungere a un'edizione finale del testo, nel 1712.
Di quest'ultima, Maria Garin ha realizzato nel 1983 per i tipi della Laterza una traduzione in italiano, basata sul testo critico fornito da Geneviève Rodis-Lewis nel quadro delle Oeuvres complètes di Malebranche. L'edizione era introdotta da un saggio di Eugenio Garin. Oggi viene riproposta con una nota di Emanuela Scribano che riattraversa la filosofia di Malebranche mettendone in luce originalità e ricchezza.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Libro sesto.
Del metodo
Parte prima
Capitolo primo
Disegno di questo libro. I due mezzi generali per mantenere l’evidenza nella ricerca della verità che saranno il soggetto del libro
Si è visto nei libri precedenti che lo spirito dell’uomo è estremamente soggetto all’errore; che le illusioni dei suoi sensi1, le visioni2 della sua immaginazione, le astrazioni della sua mente3, lo ingannano a ogni piè sospinto; che le inclinazioni4 della sua volontà e le passioni5 del suo cuore gli nascondono quasi sempre la verità e non gliela lasciano vedere se non quando è tinta di quei falsi colori che lusingano la concupiscenza. In una parola, si sono riconosciuti in parte gli errori dello spirito e le cause dei suoi errori. Ora è tempo di mostrare le vie che portano alla conoscenza della verità e di conferire allo spirito tutta la forza e l’abilità che si potrà perché proceda per queste strade senza stancarsi inutilmente e senza smarrirsi.
Ma perché non si faccia un’inutile fatica leggendo quest’ultimo libro, credo mio dovere avvertire che si rivolge solo a coloro che vogliono sul serio dedicarsi da sé alla ricerca della verità, servendosi a tal fine delle forze della propria mente. Chiedo che rifiutino temporaneamente tutte le opinioni verosimili; che non si fermino alle congetture più solide; che trascurino l’autorità di tutti i filosofi; che siano, per quanto sarà possibile, privi di preoccupazioni, di interesse, di passione; che diffidino all’estremo dei loro sensi e della loro immaginazione; in una parola, che tengano bene a mente la maggior parte delle cose che si son dette nei libri precedenti.
Il disegno di quest’ultimo libro è di tentar di rendere allo spirito tutta la perfezione di cui è naturalmente capace fornendogli i sussidi necessari perché divenga più attento e per ampliare i suoi orizzonti, e prescrivendogli le regole che vanno osservate nella ricerca delle verità per non ingannarsi mai e per imparare col tempo tutto ciò che si può sapere.
Se si attuasse questo disegno in tutta la sua perfezione – il che non si pretende, perché questo è solo un saggio – si potrebbe affermare di avere offerto una scienza universale e chi ne sapesse fare uso sarebbe veramente dotto poiché conoscerebbe il fondamento di tutte le scienze particolari e s’impadronirebbe di queste nella misura in cui utilizzerebbe la scienza universale. Col presente trattato si cerca infatti di conferire alla mente la capacità di formulare giudizi veri e certi su tutte le questioni che le sono accessibili.
Come, per essere un buon geometra, non basta sapere a memoria tutte le dimostrazioni di Euclide, di Pappo, d’Archimede, d’Apollonio, e di tutti coloro che hanno scritto di geometria, così, per essere un dotto filosofo, non basta aver letto Platone, Aristotele, Descartes e sapere a memoria tutte le loro teorie sulle questioni filosofiche. La conoscenza di tutte le opinioni e di tutti i giudizi degli altri uomini, filosofi e geometri, non è tanto una scienza quanto una storia; infatti la vera scienza, che sola può conferire alla mente dell’uomo la perfezione di cui è attualmente capace, consiste in una certa capacità di dare giudizi fondati su tutte le cose che sono alla sua portata. Ma per non sprecare tempo e per non indurre nessuno a posizioni preconcette con giudizi precipitati, cominciamo a trattare di una materia così importante.
Bisogna, prima di tutto, ricordare la regola stabilita e dimostrata all’inizio del primo libro, in quanto è il fondamento e il primo principio di tutto ciò che diremo in seguito. La ripeto: «Non si deve mai accordare pieno consenso se non alle proposizioni che si presentano come vere con tale un’evidenza da non permetterci di rifiutarle senza intima pena e senza il segreto rimprovero della ragione; ossia senza la chiara coscienza che si farebbe un cattivo uso della propria libertà rifiutando di consentire»6. Tutte le volte che si consente a cose verosimili ci si mette certamente in pericolo d’ingannarsi, e ci s’inganna, in effetti, quasi sempre, o, infine, se non ci s’inganna è solo per un caso fortunato. Quindi la conoscenza confusa di un gran numero di verosimiglianze su diverse cose non rende la nostra ragione più perfetta; qualche perfezione e qualche consistente appagamento può venirle solo dalla chiara nozione della verità.
Pertanto è facile concludere che se, come ci assicura la nostra prima regola, solo l’evidenza ci dà la certezza di non ingannarci, dobbiamo soprattutto badare a conservare quest’evidenza in tutte le nostre percezioni, perché possiamo dare fondati giudizi su tutte le cose che rientrano nell’ambito della nostra ragione e scoprire tutte le verità che sono alla nostra portata.
Le cose che possono generare e mantenere quest’evidenza sono di due tipi. Alcune sono in noi, o dipendono in qualche modo da noi; altre non ne dipendono. Infatti, come per vedere distintamente gli oggetti visibili è necessario aver buona vista e fissarla sugli oggetti, cose, entrambe, che sono in noi o che dipendono in qualche modo da noi; così, per penetrare a fondo le verità intelligibili, bisogna avere la mente acuta e applicarla intensamente; cose, entrambe, che sono pure in noi e che dipendono in qualche modo da noi.
Ma come gli occhi per vedere hanno bisogno di luce, e questa luce dipende da cause estranee a noi, anche la mente, per comprendere, ha bisogno di idee; e queste idee, come si è provato altrove, non dipendono da noi, ma da una causa che è altro da noi e che nondimeno ce le dà in conseguenza della nostra attenzione. Se pertanto accadesse che le idee delle cose non fossero presenti alla nostra mente tutte le volte che lo desideriamo, e se colui che illumina il mondo ce le volesse nascondere, ci sarebbe impossibile porvi rimedio e conoscere alcunché, come non ci è possibile vedere gli oggetti visibili quando ci manca la luce. Ma non abbiamo motivo di temere questo; infatti la presenza delle idee alla nostra mente, essendo naturale e dipendendo dalla volontà generale di Dio, che è sempre costante ed immutabile, non ci vien mai meno nella scoperta delle cose naturalmente soggette alla ragione. Perché il sole che rischiara gli spiriti non è come il sole che illumina i corpi; non si eclissa mai e penetra tutto senza che la sua luce ne risulti frazionata.
Pertanto, dato che le idee di tutte le cose ci sono continuamente presenti, anche quando non le consideriamo con attenzione, per mantenere l’evidenza in tutte le nostre percezioni non ci resta che cercare i mezzi per rendere la nostra mente più attenta e per estenderne la portata; come, per distinguere bene gli oggetti visibili che ci sono presenti, da parte nostra occorre solo avere vista acuta e guardarli fissamente.
Ma poiché gli oggetti che esaminiamo hanno spesso più rapporti di quanti non possiamo scoprirne con un solo atto della mente, abbiamo anche bisogno di alcune regole che ci addestrino a sciogliere così bene tutte le difficoltà da permetterci, con quei sussidi che accresceranno l’attenzione e la capacità della nostra mente, di scoprire con piena evidenza tutti i rapporti delle cose esaminate.
Divideremo pertanto questo sesto libro in due parti. Nella prima tratteremo dei sussidi di cui la mente si può valere per farsi più attenta e per ampliare i propri orizzonti; nella seconda forniremo le regole che deve seguire nella ricerca delle verità per formulare dei giudizi fondati che non comportino rischio di errori.
Capitolo secondo
L’attenzione è necessaria per mantenere l’evidenza nelle nostre conoscenze. Le modificazioni sensibili rendono l’anima attenta ma frazionano troppo la sua capacità di percepire
Abbiamo mostrato dall’inizio di quest’opera che l’intelletto non fa altro che percepire e che, per quanto concerne l’intelletto, fra le semplici percezioni, i giudizi e i ragionamenti c’è solo questa differenza: che i giudizi e i ragionamenti sono percezioni molto più complesse delle semplici percezioni, perché non rappresentano soltanto parecchie cose, ma anche le relazioni che parecchie cose hanno fra di loro. Infatti le semplici percezioni non rappresentano alla mente se non le cose, ma i giudizi rappresentano alla mente le relazioni tra le cose, e i ragionamenti, se sono ragionamenti semplici, rappresentano le relazioni fra le relazioni delle cose, ma, se sono ragionamenti complessi, rappresentano le relazioni delle relazioni, ossia le relazioni complesse fra le relazioni delle cose, e così all’infinito. Perché, via via che le relazioni si moltiplicano, i ragionamenti che le rappresentano allo spirito diventano più complessi. Nondimeno i giudizi, i ragionamenti semplici e i ragionamenti complessi, per parte dell’intelletto sono soltanto pure percezioni, perché l’intelletto non fa che percepire, come si è già detto fin dall’inizio del primo libro7.
Poiché giudizi e ragionamenti, da parte dell’intelletto, sono soltanto pure percezioni, è chiaro che l’intelletto non cade mai in errore; l’errore, infatti, non si verifica mai nella percezione che non è neppure intelligibile. Perché, infine, l’errore o la falsità si riduce a una relazione che non è, e ciò che non è non si può né vedere né intendere. Si può vedere che 2 per 2 fa 4, o che 2 per 2 non fa 5, perché sussiste realmente un rapporto d’uguaglianza fra 2 per 2 e 4, e un rapporto di disuguaglianza fra 2 per 2 e 5; quindi la verità è intelligibile. Ma non si vedrà mai che 2 per 2 faccia 5, perché lì non c’è rapporto d’uguaglianza, e ciò che non è non può essere percepito. L’errore, come già abbiamo detto più volte, non consiste dunque che in un consenso precipitato della volontà, che si lascia abbagliare da qualche falso splendore e che, invece di conservare la propria libertà finché è possibile, si riposa con negligenza nell’apparenza della verità.
Nondimeno, poiché spesso accade che l’intelletto abbia solo percezioni confuse e imperfette delle cose, esso diventa una vera causa dei nostri errori, causa che possiamo chiamare occasionale o indiretta. Infatti, come la vista in senso fisico spesso ci fa sbagliare rappresentandoci gli oggetti esterni in maniera confusa e imperfetta – confusamente quando sono troppo lontani da noi, o per scarsezza di luce; imperfettamente perché ci rappresenta soltanto i lati volti verso di noi – così l’intelletto, avendo spesso solo una percezione confusa e imperfetta delle cose, perché non gli sono abbastanza presenti e perché non ne scopre tutti gli aspetti, fa sì che la volontà, cedendo con troppa facilità a queste percezioni oscure e imperfette, vada a cadere in un gran numero di errori.
Bisogna dunque cercare il mezzo d’impedire che le nostre percezioni siano confuse ed imperfette. E poiché, com’è convinzione generale, niente più dell’attenzione le rende chiare e distinte, bisogna tentar di trovare dei mezzi di cui possiamo servirci per diventare più attenti di quanto non siamo. Così potremo mantenere l’evidenza nei nostri ragionamenti e anche cogliere con un sol colpo d’occhio un legame necessario fra tutte le parti delle nostre più lunghe catene di deduzioni.
Per trovare questi mezzi bisogna esser ben convinti di ciò che già abbiamo detto altrove: che la mente non dedica la stessa attenzione a tutte le cose che percepisce. Si applica infatti infinitamente di più a quelle che la toccano, la modificano, la penetrano, che a quelle che le sono presenti, ma non la toccano e non le appartengono; in una parola, si occupa molto di più delle sue proprie modificazioni che delle semplici idee degli oggetti, le quali idee sono qualcosa di diverso da lei.
Per questa ragione consideriamo solo con fastidio e senza molta applicazione le idee astratte dell’intelletto puro, e ci applichiamo molto di più alle cose che immaginiamo, soprattutto se siamo provvisti di una forte immaginazione e se nel nostro cervello si scavano grandi tracce. Infine, per questa ragione, ci lasciamo prendere completamente dalle qualità sensibili, senza neanche riuscire a prestare la minima attenzione alle idee pure della mente nei momenti in cui abbiamo qualche sensazione molto gradevole e molto do...
Indice dei contenuti
- Dio, nostro solo maestro di Emanuela Scribano
- Introduzione all’edizione 1983 di Eugenio Garin
- La ricerca della verità. Trattato sulla natura dello spirito dell’uomoe sull’uso che egli deve farneper evitare l’errore nelle scienze. di Nicolas Malebranche, Dell’Oratorio
- Prefazione
- Avvertenza relativa a quest’ultima edizione
- Libro primo. I sensi
- Libro secondo. L’immaginazione
- Libro terzo. L’intelletto o spirito puro
- Libro quarto. Inclinazioni o movimenti naturali dello spirito
- Libro quinto. Le passioni
- Libro sesto. Del metodo
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a La ricerca della verità di Maria Garin,Nicolas Malebranche in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Filosofia moderna. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.