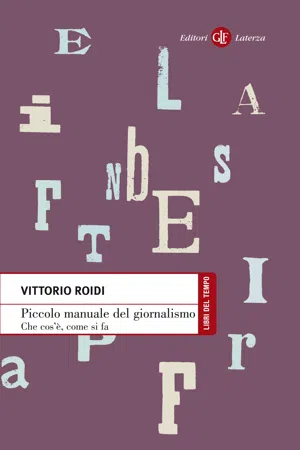
- 186 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
«Abbiamo bisogno di notizie, come dell'acqua e del cibo. Il commercio di queste informazioni deve rispondere ai bisogni della collettività, ma in quale misura la libertà e l'indipendenza dei media – requisito primo del giornalismo – possono essere accompagnate da precetti e regole di comportamento?» In questo volume, Vittorio Roidi si propone di 'insegnare' al lettore non solo 'che cos'è', ma anche 'come si fa' il giornalismo, stilando un piccolo manuale in cui racconta la storia, le pratiche e i segreti di una professione in continua evoluzione.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Piccolo manuale del giornalismo di Vittorio Roidi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Lingue e linguistica e Giornalismo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Lingue e linguisticaCategoria
GiornalismoL’etica, la deontologia, l’autonomia
1. Lontano dalla verità: pubblicità e bufale
La diffusione delle notizie giornalistiche è confusa, sommersa in un oceano dove si trova di tutto: informazioni interessate, segnalazioni, avvisi, forme di intrattenimento, pubblicità. E autentiche bufale, cioè invenzioni, imbrogli belli e buoni.
Il cittadino fa fatica a individuare il messaggio giornalistico. Spesso non ha neppure voglia di districarsi nel groviglio di segnali, suoni, chiacchiere, rumori che giungono alle sue orecchie o ai suoi occhi. E molti sono coloro che non hanno interesse a distinguere con nettezza i notiziari giornalistici. Alcuni rotocalchi hanno perso completamente le caratteristiche del veicolo informativo. Decine di pubblicazioni periodiche vivono esclusivamente di pubblicità, così come i canali televisivi e radiofonici privati, per i quali non si paga canone né abbonamento.
Come abbiamo visto, già nell’Ottocento editori e giornalisti hanno trovato nella pubblicità una forma di guadagno, da aggiungere a quella proveniente dall’edicola. Ma col tempo l’apporto della pubblicità alle casse dei giornali si è andato ingigantendo, tanto che la percentuale dei ricavi supera spesso il 50 per cento del totale. Non solo i giornali, ma anche le televisioni (e in minor misura le radio) vivono ormai di pubblicità. Un programma televisivo viene chiuso dopo la seconda puntata se gli ascolti sono inferiori alle attese, perché i clienti pubblicitari scappano se i dirigenti di quel canale non corrono subito ai ripari. Non succede per i notiziari giornalistici, ma anche i direttori sono sottoposti a spinte e pressioni. La pubblicità infarcisce le pagine e caccia fuori le notizie. Si vedono blocchi enormi di réclame che storpiano la grafica, con l’assenso dei direttori.
La pubblicità è il «braccio armato del mercato – ha scritto Giorgio Bocca – è la creatrice irresistibile di desideri e di consumi, la potentissima locomotiva che trascina il genere umano verso nuovi desideri e forse nuove guerre e forse verso l’autodistruzione». Per adattarsi alle esigenze del marketing «l’informazione deve essere sempre un pugno nello stomaco, deve stupire, impressionare, lasciare il segno sul lettore» (Bocca, 2008). Per questo assistiamo a un giornalismo che esalta, drammatizza, è catastrofista o ottimista. Un’informazione esagerata, perché così la vuole chi con i suoi soldi tiene su le finanze dell’editoria.
I giornalisti hanno tentato di difendersi dall’assedio della pubblicità, venendo a patti. Il loro sindacato ha concordato, fin dal 1988, regole che miravano a tenere distinto il messaggio pubblicitario dalle notizie e imponevano l’obbligo nella carta stampata di utilizzare caratteri diversi e di segnalare la natura pubblicitaria di alcuni messaggi. Regole ormai insufficienti e applicate in mala fede. Basti rilevare il «corpo» piccolissimo, quasi illeggibile usato per gli avvisi ai lettori.
In campo televisivo, le trasmissioni di intrattenimento hanno incamerato la pubblicità. Si vedono conduttori e presentatori famosi che si fermano per mandare in onda spot dei quali essi stessi sono protagonisti. Le preoccupazioni e le raccomandazioni espresse dall’Unione europea sono continuamente violate. Scarse sono le reazioni delle Autorità di controllo sulla concorrenza e sulle telecomunicazioni create dal Parlamento.
Perfino la Rai, che ha una concessione di pubblico servizio, mischia i generi, confonde il giornalismo con altre forme di spettacolo, utilizza giornalisti come programmisti e, viceversa, non giornalisti in trasmissioni di natura informativa. Il risultato è un guazzabuglio in cui il giornalismo è annacquato e inquinato. Un mondo in cui non si sa chi fa che cosa. Humphrey Bogart diceva «È la stampa, bellezza», a indicare che la rotativa era partita e che quel potere non poteva essere fermato. Oggi la frase è un’altra: «È la liberalizzazione, è la globalizzazione», come se tutto debba essere consentito.
Marshall McLuhan disse che l’informazione sul pianeta sarebbe divenuta globale ed è accaduto. La rete copre ogni angolo del mondo, ma non si vede perché al suo interno la natura dei messaggi debba essere affogata in un’enorme insalata. Mentre i pomodori si possono mangiare anche separati dalla verdura, dalle zucchine, dalle carote, le notizie devono essere confuse con altri generi di comunicazione. Ma è davvero inevitabile?
I giornalisti hanno capito che la pubblicità, oltre a rappresentare un combustibile per le proprie aziende, può rivelarsi un veleno mortale. Per questo l’Ordine ha proibito ai propri iscritti di fare spot, se non per fini umanitari e di beneficenza. Ma la questione è culturale e non di rado si sono visti celebri direttori di giornali partecipare a spot, che minano la credibilità del giornalista. Perché il cittadino si chiede: ma quello mi dice la verità o propaganda la sua merce?
Ci sono altri veleni che intossicano l’attività giornalistica. L’elenco è lungo. Nemici del buon giornalismo sono la partigianeria, la presunzione e naturalmente la vanità e lo «scoopismo», la voglia di emergere e di trovare notizie sensazionali. Anche i titoli possono essere fonte di ambiguità, sotterfugi per creare appeal verso un articolo, che invece una volta letto si rivelerà poco interessante. La grafica dei quotidiani ha ormai scelto titoli sparati, a tutta pagina, che ingigantiscono un’informazione (e minimizzano le altre) come facevano un tempo i giornali della sera, che puntavano tutto sull’avvenimento dell’ultima ora. Ma il lettore oggi riconosce una notizia gonfiata, si accorge quando un quotidiano – per realizzare la propria linea editoriale – esagera, imbocca la strada dello scandalismo. Metodi che tolgono credibilità al giornalismo.
Poi esistono le «bufale». I falsi giornalistici hanno riempito le biblioteche. Fra i più clamorosi, se ne possono segnalare almeno tre: il caso «Timisoara», quello di Janet Cooke e gli imbrogli di Jayson Blair.
Nel dicembre del 1989, in Romania, la popolazione si sollevò contro il dittatore Nicolae Ceauçescu. La repressione fu durissima. Le frontiere vennero chiuse ai giornalisti. Finché dalla città di Timisoara (vicina al confine con l’Ungheria) vennero le prime notizie di un «massacro»: centinaia di morti trovati nelle fosse comuni. Le informazioni vennero confermate dai profughi che riuscivano a fuggire all’estero. L’agenzia iugoslava Tanjug e le fonti ungheresi confermarono. Le televisioni di tutto il mondo mostrarono immagini di corpi sventrati – in particolare quelli di una donna e della sua figlioletta orribilmente martoriati – e fissarono il bilancio a 4362 morti. Solo un mese più tardi si cominciò a dubitare e fu la France Press a parlare di messinscena. Un falso giornalistico, costruito prendendo cadaveri da un cimitero. La donna era morta di cirrosi epatica, la bambina per una congestione e i loro corpi non portavano i segni della tortura, ma quelli dell’autopsia. Nessuno aveva controllato quelle informazioni false e, cosa ancora più grave, una volta scoperto l’imbroglio, pochissimi organi di stampa (fra i quali le più illustri testate europee) rivelarono l’errore ai propri lettori (Roidi, 2008).
Nel giornalismo degli Stati Uniti, lo scandalo più cocente fu quello che vide protagonista una giornalista del «Washington Post». Janet Cooke aveva vinto il premio Pulitzer per aver raccontato nel 1980 la storia di Jimmy, un bambino di 8 anni, che era stato drogato dall’amante della madre. Una vicenda orribile, al punto che le autorità avevano incalzato la giornalista affinché collaborasse alla punizione del colpevole rivelandone il nome. La Cooke, con le spalle al muro, alla fine aveva ceduto e ammesso di aver inventato tutto. Peraltro, il giornalismo americano, pur con i suoi clamorosi infortuni, ha mostrato di avere un’idea solida dei propri doveri e delle proprie finalità (Brancoli, 1994).
Molto simile il putiferio al «New York Times», sollevato dal caso di Jayson Blair, un altro reporter di cui la categoria si è dovuta vergognare. Jayson era un cronista di colore, potremmo definirlo un «reporter d’assalto», molto apprezzato dai capiredattori del «New York Times», ma poco amato dai colleghi. Si scoprì che aveva copiato da un giornale texano l’intervista a una soldatessa fatta prigioniera dagli iracheni e liberata dai marines. E fu provato che il vizio lo aveva spesso. Per almeno una trentina di volte aveva copiato articoli di altri giornali senza mai citare la fonte. Quando lavorava a un fatto, raramente andava sul posto. Preferiva scrivere da casa propria, con l’aiuto di una fidanzata topo d’archivio che gli procurava foto utili a ricostruire i luoghi degli avvenimenti.
Scoppiato lo scandalo, il direttore del «New York Times», Howell Raines, si dimise. Non solo aveva fatto di Blair il suo pupillo, ma aveva guidato la redazione come un gruppo di avventurieri: «Ogni giorno l’America deve parlare della nostra prima pagina», diceva. Non si rendeva conto che il giornale stava perdendo pezzi della propria credibilità. Il giornalismo deraglia perché vuole stravincere. Inventa i fatti perché non ne trova di sufficientemente attraenti. Ma le osservazioni che si possono fare sono anche altre.
Nel caso di Timisoara, la cosa più preoccupante fu la rapidità con cui la notizia falsa si diffuse. Grazie alla credulità dei colleghi e al tam tam delle agenzie di stampa, quella notizia fece il giro del mondo. Le conseguenze politiche potevano rivelarsi disastrose, visto che in Romania era in atto la ribellione di un popolo contro la dittatura.
Il caso del giovane Blair mostra invece quanto possano essere pericolosi l’arrivismo e l’ambizione, a quali risultati possa portare il giornalismo d’assalto (se non accompagnato da una buona dose di onestà e di umiltà). Occorrono antidoti energici. Introdurli non spetta ai lettori, anche se costoro possono informarsi attraverso cento altri canali e «controllare» in qualche modo l’informazione errata. Ma la responsabilità primaria sta nei vertici di ciascuna struttura editoriale, che deve prevedere meccanismi capaci di indicare ed espellere i reprobi. Per questo l’uragano causato dal comportamento di Blair provocò al «New York Times» l’uscita del direttore e del suo vice Gerald Boyd.
Diverso è il discorso sugli errori che un giornalista commette, talvolta, spinto dalla voglia di strafare. Fu volontario o no l’errore commesso da Andrew Gilligan? Dopo cinque anni, gli ascoltatori della radio inglese ancora ne discutono, perché l’episodio fece tremare il governo di Tony Blair.
All’inizio del 2004, quando le truppe americane e inglesi erano impegnate a mettere ordine in Iraq, i sudditi della regina Elisabetta si domandarono se esistessero davvero le armi chimiche che George Bush aveva preso a pretesto per l’invasione. Grande era stata l’impressione provocata dalla morte (ufficialmente «suicidio») dello scienziato David Kelly, il cui corpo era stato trovato in un prato dell’Oxfordshire, con le vene dei polsi tagliate. Lo scandalo politico scoppiò quando Andrew Gilligan, giornalista radiofonico, una mattina disse ai microfoni della Bbc (la «zietta», come la chiamano affettuosamente gli inglesi) che il governo Blair aveva alterato la relazione della commissione internazionale che aveva indagato sull’esistenza delle armi di distruzione di massa, l’aveva in qualche modo gonfiata («sexed up») per giustificare l’intervento armato.
In quei giorni erano morti i primi soldati britannici al fronte. Il governo Blair reagì con durezza. Lo staff del primo ministro (in cui si distinse il capo delle comunicazioni Alistair Campbell) chiese la testa di Gilligan, che non volle rivelare la fonte delle proprie informazioni. Kelly, che sulla presenza delle armi aveva indagato, si era sentito probabilmente tradito e per questo si era ucciso. Il primo ministro tentò di sedare la tempesta chiedendo l’intervento di un giudice neutrale. Fu nominato Lord Hutton che dopo qualche giorno dette torto a Gilligan e ragione al governo. Di qui le dimissioni del vertice della Bbc (che aveva difeso il cronista ed era accusato di non averlo controllato) e l’uscita dall’azienda di Gilligan.
Una vicenda che qualcuno ha usato per mettere in dubbio la leggendaria serietà dell’azienda radiotelevisiva inglese. In realtà, il successivo Rapporto Butler, più approfondito e neutrale di quello elaborato da Lord Hutton, dimostrò che Gilligan sostanzialmente aveva detto il vero, perché gli scienziati erano ormai sicuri che le armi chimiche in Iraq non esistessero. E Kelly lo aveva confermato.
In conclusione, si può osservare che:
– poche parole, usate in un notiziario radiofonico, possono scatenare il putiferio;
– il governo britannico, messa in campo tutta la propria forza, aveva ottenuto un parere «amico» e schiacciato il giornalista;
– l’informazione, se vuole restare libera, deve dire anche cose scomode, purché siano esatte; anche un piccolo errore, un’imperfezione provocata da una dose eccessiva di disinvoltura, può causare disastri. In quel caso portò Kelly, peraltro sempre coperto da Gilligan, fino al suicidio, perché non aveva ben calcolato il ginepraio in cui si cacciava rispondendo alle domande di un giornalista privo di scrupoli.
Anche noi italiani abbiamo una galleria di nefandezze, ben nascosta negli armadi. Con il sorriso sulle labbra e una punta di onestà è sufficiente ricordare l’episodio accaduto quando sull’«Unione sarda» venne pubblicata, in prima pagina, la vicenda di un pensionato che aveva rubato in un supermercato un pacco di pasta e del formaggio. L’articolo diceva che era stato colto sul fatto dai proprietari dello spaccio e che però gli abitanti del quartiere avevano ottenuto che fosse perdonato. Il colpevole era dunque tornato libero e la sua storia aveva fatto capolino su tutti i giornali italiani e sulle principali tv. Fino a quando gli stessi giornalisti dell’«Unione sarda» avevano scoperto che la storia, inviata da un collaboratore, era interamente parto della sua fantasia. Peraltro i redattori l’avevano impaginata con tanto di foto del market dove il furto era avvenuto, evidentemente falsa anche quella.
Drammatizzare un episodio come questo non serve. È utile invece osservare che la bufala è dietro l’angolo e che grandi e piccole redazioni possono essere infettate. Non solo il mestiere espone a rischi, ma l’impudenza, la faciloneria, la voglia di mettersi in mostra, da parte di giornalisti veri o presunti, rende questa attività non facilmente difendibile.
2. Diritti e doveri del giornalista
Filosofi e sociologi dell’informazione hanno cercato di individuare i valori base dell’attività giornalistica, i principi sui quali, in alcuni paesi, sono state innestate vere e proprie regole di comportamento, che costituiscono la deontologia di questa professione. Diversi sono, come abbiamo visto, gli interessi che premono sui giornalisti e non unanime la concezione sui fondamenti del mestiere. Stabilito chi sono e cosa fanno i giornalisti, c’è poi da individuare quale sia la retta via.
Senza risalire ad Aristotele e a un’astratta regola dell’agire umano, si tratta di indicare i principi ai quali deve essere ispirata l’informazione giornalistica e, di conseguenza, quali regole devono rispettare coloro che la praticano. Detto che l’agire giornalistico ha come fondamento il sacro valore della libertà di stampa, quali sono i limiti e i paletti?
In ogni epoca sono state diverse le risposte. Il giornalista, visto dapprima come un letterato, uno scriba, un cronista da strapazzo, solo in tempi più recenti è diventato il cane da guardia dei potenti. Una figura considerata al servizio della collettività, colui che assume l’impegno di informare il cittadino, per aiutarlo a conoscere, a farsi delle opinioni, a votare con consapevolezza.
Ciò è avvenuto, come abbiamo visto, con più facilità nelle nazioni che prima di altre hanno visto diffondersi le idee liberali, i diritti umani e la coscienza civile. Nella nostra penisola la fine del ventennio mussoliniano, la nascita della Repubblica e l’approvazione della Costituzione, nel 1948, aprirono un’epoca nuova. Ma aboliti gli orrori del fascismo, quale era l’idea, il valore etico che la collettività affidò a chi svolgeva questa attività?
Per secoli, la credibilità della categoria si è retta sulla visibilità e l’autorevolezza di alcuni giornalisti, personaggi noti, direttori di giornali, che combattevano furiose battaglie politiche. Ma è mancata una teoria del giornalismo, che tutti i filosofi e i sociologi hanno poi imperniato sul rapporto fra il giornalista e il potere. Per questo, alcuni hanno parlato di stampa come «quarto potere»; e poi della televisione come «quinto» potere. Quasi che i titolari di questa attività fossero in possesso di autonome facoltà e prerogative, e si ponessero in posizione di concorrenza con le istituzioni dello Stato liberale, retto, a partire da Montesquieu, sull’equilibrio fra i detentori dei tre poteri fondamentali: legislativo, esecutivo e giudiziario.
Che gli operatori del giornalismo possano essere considerati soggetti appartenenti a un corpo del tutto indipendente, capace di influenzare o indirizzare le sorti del paese, è sicuramente teoria inaccettabile. Anche se discende direttamente dalla libertà di espressione, come baluardo della vita civile, di cui devono god...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Parte prima. La teoria
- Natura ed evoluzione del giornalismo
- Il sistema giuridico
- Professionalità e organizzazione
- L’etica, la deontologia, l’autonomia
- Parte seconda. La pratica
- Il giornale di carta
- L’informazione radiofonica
- Potere e pericoli della televisione
- L’affermazione del web
- Bibliografia
- Piccolo glossario del giornalismo