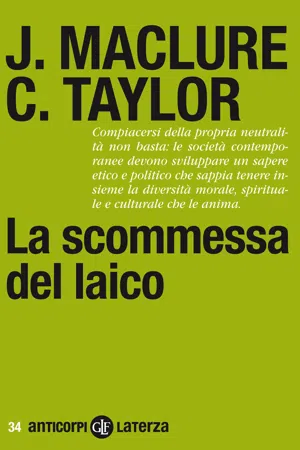X. L’obbligazione giuridica all’accomodamento favorisce la religione? Le convinzioni di coscienza religiose e secolari
Una critica che viene spesso rivolta all’obbligazione all’accomodamento fondata sulla libertà di religione è che essa favorisce le concezioni religiose più che le concezioni secolari di vita buona. Perché, per esempio, si dovrebbe gestire l’orario di lavoro di una impiegata avventista in modo che non debba mai lavorare il sabato (il giorno di shabbat), mentre il suo collega, che vorrebbe seguire una formazione professionale o un corso di pianoforte il sabato o, ancora, tenere compagnia alla madre anziana, deve lavorare lo stesso quel giorno, pena il licenziamento? Ciò non equivarrebbe forse a favorire le concezioni religiose di vita buona a discapito delle concezioni secolari (basate in particolare sulla soddisfazione personale, l’espressione artistica o la solidarietà familiare)? Gli accomodamenti religiosi sono compatibili con la neutralità verso le concezioni del bene di cui deve dar prova uno Stato liberale?
Si sa che i regimi di laicità e di tolleranza religiosa nella storia occidentale hanno cercato di garantire pace e stabilità all’interno di società caratterizzate dalla frammentazione della Chiesa cristiana. Il fine era che i membri di diverse confessioni religiose godessero di una libertà di coscienza approssimativamente uguale, cosa che richiedeva una separazione tra lo Stato e le Chiese. Questa posizione tuttavia è compatibile con la concessione di uno statuto privilegiato alla religione rispetto alle visioni non religiose del mondo. Locke sosteneva che la tolleranza religiosa poteva essere estesa agli ebrei e ai «maomettani», ma che non potessero essere tollerati gli atei, indegni di fiducia dato che essi non devono rispondere dei propri atti davanti a nessuna forza superiore. Nello stesso spirito, il giudice Joseph Story della Corte suprema americana poteva affermare, negli anni Trenta dell’Ottocento, che, anche se il primo emendamento della Costituzione vietava qualsiasi identificazione dello Stato con una Chiesa particolare, il fatto che le Chiese presenti fossero cristiane (e, nei fatti, protestanti) rendeva normale e legittimo invocare i principi del cristianesimo nell’interpretazione delle leggi. Per Story, la finalità del Primo emendamento era di «escludere ogni rivalità tra le sette cristiane», ma ciò non impediva che «il cristianesimo dovesse essere incoraggiato dallo Stato». Il cristianesimo è essenziale al governo politico perché la credenza in «uno Stato futuro di pene e ricompense» è vista come «indispensabile all’amministrazione della giustizia». Inoltre, secondo Story, «è impossibile, per chi crede nella verità del cristianesimo quale rivelazione divina, dubitare che tocchi al governo alimentarla e incoraggiarla presso i cittadini».
Tale primato accordato alla religione è stato sostenuto per tutto il XIX secolo. Ancora nel 1890, 37 dei 42 Stati esistenti riconoscevano l’autorità di Dio nel preambolo o nel testo stesso delle loro costituzioni. Una sentenza unanime della Corte suprema degli Stati Uniti affermava nel 1892 che, una volta dipinto il ritratto «della vita americana come si manifesta attraverso le sue leggi, il suo commercio, i costumi e la società, troveremo ovunque il netto riconoscimento di una stessa verità [...] che si tratta di una nazione cristiana». Il primato della religione sulle altre credenze è ancora oggi affermato nella teoria costituzionale del «non-preferenzialismo», secondo la quale il principio di «non-istituzionalizzazione» della religione implica solamente che nessuna religione particolare possa essere favorita dal Congresso americano, e non che sia vietata una generica approvazione della religione. Nella sentenza Wisconsin c. Yoder, sul diritto di genitori amish di abbassare per i figli l’età della scolarizzazione obbligatoria da 16 a 14 anni, la Corte suprema americana ha stabilito che le credenze religiose costituiscono una categoria distinta di credenze che meritano un trattamento giuridico preferenziale: «un modo di vita, sia esso virtuoso o ammirevole, qualora si basi su considerazioni puramente secolari, non può ostacolare un ragionevole controllo etico dell’educazione; per ricevere la tutela di clausole religiose, le rivendicazioni devono essere radicate nella fede religiosa».
In un contesto ben diverso, il presidente francese Nicolas Sarkozy ha adottato una posizione che attribuisce uno statuto privilegiato alla religione, o almeno a una certa forma di spiritualità, quando ha sostenuto che la ricerca di trascendenza è iscritta nella costituzione ontologica dell’essere umano e che, dunque, è una condizione necessaria al suo pieno sviluppo. Il discorso che ha tenuto nel 2007 a Roma, a San Giovanni in Laterano, lascia intendere che una forma di spiritualità trascendentale sia necessaria alla realizzazione autentica dell’essere umano:
Certo, fondare una famiglia, contribuire alla ricerca scientifica o alle scienze umane e sociali, insegnare, lottare per le proprie idee, in particolare quelle sulla dignità umana, guidare un Paese, possono dare senso a una vita. Sono queste piccole e grandi speranze «che, giorno per giorno, ci mantengono in cammino» per riprendere le parole dell’enciclica del Santo Padre. Non rispondono però alle domande fondamentali dell’essere umano sul senso della vita, sul mistero della morte. Non sanno spiegare cosa accada prima della vita e dopo la morte. [...]
La mia profonda convinzione, che ho espresso in particolare nel libro di interviste La Repubblica, le religioni, la speranza, è che la frontiera tra fede e non-fede non passi tra quanti credono e quanti non credono, ma attraversi ciascuno di noi. Anche chi sostiene di non credere non può dire di non interrogarsi sull’essenziale. Il fatto spirituale è la tendenza naturale di tutti gli uomini a ricercare una trascendenza. Il fatto religioso è la risposta delle religioni a tale aspirazione fondamentale.
Anche se Sarkozy, nel suo discorso, si guarda bene dal sostenere che lo Stato debba favorire le religioni a discapito delle concezioni secolari, la posizione metafisica che adotta non potrebbe far parte dei principi fondamentali di uno Stato laico. È possibile approvare o rifiutare la posizione del presidente pur restando un buon cittadino. E, tuttavia, il presidente sembra sostenere che gli individui che non abbracciano una cosmologia o una filosofia morale trascendentale non possano giungere a uno sviluppo autentico, cosa che si concilia con difficoltà con l’uguale rispetto che il potere politico deve accordare ai credenti e ai non credenti. Se il cittadino Sarkozy è ovviamente libero di avere tali idee, il fatto che queste parole siano state pronunciate dal presidente della Repubblica nell’esercizio delle proprie funzioni le rende più problematiche.
Eppure, come abbiamo sostenuto nella prima parte del libro, nelle società contemporanee segnate dalla diversità morale e religiosa, non sono le convinzioni religiose in sé a dover godere di uno statuto particolare, ma tutto l’insieme dei quadri di riferimento che permettono agli individui di strutturare la propria identità morale. Tanto più che l’uguale rispetto che si deve alle convinzioni di coscienza religiose e secolari è già riconosciuto, almeno in parte, dal diritto. Pensiamo, in particolare, all’esenzione dal servizio militare per obiezione di coscienza. Un pacifista, per il quale il rifiuto di ricorrere alla violenza è intimamente legato alla propria autocomprensione come agente morale, potrà avvalersi, nel periodo di leva, dello statuto di obiettore di coscienza ed essere così dispensato dal portare armi. La libertà di religione deve dunque essere considerata una sottocategoria della libertà di coscienza. Come ha scritto l’ex giudice capo Lamer della Corte suprema del Canada nella sentenza Edward Books:
Il paragrafo a) mira ad assicurare che la società non interferisca nelle credenze intime profonde che orientano la percezione che ognuno ha di se stesso, dell’umanità, della natura e, in alcuni casi, di un essere superiore o diverso. Queste credenze, a loro volta, orientano i nostri comportamenti e le nostre pratiche.
Come ha implicitamente riconosciuto la Corte suprema canadese, le credenze religiose non sono gli unici punti di riferimento e criteri di giudizio nella vita di un individuo. Le convinzioni di coscienza secolari, come nel caso del pacifista, permettono altrettanto all’agente di dare una direzione alla propria vita e di esercitare la propria facoltà di giudizio nel caso di conflitti di valore. Ciò che accomuna queste credenze è che impegnano la coscienza della persona e che questa non potrebbe astrarsi da esse o trasgredirle senza ledere il proprio senso d’integrità morale.
Così una persona vegetariana ha il diritto di pretendere, in uno spazio chiuso come la prigione o l’aereo, che le si offra un menù senza carne. Non vi è infatti alcuna buona ragione per stabilire una gerarchia, sul piano dei diritti, tra una persona il cui vegetarianismo abbia origine religiosa (l’induismo) e un’altra il cui vegetarianismo derivi da una filosofia morale secolare (anche gli animali hanno, in quanto creature sensibili, dei diritti). In entrambi i casi chiedere a qualcuno di abbandonare le proprie credenze equivale a infliggergli un torto eccessivo. Ciò lo indurrebbe a interpretare la propria richiesta come una semplice preferenza che può essere facilmente dimenticata o sostituita. La distinzione pertinente non è, dunque, tra quadri di riferimento di natura religiosa e secolare, bensì tra gli impegni fondamentali, da una parte, e, dall’altra, le preferenze personali che non sono intimamente legate alla comprensione che ho di me quale agente morale.
La tesi qui sostenuta non è tuttavia esente da alcune difficoltà, che nei fatti sono variazioni sul vaso di Pandora. Questa posizione non è esageratamente inclusiva? L’effetto combinato della concezione soggettiva della libertà di religione e del pari statuto accordato alle convinzioni di coscienza secolari e religiose non rischia di favorire, da una parte, la proliferazione delle istanze di accomodamento, e, dall’altra, la strumentalizzazione dell’obbligazione giuridica di accomodamento?
Il problema della proliferazione Il nocciolo del problema della potenziale proliferazione delle istanze di accomodamento risiede nella difficoltà di circoscrivere in modo preciso la nozione di convinzione o di impegno fondamentale. Come abbiamo visto, ciò che definisce un quadro di riferimento è il ruolo che svolge nella vita morale di una persona. Questo tipo di convinzione e di impegno aiuta l’individuo a risolvere conflitti di valori, a darsi un progetto di vita, ad attribuire senso alle proprie azioni, in breve, a condurre una vita «buona».
Bisognerebbe dunque poter tracciare una linea di demarcazione tra gli impegni fondamentali e le preferenze personali, ossia tutte quelle cose che si desiderano ma che non sono intimamente legate alla nostra integrità morale. Il pluralismo ragionevole dei valori e delle concezioni del bene, così come i limiti della ragione pratica, fanno sì che non ci si possa semplicemente rapportare ad una lista oggettiva di credenze e di valori che rientrano o nell’ordine dei quadri di riferimento o nell’ambito delle preferenze secondarie per l’integrità morale dell’agente. Una convinzione di coscienza comporta una dimensione soggettiva irriducibile; chi agisce deve attribuire un’importanza speciale ad una certa credenza per cui questa conta come un quadro di riferimento; sta all’agente stabilire ciò che è centrale e ciò che non lo è per la propria identità morale. Come ha scritto Locke: «nessuno potrebbe, anche volendo, conformare la sua fede ai comandi di un altro».
Dove tracciare dunque una linea di demarcazione? Si sa che costringere un vegetariano a mangiare carne rappresenta un torto morale importante, mentre obbligare un professore universitario a fare lezione alle 8,30 invece che alle 15,30, come ha chiesto, può essere fastidioso, ma non lo costringe a deviare dal cammino che gli indica la coscienza. Tuttavia, molte credenze e valori si situano tra questi due poli ed è difficile stabilire in astratto dove passa il confine tra preferenze e impegni fondamentali. Sebbene non sia oggetto di controversia porre dal lato delle convinzioni di coscienza le credenze che derivano da dottrine filosofiche, spirituali o religioni istituite, che ne è del campo più fluido e frammentato dei valori? La persona che vuol...