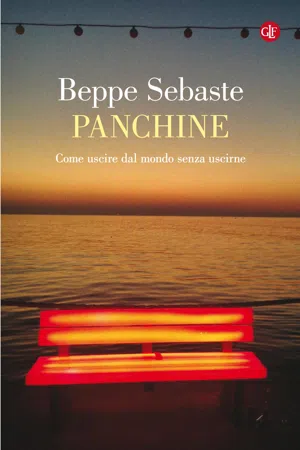Elenco
Ho fatto l’altro giorno l’elenco delle panchine che mi ricordavo (con esclusione di quelle di Parigi, che voglio pensare un’altra volta).
Le panchine (un paio) di Capalbio, su in paese, quasi un premio per chi vi arriva a piedi, nella piazzetta di fianco al ristorante, alle spalle il panorama della valle e delle colline, e di fronte la fontana con la scultura di Niki de Saint Phalle – rumore d’acqua, la città vecchia che comincia, dove ci si aggira come dentro un castello, però pacifico, molto pacifico.
Le panchine della grande piazza vuota di Borgo Carige (sotto Capalbio), con davanti una locanda chiusa con un’insegna scolorita che sembra un edificio rurale, anzi la casa dei contadini di Novecento, e in quel vuoto ci si sente bene una volta che lo si capisce e che si sa dove ci si trovi (tutta quella zona è difficile da capire all’inizio, il mare se non lo sai non lo trovi, e la campagna intorno non sai come usarla, eppure è bellissima, il verde e il giallo insieme). Bisognerebbe cercare soprattutto di definire la qualità di quel vuoto.
La panchina di legno a Bologna verso la fine di via Zamboni, vicino all’istituto di Matematica (o di Geografia?) all’incrocio con la fine (o l’inizio) di via Belle Arti, dove ci si riposa in uno spiazzo tra il traffico dei corpi, senza mescolarsi ai bar dei panini (quelle paninoteche nate all’improvviso, fine anni Settanta, mentre prima i panini li facevano i salumieri). Da quella panchina si vedeva anche la fila di chi andava alla mensa. E lì seduti una notte con Valeria e Nereo si parlava di tutte le case in cui avevamo abitato e da cui eravamo stati sfrattati, primi anni Ottanta, e Nereo citava un’ordinanza del Comune di Bologna sulle case da assegnare che dava la precedenza a «chi vive in una grotta» (?).
La panchina di pietra sempre a Bologna attaccata al baretto d’angolo sopravvissuto, si chiamava «Pierino», a forma di cuneo, inizio via Belle Arti, gestito da due vecchietti a ridosso di uno spazio vuoto edificabile, che per anni gli speculatori volevano demolire (alla loro morte ci riuscirono), e dove abbiamo passato tanto di quel tempo (tempo distribuito in modo equanime, in realtà, tra lì e molti altri posti all’aperto), tempo perso e felice di cui vorrei riuscire a descrivere la pienezza fisica, il lusso, perché quel modo di perderlo, il tempo, di farlo scorrere, mi manca oggi anche fisicamente.
La panchina di pietra della piazzetta San Domenico, a Napoli, tra l’Istituto Orientale e la mitica pasticceria Scaturchio, dove aspettavo che mi si confezionasse una pastiera che avrei portato a casa (all’epoca, a Pietrasanta).
Le panchine maiolicate nel chiostro della chiesa di Santa Chiara, a Napoli, anzi Spaccanapoli.
Una panchina a Capri, con la vista che si vede da Capri (era il luogo più appartato e lussuoso, senz’altro più dei ristoranti gremiti di folla e di rumore).
Una panchina panoramica in una curva lungo la strada sopra il lago di Bracciano, con vista sul paese e il lago di Bracciano, vicino alla casa di Niki e Andrea. Tutto il resto non mi piaceva, la panchina sì.
Le panchine lungo il lago di Castelgandolfo, malinconico e perfetto, il paese e le case abbarbicate sulle colline intorno, anche quella papale, quasi una miniatura del mondo in uno sguardo, che faceva pensare all’espressione «origine vulcanica» – geologicamente ancestrale (nonché atea) – dei laghi, e forse del mondo.
Le panchine nei pressi del cosiddetto «ponte romano» all’inizio della pineta della Versiliana, lungo viale Apua, a Fiumetto (Marina di Pietrasanta), quasi una cartolina illustrata.
Le panchine del giardinetto di Fiumetto, con vista sul mare (alzando la testa), tra il bar Grimaldi e quell’altro di cui non ricordo il nome, sotto l’hotel azzurrino, ma soprattutto dietro l’edicola che mi prestava i fumetti da leggere lì nelle mie lunghe pause (pause da cosa?). (All’inizio, con le giostrine per i bambini e i cigni nel canale, quello spazio mi sembrava uscito da un vecchio film di Wenders.)
Le panchine sul lungomare commerciale di Viareggio, lo struscio pedonale il pomeriggio tardi e la sera, e una soprattutto, quella davanti alla Libreria Internazionale, che è bianca, e aperta anche la notte (almeno in estate).
La panchina bianca privata dove ci si siede con finta modestia lungo gli spogliatoi dell’Augustus Lido, davanti al bar sulla spiaggia, dal fascino così coloniale (Forte dei Marmi).
Le panchine di Tonfano (Marina di Pietrasanta), dove mi fermavo quando andavo alla posta, e dove negli ultimi anni avevano posto una scultura di Kan Yasuda, Porta di ritorno (ma io me n’ero già andato, senza più farvi ritorno) (ora, mi dicono, se n’è andata anche la scultura, con tutte le panchine).
Le panche di pietra rosa lungo la fontana circolare del monumento colonialista a Vittorio Bottego, di fronte alla stazione, a Parma; c’erano pesci rossi nella vasca circolare, e da bambino mi piaceva guardarli stando in piedi sulle panchine rosa, e guardare Vittorio Bottego con l’elmetto coloniale e con un selvaggio vinto ai suoi piedi – poi l’acqua è diventata melmosa, e lì si ritrovarono negli anni solo i drogati all’ultimo stadio, nemmeno gli immigrati (non si sa cosa diventerà, è un cantiere recintato, l’acqua è sparita, forse sparirà anche il monumento, nella smania dei cambiamenti e dei make up, forse qualcuno se ne vergogna, eppure dovrebbe restare, quel fascismo con l’elmetto è la nostra storia, ed è il più onesto monumento all’azienda Italia che conosco).
Le panchine di legno verde alla fine del molo di Forte dei Marmi che sembra una fotografia di Luigi Ghirri, dove ho camminato tante volte guardando il mare e l’orizzonte, o i surfisti quando ci sono le onde, di giorno, di sera, di notte – perché è un luogo molto consolante, soprattutto l’inverno. Ci sono andato tante volte anche con mio figlio, e quando il mare era molto mosso le onde ributtavano l’acqua in su dalle fessure del molo, e ci si doveva arrampicare ridendo sulle panchine per non bagnarsi i piedi.
La panchina vicino a Torre dell’Orso, in Salento, sull’Adriatico, posta dentro un anfratto roccioso, sola, isolata, invitante, quasi scintillante nella sua imprevedibilità, all’ombra, con vista sul mare e il sole ed il mondo che brilla, e dove mi sono fatto fotografare.
La panchina rossa sullo Zermatt, in mezzo alla neve, dove mi sono seduto a riposarmi e ho scritto una poesia sul tradire = scrivere guardando le orme che avevo lasciato sul sentiero di neve.
Le panchine dei piccoli giardini recintati a Manhattan, New York, alcune delle quali sono riservate a chi accompagna un cane, e dove mi sono seduto senza avere un cane.
Le innumerevoli panchine visitate dagli scoiattoli a Central Park, dove mi sono meravigliato anch’io e ho fotografato gli scoiattoli (o ratti, direbbe Max Frisch). (Ero vestito come un giovane professore da film, con un soprabito di gabardine che amavo molto, e che mi hanno rubato a Parma dalla mia automobile, anni dopo.)
Le panchine sulle meravigliose distese d’erba e gli eucalipti, in realtà campo da golf, dell’Ojai Valley Inn a Ojai, California, e quelle nel resto del paese, dove capitai per caso bevendo una Coca Cola, dove rimasi una settimana meravigliandomi di stare così bene, e dove scoprii, dopo, che vi aveva risieduto Krishnamurti.
Le panchine di fronte agli edifici della New York University, i muri rossicci, la quiete composta.
Le panchine di Ashbury Heighs, una volta ritrovo degli hippies, a San Francisco (dove ho perso il taccuino con tutto quello che avevo scritto, su San Francisco e sulla California).
Le panchine di Washington Square (a San Francisco, non a New York. Eppure sono belle anche quelle di N.Y., ma nella piazza di S.F. c’era il sole).
La panca di legno di Big Sur, all’ingresso del Big Sur Inn, dove mi sedevo a scrivere, oppure a parlare col custode hippie della Henri Miller Library, aspettando che prima o poi passassero le balene, là sotto.
Le panchine nella piazza di Palermo dove una notte, all’uscita da una privata cena sontuosa nella sala della mitica biblioteca dell’autore del Gattopardo, sono rimasto incantato a guardare il tronco di un ficus che avrebbe potuto ospitare all’interno tre o quattro famiglie (ma mi sarei seduto anche senza il ficus).
Le panchine disposte a cerchio intorno a una fontana a Villa Borghese, dove abbiamo bivaccato per ore io e alcuni ex studenti e studentesse del mio corso di formazione all’Accademia, biscotti dolci e salati, patatine, vino e succhi di frutta, finché ci siamo messi a osservare la statua sulla fontana (autore Giovanni Nicolini, scultore, anno 1925), del genere la bella e la bestia, un satiro tardo liberty color verderame (colore che, mi ha insegnato una ex studentessa, viene dall’ossidazione del rame, scoperto dagli egizi – come anche il blu).
Le bellissime panchine vecchio stile, sparse ad arte nel grande prato dietro il borgo di Ostia Antica, alle spalle dell’unica piazza (quella coi lecci e il bar) che non si vedono subito, sono sette, ma se ne vedono massimo due alla volta, ognuna circondata da una sua solitudine (il prato si chiama Parco dei Ravennati, con sotto scritto come didascalia: bonificatori).
La panchina nella piazzetta circolare davanti alla piccola stazione di Novoli (Lecce), paesino natale di mia madre, dove da ragazzo mi isolavo sognando di andarmene, perché odiavo passare l’estate in quel posto dove non succedeva niente, c’era solo il sole e il cibo, e dove ora invece agogno ogni volta di andare, perché non succede niente, c’è solo il sole e il cibo. E cielo, luce, spazio, qualche generosa panchina.
Una delle panchine isolate nello spazio dell’immenso parco di Monza, città in cui da ragazzo fui parcheggiato in casa di una sorella (sposata) e dove mi rifugiavo a leggere, e precisamente lessi Il mestiere di vivere di Cesare Pavese e La vita agra di Luciano Bianciardi.
La panchina nella piccola stazione di Casalmaggiore un pomeriggio d’estate, dove mi trovavo perché avevo comprato, proprio lì, un panetto di hashish, e dove guardavo i gerani e i gesti indolenti del capostazione col cappellino dalla visiera rossa, e dove ho scritto una poesia sul desiderio di diventare capostazione di un paesino così (e continuare quindi a scrivere poesie).
Le panchine del piccolo parco les Cropettes, sotto casa a Ginevra, rue du Fort Barreau (dietro la stazione Cornavin), dove ho letto Mes amis di Emmanuel Bove (prima di tradurlo anni dopo in italiano, proprio mentre Peter Handke lo traduceva in tedesco) e dove ho letto gli scritti di Benjamin Constant sulla conversione («desiderare quello che abbiamo, non quello che ci manca»). Su quelle panchine mangiavo felicemente il pane caldo con dentro la cioccolata, quando avevo i soldi per comprare appunto solo il pane caldo e una stecca di cioccolata al vicino negozio della Migros.
C’è una panchina vicino alla tomba di Rilke? C’è una panchina nel piccolo prato attiguo alla chiesetta di Raron (Sierre, sopra Sion, Valais, Svizzera) dove si trova la tomba bianca e nuda, spoglia come una panca rude rovesciata, del poeta Rainer Maria Rilke? O me la sono inventata io? Di fatto ci ho soggiornato lunghi momenti almeno due volte, incantato dal silenzio, dalla scelta del poeta (che abitò lì, a Muzot, e lo immaginavo, dopo avere scritto i suoi poemi, scendere da qualche contadino a chiedere del formaggio per la cena), incantato dalle parole – disadorne come la lapide che le riporta – «rosa bianca purissima / piacere di non essere più / il sogno di nessuno».
Le panchine sulla strada per andare al lago di Bienne, la città di Robert Walser, quando uscivo di casa (bisognerebbe scrivere Biel/Bienne, come nei cartelli e alla stazione, perché è una piccola città bilingue – tagliata dalla frontiera del rösti, dicono lì), ma di fatto io abitavo a Bienne, perché sono francofono.
Le panchine lungo il lago di Bienne, dove spesso non si vedeva quasi niente per la nebbia (come il lago di Stranger than paradise), e a me piaceva moltissimo (anche il film).
Una panchina (ma dove? forse a Firenze) in cui con altri tre amici, tutti circa diciottenni, ci siamo messi a suonare per raccogliere soldi (colletta, si diceva), quattro piccoli fricchettoni, e io suonavo l’armonica a bocca e sulla chitarra facevo acuti disgraziati stile blues (a volte suonavo anche i bonghi), e la cosa stupefacente è che qualcuno si fermava, qualcuno ci ha addirittura dato dei soldi (le monete da cento lire, per chi se le ricorda).
Le panchine di sera in fondo al lungomare di San Terenzo, direzione Lerici, quando a un certo punto finisce (sopra quella collinetta e il voltone c’era un albergo stile liberty, forse il Byron), finiva anche la spiaggia e c’erano gli scogli su cui s’infrangevano le onde, e mio padre mi diceva «respira» – quando si vedeva il bianco spumoso, e quello era ...