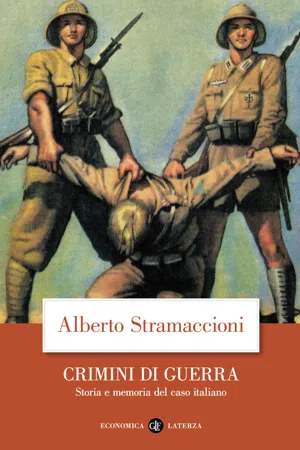III.
La seconda guerra mondiale
La seconda guerra mondiale vide l’Italia impegnata in un conflitto lungo e distruttivo: prima da alleata della Germania nazista e poi, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, da cobelligerante con gli anglo-americani.
Tra il 1940 e il 1943 l’esercito italiano impegnò nella guerra tra i 4 e i 4,5 milioni di combattenti, occupando la Francia meridionale, l’Africa settentrionale e poi l’Albania, la Grecia, la Jugoslavia e la Russia. In questi Paesi, con diverse modalità, giunse ad organizzare campi di concentramento, dopo massacri e deportazioni di civili e partigiani, facendo migliaia di vittime.
Tra il 1943 e il 1945, dopo lo sbandamento e la successiva ricostruzione parziale dell’esercito italiano, i nazisti, sentendosi traditi dall’Italia fascista e incalzati dall’avanzata da sud dell’esercito anglo-americano, compirono a loro volta rastrellamenti, eccidi e rappresaglie aiutati dai fascisti della Repubblica di Salò, giungendo alla soppressione di circa 15.000 civili in più di 2.000 stragi.
1. I crimini italiani in Jugoslavia, Grecia e Albania
Nel settembre 1939, dopo l’avvio del conflitto che sfociò nella seconda guerra mondiale, l’Italia assunse la posizione di Paese neutrale, pur essendo alleata della Germania nazista di Adolf Hitler. Le successive valutazioni politico-militari di Benito Mussolini e del re Vittorio Emanuele III condussero però l’Italia, il 10 giugno 1940, dopo l’occupazione nazista di Parigi, a dichiarare guerra alla Francia e alla Gran Bretagna schierandosi al fianco dei tedeschi e considerando pressoché certa la vittoria della Germania in Europa. Mussolini intendeva comunque partecipare al conflitto, con una certa autonomia, attraverso una specie di «guerra parallela», occupando prima la Francia e poi la Jugoslavia, la Grecia e l’Albania e intervenendo anche in Africa del Nord e in Russia al fianco dei tedeschi1.
Ma fu l’occupazione politico-militare della Jugoslavia da parte dell’esercito tedesco e di quello italiano tra il 1941 e il 1943 ad essere particolarmente aggressiva2.
Il 6 aprile 1941 gli eserciti tedesco, italiano, ungherese e bulgaro invasero il Regno di Jugoslavia e dopo i primi scontri si giunse alla creazione delle nuove province italiane di Lubiana, Spalato e del Cattaro, all’espansione di quelle già esistenti di Fiume e Zara, all’istituzione di un Regno di Croazia guidato da Aimone di Savoia e al dominio sul Montenegro3.
La politica di occupazione dei Balcani si contraddistinse per una serie di ripetute violenze che non furono il risultato di scelte isolate dei Comandi militari, ma una componente essenziale delle strategie di dominio territoriale dell’Italia fascista.
Questi obiettivi del governo mussoliniano e dello Stato maggiore vennero attuati da un esercito al cui interno c’erano ufficiali e soldati che avevano giurato fedeltà al re, soldati non politicizzati, ma anche molti volontari fascisti inquadrati in speciali strutture militari come la Milizia volontaria anticomunista (Mvac), integrata nell’XI Corpo d’armata.
L’occupazione italiana e tedesca avvenne in un contesto politico e militare balcanico molto complesso. Inizialmente la Jugoslavia, il 24 marzo 1941, aveva aderito al Patto tripartito di Adolf Hitler, ma tre giorni dopo un colpo di Stato maturato in ambienti militari e sollecitato dai servizi segreti inglesi ruppe l’accordo con la Germania e l’Italia. A distanza di pochi giorni la Jugoslavia firmò un trattato di amicizia con l’Urss. Questo mutamento radicale nella politica delle alleanze indusse il 6 aprile le forze tedesche, italiane e ungheresi a invaderla. L’esercito tedesco iniziò un’avanzata verso Belgrado su tre direttrici, e anche grazie ai conflitti interetnici e, in particolare, all’atteggiamento croato, le forze armate del Regno della Jugoslavia riuscirono a resistere solo dieci giorni. Re Pietro II e alcuni membri del governo si rifugiarono a Londra, mentre altri ministri e militari firmarono l’armistizio e il 19 aprile l’esercito bulgaro poté procedere all’occupazione della Macedonia.
Di fronte a questa situazione prese corpo una resistenza armata all’occupazione che però, ben presto, si divise. I partigiani comunisti guidati da Josip Broz Tito entrarono in conflitto con l’esercito jugoslavo monarchico e con l’armata dei četnici (serbi nazionalisti), ma anche con i croati filonazisti (ustaša). Ebbe così inizio la guerra civile, uno scontro che coinvolse anche la resistenza anticomunista e antinazista, di etnia prevalentemente serba, comandata dal generale Draža Mihajlovič, che aveva al suo interno interi settori dell’esercito jugoslavo e molte bande cetniche sostenute dai britannici, dagli Stati Uniti e dal governo jugoslavo in esilio. In seguito ai successi delle forze partigiane di Tito, tuttavia, nel 1942 e 1943 gli Alleati tolsero il sostegno ai četnici e riconobbero ufficialmente i combattenti titini durante la Conferenza di Teheran del dicembre 1943. Con Tito, dopo l’armistizio, combatterono anche alcune formazioni militari italiane come i soldati della divisione «Garibaldi», anche se alcuni loro ufficiali vennero fucilati per aver avversato i partigiani jugoslavi prima dell’8 settembre.
Con il passare dei mesi l’occupazione italiana e tedesca dopo l’aprile 1941 divenne via via più brutale, di fronte al crescere del movimento di resistenza slavo, particolarmente organizzato e sostenuto dalla popolazione.
A questo proposito è significativa una circolare del generale Mario Roatta, comandante della II Armata dell’esercito italiano nei Balcani, del 1° marzo 1942 (ristampata nel dicembre e composta di oltre duecento pagine), che prevedeva di incendiare e demolire case e villaggi, uccidere ostaggi, internare massicciamente la popolazione e passare per le armi anche quelle famiglie in cui mancassero all’appello uomini in età adulta e quindi potenziali ribelli4.
Analoghi intenti repressivi aveva il dispositivo emanato nell’agosto 1942 dal generale Mario Robotti, collaboratore di Roatta, nel quale tra l’altro si leggeva:
non importa se nell’interrogatorio degli arrestati si ha la sensazione di persone innocue, ricordarsi che per infinite ragioni anche questi elementi possono trasformarsi in nostri nemici, quindi sgombero totalitario, non limitarsi agli internamenti5.
Successivamente, lo stesso generale Roatta scrisse esplicitamente che la guerra era di tipo coloniale e che andava combattuta anche con mezzi sproporzionati rispetto agli obiettivi. Significativa a tal proposito la circolare 3C, del 1° dicembre 1942, sul trattamento da usare con le popolazioni e i partigiani nel corso delle operazioni. In essa, al capitolo riguardante Misure precauzionali nei confronti della popolazione6, si prevedeva l’internamento di famiglie e di intere popolazioni rurali, si prescriveva alle truppe italiane di prendere ostaggi, si ordinava di considerare corresponsabili gli abitanti di case nelle cui vicinanze venivano compiuti attentati. L’ordine era di internarli, confiscare il bestiame e distruggere le loro abitazioni, mentre li si incitava a passare per le armi gli ostaggi in caso di aggressioni ad italiani. Si assicuravano, infine, i membri dell’Armata che «gli eccessi di reazione, compiuti in buona fede, non verranno mai perseguiti», e il riferimento al trattamento riservato ai partigiani veniva sintetizzato nel passaggio dalla formula «dente per dente» a quella di «testa per dente».
La circolare 3C del generale Roatta non fu comunque un episodio circoscritto, determinato da un comandante fedele al fascismo; misure analoghe vennero infatti adottate dall’esercito italiano anche in Francia, Corsica, Montenegro, Grecia e Albania7. Il lavoro particolarmente repressivo che in Africa veniva spesso delegato alle truppe coloniali eritree, nei Balcani fu svolto direttamente dagli italiani. Numerosi furono i villaggi croati e dalmati distrutti dai soldati dell’esercito regio che attuarono esecuzioni sommarie, incendi, razzie, saccheggi e stupri. Ciononostante, il generale Robotti, al comando dell’XI Corpo d’armata, avvertiva i suoi subordinati che «si ammazza troppo poco», mentre contro ogni convenzione internazionale i medici civili che prestavano cure ai feriti senza denunciarli ai Carabinieri venivano minacciati di morte. A ciò si aggiunsero le deportazioni di massa e lo sgombero di intere zone della Slovenia. Questa regione nel 1941 venne divisa in tre parti: Lubiana e le regioni meridionali all’Italia, il Nord alla Carinzia (divenuta anch’essa dopo l’Anschluss un Land del Terzo Reich) e una parte più piccola all’Ungheria. Secondo fonti slovene, 35.000 persone – il 10% della popolazione della provincia di Lubiana – furono deportate in pochi mesi.
Dai materiali prodotti dalla Commissione d’inchiesta per i presunti crimini di guerra italiani, istituita nel 1947 e presieduta da Luigi Gasparotto, a macchiarsi di reati non furono soltanto le Camicie nere o i vertici militari politicizzati, ma ufficiali e soldati comuni come gli Alpini dei battaglioni «Ivrea» e «Aosta», «che rastrellarono undici villaggi in Montenegro e fucilarono venti contadini». Anche il prefetto del Carnaro Temistocle Testa, per l’eccidio di Podhum, un villaggio a pochi chilometri da Fiume, «si servì di reparti normali». In quell’occasione, dopo aver circondato il villaggio e bloccato tutte le strade di accesso, il 12 luglio 1942 reparti dell’esercito italiano aiutati dai Carabinieri e dalle Camicie nere fucilarono oltre 100 uomini, catturarono la rimanente parte della popolazione, circa 200 famiglie, confiscarono beni mobili e circa 2.000 capi di bestiame. Il generale Taddeo Orlando rastrellò invece la città di Lubiana, la capitale della Slovenia, che fu circondata il 23 febbraio 1942 con reticolati di filo spinato. Dei 40.000 abitanti maschi ne furono arrestati 2.858 e circa 3.000 vennero catturati in un secondo rastrellamento. La chiusura dei centri abitati con reticolati venne applicata ad altre 25 località, e oltre ai maschi adulti vennero deportati anche vecchi, donne e bambini8.
Questa occupazione militare italiana si muoveva sul modello tedesco, tanto che si realizzarono oltre 20 campi di concentramento, i p...