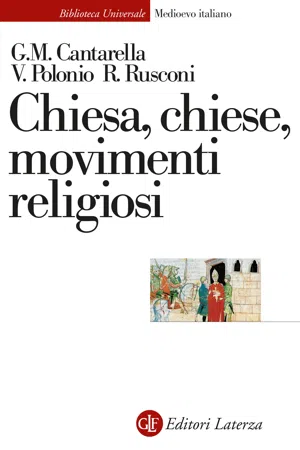
eBook - ePub
Chiesa, chiese, movimenti religiosi
- 288 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Chiesa, chiese, movimenti religiosi
Informazioni su questo libro
L'affermazione del primato del papato romano; la nascita e lo sviluppo del monachesimo; gli Ordini mendicanti e le nuove forme di religiosità basso-medievale: mille anni di sperimentazione continua, e talora di veri e propri rivolgimenti, che hanno plasmato le strutture istituzionali della Chiesa. Una nuova edizione con aggiornamenti bibliografici.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Chiesa, chiese, movimenti religiosi di Glauco Maria Cantarella,Valeria Polonio,Roberto Rusconi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Storia dell'Europa medievale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Il monachesimo nel Medioevo italico
di Valeria Polonio
1. Ricerca di Dio e fuga dal mondo.
Le esperienze più antiche (secoli IV-VI)
1.1. I fatti
In un autunno di poco anteriore all’anno 420, Rutilio Namaziano, funzionario romano oriundo delle Gallie, risale il Tirreno, diretto alle terre d’origine. Rutilio è pagano, sebbene il cristianesimo sia ormai religione ufficiale dell’impero; ed è un intellettuale sensibile, affascinato dalla grandezza e dalla civiltà di Roma. Il viaggio è all’origine di un poemetto, in cui è espresso ammirato interesse per il paesaggio. Ma la vista di alcune isole suscita nell’autore tutt’altro che compiacimento: la Capraia è divenuta orrida per la presenza di un buon numero di uomini che fuggono la luce – «squalet lucifugis insula plena viris» (De reditu suo, I, 440) –, segregati volontariamente o per viscerale pessimismo nei confronti della vita o per avversione nei riguardi del genere umano; la Gorgona rievoca il concreto esempio di uno scandalo del genere, attraverso la recente scelta di un giovane di alta condizione che, lasciati dietro di sé matrimonio e fortune, vi si è rifugiato in solitudine. Circa centosettanta anni più tardi, Gregorio I Magno, romano di illustre famiglia, alto funzionario pubblico e poi monaco egli stesso prima di divenire papa, nei suoi Dialogi addita ripetutamente quali modello di santità i numerosi solitari di cui è riuscito ad avere notizia, vissuti per lo più nell’Italia centrale nei decenni precedenti.
Queste testimonianze del V e del VI secolo, al di là delle opposte valutazioni, ci mettono di fronte a un fenomeno di ricerca dell’isolamento, per motivi e scopi religiosi, in progressivo sviluppo. Per molti aspetti esso si allaccia all’analoga, rapida e intensa fioritura verificatasi in Egitto e nella vicina Asia (dalla Palestina alla Siria alla Cappadocia), a partire dalla seconda metà del III secolo e lungo il IV. Secondo una tradizione ben presto consolidata, il patriarca di tutti i monaci, colui che detiene la palma di una prima perfetta esperienza raggiunta attraverso progressive fasi di isolamento e di affinamento interiore, è l’egiziano Antonio (250 circa-356). La sua Vita, redatta da Atanasio (vescovo di Alessandria dal 328, morto nel 373), sortisce subito un formidabile effetto propagandistico, in armonia con il suo carattere di trattato spirituale con scopi parenetici. Ciò nonostante, è indispensabile notare come un testo tanto importante non introduca spunti nuovi. La stessa narrazione ci dice che Antonio si rivolse a un maestro, almeno nelle prime fasi della sua vicenda, e soprattutto che trovò numerosi discepoli, decisi a seguire le sue orme, ed estimatori di vario rango intenzionati a restare nel mondo, che ricorrevano a lui per consiglio.
Il monachesimo cristiano, nelle sue prime attestazioni definite, si presenta come un fenomeno già largamente condiviso, basato su disposizioni interiori diffuse. L’Egitto – dalle zone a mezzogiorno di Alessandria sempre più a sud lungo la valle del Nilo per giungere fino ai territori intorno a Tebe – si popola di monaci e aspiranti tali. Ma non è questa l’esclusiva culla di un fenomeno che in breve si dimostrerà esteso su una scala molto più ampia e con manifestazioni tra loro differenziate. La Siria – intesa nella sua accezione antica, con diramazioni verso terre iraniche, in Mesopotamia, in direzione dell’Asia Minore – è patria di fenomeni peculiari, ben diffusi nel IV secolo; su di essi molto si discute, dato che non paiono mutuati dall’Egitto, bensì frutto di spiritualità e di atteggiamenti etici originali, eventualmente influenzati da settori orientali, come la Persia e forse, almeno secondo alcuni studiosi, l’India. La Palestina e, molto più a settentrione, la Cappadocia conosceranno a loro volta una ricca diffusione ascetica più o meno organizzata.
In sostanza, nel fenomeno monastico, così come si manifesta ai suoi rigogliosi inizi nelle parti orientali della cristianità, non è corretto individuare una matrice esclusiva; né è possibile identificare un’unica, semplice circolazione di idee. Semmai si può notare un processo di assimilazione entro il cristianesimo di pulsioni portatrici di esperienze esterne; e si può delineare a grandissime linee lo sforzo di organizzare energie vigorose e fortemente individualiste. Nello stesso sistema di vita, così come viene elaborato e prospera nelle esperienze orientali, si identificano filoni differenti. Il primo è radicalmente anacoretico, condotto nell’abbandono del consorzio civile, prima di tutto urbano ma anche umano nel senso più lato: il monaco è veramente solo, come vuole l’etimo greco del termine, nel combattimento quotidiano lungo un erto itinerario spirituale e nella soluzione delle più banali necessità di sopravvivenza. Un altro filone, dovuto alle iniziative condotte dall’egiziano Pacomio (circa 292-346) e ordinato da norme da lui dettate, introduce l’esperienza collettiva del monastero, in cui ha spazio anche il lavoro manuale, ma in modo tale da lasciar prevalere la tensione e l’iniziativa individuali. Un terzo, elaborato e disciplinato da Basilio di Cesarea di Cappadocia (329-79), organizza in maniera più compatta una piena vita di comunità. Il confronto di esperienze e di metodi ora si fa effettivo ed efficace; tuttavia, i tre stili non rappresentano rispettivi progressi o superamenti, ma continuano a convivere, a volte con commistioni, a seconda dei luoghi e delle scelte. Questi rapidi cenni, funzionali a molti aspetti dei temi in seguito proposti, non devono indurre a semplificare in maniera riduttiva il fenomeno del monachesimo orientale, straordinariamente ricco – all’interno e negli effetti sul mondo – e durevole – in sé e negli esiti più tardivi –, frutto e nello stesso tempo strumento della varia e feconda comunità civile e culturale che respira intorno al Mediterraneo (orientale e non solo) e nel suo entroterra nei secoli tardo-antichi.
Esperienze tanto variate e numerose hanno i loro riflessi in Occidente, dove trovano alcuni ambienti molto ricettivi. I monaci cristiani dell’Oriente mediterraneo divengono figure eroiche recepite come modelli. Le loro conquiste spirituali e ascetiche entrano nelle conoscenze dell’Occidente prima di tutto attraverso spostamenti di uomini. La politica filo-ariana di alcuni imperatori del IV secolo ha provocato viaggi coatti di ecclesiastici eminenti, ben al corrente della vita religiosa e determinanti per l’esistenza delle collettività: l’esilio a Roma (340-43) proprio di Atanasio di Alessandria e di alcuni suoi chierici è un formidabile volano per la conoscenza delle scelte di Antonio; l’esilio in senso contrario di vescovi occidentali (primo tra tutti, per l’Italia, Eusebio di Vercelli) è all’origine di esperienze e informazioni importate in sede al rientro.
Altri ancora si fanno propagandisti, con la parola e con la stessa vita, di ciò che è maturato nel vicino Oriente e che in tempi rapidi trova in Europa protagonisti mossi da esigenze proprie. Prima del 360 Martino (originario della Pannonia, già avviato sull’itinerario che approderà a quella Tours cui il suo nome resterà legato) fonda vicino a Milano un ente di cui sfuggono i caratteri, ma definito come monasterium; poco dopo trascorre un periodo sull’isolotto della Gallinaria, a breve distanza dalla costa ligure occidentale, non lontano da Albenga: è il primo, tenue annuncio di quel tema isolano che tanto indignerà Rutilio Namaziano. A Roma ciò che già era stato seminato da Atanasio è rinvigorito nel 373 da Pietro, suo successore sulla cattedra di Alessandria. Soprattutto, tra il 382/383 e il 385, vi opererà Gerolamo: non si dimentichi che egli, originario di terre poste tra l’Italia di nord-est e la Pannonia e formatosi nei più attivi centri della cultura occidentale, ha alle spalle un ritiro nei deserti di Siria, esperienza fondamentale anche se non del tutto soddisfacente.
I primi contatti, limitati a circoli di alto livello sociale, aprono la strada alla diffusione, tra un numero molto maggiore di individui, di opere specifiche sull’argomento. La vita di Antonio, redatta da Atanasio di Alessandria, viene molto presto tradotta in latino. È seguita in breve da una ricca letteratura relativa agli eroi del deserto. L’Occidente – e l’Italia con gli altri – ha sete di testi del genere. Gerolamo, nella sua ricchissima e varia produzione, non trascura il settore; si susseguono traduzioni latine di opere redatte da scrittori orientali; l’attenzione si volge, oltre che al genere biografico – o agiografico che dir si voglia –, anche a testi di carattere normativo. A ciò si aggiunga una nuova corrente di influenza. Nella zona provenzale, agli inizi del V secolo, sorgono alcuni centri importanti, presto propulsori dei concetti e della pratica monastici: i cenobi marsigliesi e quello di Lérins (su un’isola situata non lontano da Cannes) affondano le radici nel crogiolo monastico orientale e irradiano i suoi principi verso l’Italia anche da occidente.
Con tutto ciò, il passaggio a una applicazione concreta dell’ideale vagheggiato non è semplice. Lo stesso stile di vita, come si è detto, presenta modelli differenti. In Italia è difficile cogliere le prime manifestazioni compiute di scelte monastiche. Le inclinazioni ascetiche di singole persone e la loro aspirazione a una vita di concentrazione interiore, anche quando si incontrano con gli ammirati modelli orientali, a tutta prima si traducono in uno stile individuale austero, in preghiera e meditazione condotte in comune con personalità affini, in generosa attività caritativa, ma sempre entro l’ambito domestico; va anche detto che inclinazioni del genere possono suscitare diffidenza e incomprensione nello stesso ambito cristiano. La risposta più immediata viene dal mondo femminile. Le conversazioni di Atanasio e di Gerolamo sollecitano alcune dame del gran mondo romano verso una vita austera e meditativa che può anche sboccare in una sorta di esperienza comunitaria, in associazione con parenti e ancelle, nei palazzi di città o, meglio, suburbani. La velazione delle vergini consacrate diventa una cerimonia formale, il che significa che queste donne raggiungono uno stato noto e riconosciuto. Si tratta pur sempre di una vita di tipo domestico, mentre lo stile degli eventuali gruppi dipende dalla persona che ha preso l’iniziativa e non da un sistema. Lo stesso Gerolamo, dopo il soggiorno romano nel corso del quale si è fatto propagandista di scelte radicali, se vuole condurre e organizzare vita monastica finisce con il ritirarsi a Betlemme; là si stabiliscono le discepole più determinate; sempre in Terrasanta sarà, ormai nel V secolo, l’approdo monastico di Melania la Giovane e di Piniano, coniugi romani di altissimo rango.
Tuttavia, qualcosa si è già mosso proprio entro il IV secolo. Le scelte di tipo anacoretico sono, dal punto di vista organizzativo, le più semplici da tradurre in realtà. Nello stesso tempo, per loro natura, esse lasciano pochi segni: ma già Gerolamo scrive di monaci sparsi in tutto il mare «etrusco» e nella provincia dei Volsci (Epistulae, LXXVII, 6); il pullulare di analoghi personaggi denunciato da Rutilio Namaziano indica un fenomeno ormai radicato e diffuso; gli eremiti dell’Italia centrale, di cui scrive Gregorio Magno verso la fine del VI secolo, sono vissuti e hanno operato nei decenni precedenti. Insomma, in Italia le isole, i promontori solitari e la foresta hanno preso il posto del deserto, mutuandone il carattere di luogo di tentazione e, nello stesso tempo, di grazia. Lungo i litorali toscano e ligure, come in Sardegna, ancora oggi radicate tradizioni parlano di eremiti, singoli o a gruppetti, molto spesso di provenienza esterna, orientale o africana. Recenti indagini archeologiche – là dove sono state compiute – hanno posto in evidenza elementi coerenti con le remote certezze; nelle singole località si è costituito un nucleo di sacralità che, in tempi successivi, è divenuto riferimento per nuovi impianti di vita regolare. Lo stesso discorso si applica ai solitari delle selve dell’Italia centro-meridionale. Essi sono ricordati in Umbria (intorno a Spoleto e a Norcia), nel Lazio (nelle zone di Rieti, Tivoli, Fondi, Alatri), sui monti dell’Abruzzo; ad alcuni di loro è attribuita provenienza esterna, addirittura siriaca; diversi insediamenti conosceranno in futuro nuova floridezza.
In quanto ai primi centri di vita comune, il loro impianto è collegato con coloro che già hanno capacità organizzativa, dal punto di vista istituzionale e pratico: le comunità di più antica memoria nascono per lo più all’ombra dei vescovi. Si è accennato all’intensità e mobilità di esperienze maturate nel corso dei contrasti esplosi intorno alla dottrina ariana. Puntualmente Eusebio di Vercelli, al ritorno dall’esilio in Oriente (363), organizza il suo clero in una forma di vita comunitaria cui egli stesso partecipa, sulla base di un austero ascetismo. L’esempio si diffonde in altre sedi non troppo lontane – da Torino a Piacenza, da Novara a Bologna –, si allarga a Verona; raggiunge Nola per opera di Paolino; come è noto, verrà introdotto in Africa da Agostino. Tuttavia, anche se in secoli successivi alcuni di questi presuli verranno gratificati di una aureola monastica, nessuno di loro fu monaco, né potevano esserlo i loro chierici, ben inseriti nel mondo in quanto depositari prima di tutto del compito della cura d’anime. Le loro iniziative pongono le basi di un altro genere di vita religiosa associata, quella che verrà chiamata «vita comune del clero». Individuata come un eccellente strumento di incremento morale e culturale e come un luogo ideale per la preparazione e la formazione degli elementi più giovani, essa andrà incontro, nei secoli a venire, a fasi di vigoroso incremento e si confronterà con l’ambito monastico; e ciò conferma come sia altra cosa.
L’esempio di comunità di chierici di vita ascetica, organizzate intorno a una figura guida, costituisce un elemento traente verso uno stile vagheggiato e altrimenti di difficile impianto. Nella penisola si manifesta l’aspirazione alla vita di comunità. Le esperienze esterne si fanno sollecitazione e guida a una meta auspicata per orientamento spontaneo. Qualche vescovo si fa promotore di cenobi veri e propri. Primo tra tutti è Ambrogio. La sua predicazione sollecita molte scelte femminili. C...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Dalle chiese alla monarchia papale di Glauco Maria Cantarella
- Il monachesimo nel Medioevo italico di Valeria Polonio
- La vita religiosa nel tardo Medioevo: fra istituzione e devozione di Roberto Rusconi
- Aggiornamento bibliografico
- Gli autori