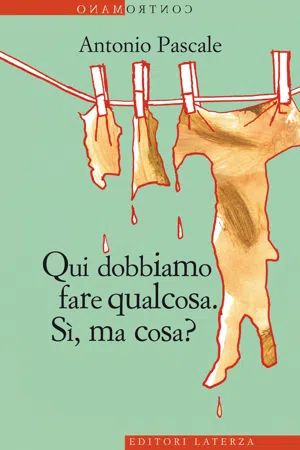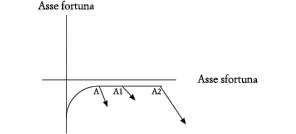Datemi una differenza: il piccolo orto di una volta...
Torniamo al sapere nostalgico. È chiaro che se ci appoggiamo troppo a un siffatto modello, poi, con molta probabilità capita che i conti in campo non tornino per niente.
Quando i conti non tornano non bisogna spaventarsi. Lo dicono i teorici della narrazione. È lì che il personaggio passa dalla cura alla manutenzione. C’è da verificare adesso. Toni più bassi. Abbiamo promesso alla nostra amata di preservare la sua bellezza e ci troviamo piegati in due da un mal di pancia inaspettato. Della bellezza della nostra amata comincia a importarci un po’ meno. In un buon racconto il nostro protagonista ragiona sul suo mal di pancia: sarà psicosomatico? Ho impiegato troppe energie e ora sono a secco? Chiaro che sì. Ci tocca rivedere la nostra promessa iniziale e ragionare sulle complesse variabili che la vita ci pone davanti. Dichiarare la nostra fragilità e riprendere il cammino.
Viceversa, in un cattivo racconto, il nostro protagonista piegato dal mal di pancia, continua ad alimentare la promessa iniziale. Oppure, visto che il mal di pancia gli rende la vita difficile, decide di affidarsi a una ricetta magica. Un salto logico. In fondo un terzo atto siffatto è simile al primo atto. Una facile promessa equivale a una facile risoluzione. Oppure terza ipotesi, se ho mal di pancia io, prevedo allora che tutti l’avranno da qui a poco. I miei sintomi sono evidenti segni che il mondo è malato, tutto torna, lo dico io che sono il poeta, il vate, il visionario. Stiamo precipitando. L’apocalisse è vicina. Però, niente male come discesa. Questo ultimo tipo di reazione al mal di pancia può andare sotto il nome di retorica dell’apocalisse, una tecnica usata, per esempio, dai Testimoni di Geova. Ce li ricordiamo tutti, no? Quei simpaticoni. Tendevano ad atterrirti. E convertirti. La procedura standard si svolgeva secondo passaggi collaudati. Rappresentare fenomeni complessi la cui trattazione richiederebbe competenze specifiche, con immagini semplici ed evocative. In più, associare cose molto distanti tra loro senza provare il nesso che dovrebbe unirle. La tecnica tuttavia funzionava e finiva per provocare in te una sorta di morboso stupore catatonico. Per un momento tutto sembrava tornare, così come le auto che inquinano l’aria, i veleni chimici che distruggono la terra. Del resto, queste immagini erano rapportate continuamente a un modello ritenuto ideale: un mondo bucolico, incontaminato frutto della bontà e della generosità di Dio. Insomma, l’ideale purissimo da una parte e la corruzione di cui sono portatori gli uomini. La scelta si restringe. O ti converti o muori.
In realtà gli apocalittici tendono per vanità a sopravvalutare alcuni sbalzi della curva, insomma, si fidano troppo dei loro mal di pancia. C’è di più, spesso scoprono che si guadagna anche abbastanza (gli apocalittici e i nostalgici godono nei media di una buona rendita di posizione) prolungando l’agonia. Più si semplifica la visione dell’apocalisse più le persone ne sono attratte. Anche loro, in fondo, vogliono solo raccontare la storia. La storia della fine del mondo contiene elementi epici. Il risultato? Può succedere che aspettando l’apocalisse il sentimento che più comunemente si può impadronire di noi sia quello della frustrazione, del tipo appunto: non riusciamo a gestire i rifiuti figuriamoci le scorie nucleari.
Graficamente parlando? Uno stato di piattezza dove gli unici movimenti sono quelli immaginati dai teorici dell’apocalisse: A, A1, A2, cioè, apocalissi, più o meno intense, più o meno profonde, che non arrivano e ci lasciano un senso di immobilità. E un ritardo cronico.
Ora, per parlare di un campo verso il quale ho qualche interesse (culturale e lavorativo), cioè l’agroalimentare, è facile dimostrare che affermazioni del suddetto tipo (sapere nostalgico, retorica dell’apocalisse, ecc.) si appoggiano su dichiarazioni di fede. Abbiamo un problema! Bene, come facciamo ad affrontarlo? Con parole amebe. Basta agricoltura intensiva, al bando gli allevamenti industriali, evviva la miseria genuina, sapere antico, contadini di tutto il mondo che si scambiano i semi. Agricoltura sinergica, biodinamica, biologica, quelle pratiche che nascono dal sano rapporto tra uomo e natura. Promesse. Ricette risolutive. Come considerarle? Dichiarazioni di fede? Dovremmo considerarle caso per caso ed analizzare ognuna di esse rigorosamente.
Il fatto è che se siamo pigramente immersi nel modello culturale nostalgico, poi tendiamo a saltare la fase analitica. Troppo allettante la promessa iniziale e ancora più allettante la ricetta finale. Risultato: pigrizia culturale, sterilità. Ci impegniamo poco, culturalmente parlando. Tutta la conoscenza che dovremmo produrre per migliorarci non risulta utile allo scopo. A che serve infatti sforzarci di conoscere questo nostro mondo attuale se, secondo il modello nostalgico, il mondo che aveva valore era quello di un tempo? A che serve se tutto è perduto e il presente è sinonimo di corruzione?
Questo modello fa molti proseliti. Costa poco. È facile capire allora come anche molte trasmissioni di sinistra, appena possono, accolgono con entusiasmo ogni discorso del suddetto tipo. I conduttori ascoltano i compagni bucolici e sembrano contenti: si sentono dalla parte giusta del mondo. La natura, le energie alternative, il piccolo orto, l’organico, il biologico: che meraviglia, il sano rapporto uomo-natura.
Sano rapporto uomo-natura. Ma che significa? Esiste davvero questo sano rapporto, cioè, esiste davvero la natura? Per i creazionisti sì. Per i cattolici anche, ma del resto il cristianesimo ha sfondato a sinistra e tra i ricchi di sinistra. Quanti Rutelli convertiti, quante preghiere mattutine. Quanti monasteri frequentiamo per ritemprarci, quanti priori, abati, missionari pubblicano libri sul pane di ieri o sulla vita in povertà e quante copie si vendono dei loro libri. La natura, prodotto della creazione, esige rispetto per i suoi doni, cogliamoli con discrezione, non ce ne facciamo nemmeno accorgere. Quanti ricchi di sinistra la pensano così. Gli stessi ricchi che fanno corsi di sopravvivenza nella natura selvaggia, prima di tornare in azienda e dirigere con polso duro i dipendenti – a volte come detesto i ricchi.
Per me no, però. Sono laico. La natura è il prodotto di un’equazione, nasce dall’interazione tra noi e l’ambiente. Noi modifichiamo l’ambiente e l’ambiente modifica noi. Il risultato si chiama «natura». La natura è perciò un risultato. È sfuggente, aleatoria, e per questo, per essere definita, ha bisogno di misurazioni, di costante monitoraggio. Ha bisogno di apporti conoscitivi moderni, di manutenzione, appunto. Necessita di essere tenuta a bada. La natura lasciata a se stessa non ci piacerebbe. Non la troveremmo «armonica».
Faccio per dire, ho conosciuto un agricoltore sinergico molto arrabbiato con la modernità, con l’agricoltura convenzionale, gli antiparassitari, le multinazionali, ecc. Mi chiedete cos’è un agricoltore sinergico? Non lo so. So che è diverso dall’agricoltore biodinamico e da quello biologico. Perché? Non lo so, vi dico. Non lo dico io, che è diverso. Lo diceva lui, era contro lo slow food e i biodinamici. Era uno scissionista.
Ho provato a indagare ma sono differenze così minime, sfumature che non saprei riportarvi – ci sono, comunque, dei siti che lo spiegano. Se ci tenete.
Ma non è questo il punto. Il punto è che lui coltivava ventitré metri quadri di terra. Coltivava un fazzoletto di terra grande quanto il mio balcone. Pure io sul mio balcone non uso concimi. È un modello di sviluppo sensato questo? No, è semplicemente un altro aspetto del carattere italiano: il piccolo orto. O meglio, il mio piccolo orto di una volta. Che non è soggetto alla corruzione della modernità. Il mio piccolo orto che può far miracoli. Non perché produca davvero, ma perché in Italia nessuna cosa è foraggiata e finanziata come i piccoli orti.
E qui torniamo al seno di Cristina Del Basso. La mamma italica che ci finanzia con generosità e senza farsi troppo pensiero delle conseguenze del nostro agire. Per questo il forum sul seno di Cristina è così frequentato, tanto che anche «Panorama» ha dedicato una copertina all’evento – meglio la preferenza verso il culo laico, mi verrebbe da dire, non nel senso della fortuna.
Insomma, è un modello di sviluppo serio questo? Un Paese che, per restare in tema agricolo, vede le sue colture gravemente danneggiate da attacchi di insetti, che è in affanno con le esportazioni, che importa il sessanta per cento dei mangimi zootecnici – per non parlare dell’energia –, questo Paese che avrebbe bisogno di un serio piano quinquennale e di investimenti innovativi, un Paese come il nostro che avrebbe bisogno di una costante innovazione, preferisce concentrarsi sui piccoli orti di una volta: la passata di pomodoro.
Prodotti tipici? Mi sembra che nel paniere complessivo dei beni occupino una piccola percentuale: il quattro per cento. E al resto, chi ci pensa? Ricette semplici, quindi. Buone per me che spesso sono pigro e ho poca voglia di muovermi. Sono in buona compagnia. Tutti pigri ma contenti. Appagati dalle belle dichiarazioni di fede, cioè, l’agricoltura biologica, sinergica, biodinamica, i piccoli orti naturali, quelli che fanno miracoli, che aboliscono insetti, producono prodotti sani, ecc.
Ma perché aboliscono gli insetti? E già, perché?
Esempio: piccolo caso di inquinamento biodinamico. Si tratta di un’azienda che coltiva olivi. Un ettaro e mezzo circa, in un’amena zona collinare romana. Il proprietario per preservare la salubrità del suo terreno, o quello che la filosofia biodinamica ritiene essere un terreno salubre, insomma, questo agricoltore si rifiuta di tagliare le malerbe. La natura, sostiene, si autoregola, tanto è vero che il nostro, con rigoroso formalismo teorico, non pota nemmeno gli ulivi che presto sviluppano una chioma disordinata. Con il tempo, dai fossi di scolo, piano piano dapprima i pioppi (che si riproducono per talea, basta un ramo e parte la pianta), poi le ortiche, cominciano a invadere il campo. E si mangiano pezzi di terreno utile. In un terreno così selvaggiamente autoregolato, arrivano anche i rovi che cominciano selvaggiamente ad arrampicarsi sugli olivi.
Ora, a primavera dai rovi nascono dei bei frutti di bosco, more e fragoline, ma, a questo punto, l’agricoltore biodinamico comincia ad avere qualche preoccupazione, i rovi sono così vigorosi che si rischia di non entrare in campo e raccogliere le olive. Decide allora di tagliare i rovi, dimenticandosi quello che aveva detto qualche tempo prima riguardo alla capacità della natura di autoregolarsi. Ma interviene la moglie dell’agricoltore: non è d’accordo. E ci credo! Lei vuole fare la marmellata con i frutti di bosco e nasce così, fra i due, un piccolo dilemma etico: si raccolgono le olive e si sacrificano i frutti di bosco. O viceversa? I due però non fanno in tempo a risolvere il problema che interviene nella contesa un terzo, anzi, terzi. Si tratta dei vicini di azienda. Loro non coltivano biodinamico e vedono il proprio appezzamento riempirsi di erbacce: provengono tutte dal campo biodinamico.
I vicini di azienda fanno storie, va bene il biodinamico ma bisogna perlomeno salvare il decoro e l’ordine. Soprattutto, è necessario bloccare le erbacce che oramai si riproducono con enfasi esponenziale invadendo i campi e ignorando qualsiasi proposito di autoregolazione. L’agricoltore biodinamico non molla. Non ha nessuna intenzione di usare erbicidi che inquinerebbero non solo il terreno ma anche la sua filosofia. Poco male, dicono i suoi vicini, usa la zappa. Nemmeno la zappa però va bene, per una ragione che adesso non ricordo. Fatto sta che i vicini si scocciano di tutta questa storia, chiamano i vigili, si appellano al concetto di buon decoro civico e l’agricoltore biodinamico si vede recapitare una multa dal messo comunale, che ammonta a un centinaio di euro. Niente da fare, l’agricoltore è disposto ad andare fino in fondo, arrivare anche in tribunale per difendere la causa. Del resto, è una causa nobile.
Per questo chiama un agronomo, ha bisogno di una perizia giurata necessaria al ricorso, ma l’agronomo appena vede il campo così combinato lo invita a prendere la zappa. L’agricoltore biodinamico alla fine accetta, prende la zappa e pulisce il campo.
Chissà, a me piacerebbe che avesse tratto una morale: la natura si autoregola anche e soprattutto se nel sistema è presente l’uomo. Ne dubito. Trattasi, infatti, di un pensiero ossessivo che genera moderne illusioni cognitive, quello di pensare che siccome si segue una pratica agronomica detta erroneamente biodinamica o, per altri versi, biologica, gli insetti, le erbacce, ecc., non invadono il campo, in quanto questo è in rapporto armonico con la natura.
Come ha sostenuto recentemente Vandana Shiva in un articolo apparso naturalmente su «Repubblica», nella sua cooperativa biologica, dove i contadini usano ancora il bue per tirare l’aratro, il terreno è sano e gli insetti non ci sono.
Si tratterebbe in questo caso di un’invenzione da Nobel: insetti ed erbacce culturalmente modificati che sanno leggere e riconoscono i buoni propositi e l’animo nobile di Vandana Shiva, e così decidono di cambiare campo e dirigersi verso i terreni di quelli che, con animo meno nobile, usano diserbanti e antiparassitari. In attesa di questa invenzione straordinaria, però, credo ci toccherà usare ancora mezzi rudimentali per difenderci dalla natura che è indubbiamente ignorante, si rifiuta di imparare a riconoscere le nostre buone intenzioni.
Vedete? Alla fine queste soluzioni sono dichiarazioni di fede. Molto semplici da fare. Non costano niente. Il primo atto è la dichiarazione dell’apocalisse, il secondo salta, il terzo è la soluzione. Semplice semplice: come i film per famiglia, arriva l’eroe e risolve il problema.
Ce ne sono tante altre di questo tenore: è biologico, dunque sano e naturale. Ogni tanto ne leggo qualcuna. In agricoltura biologica si usano gli oli bianchi per la lotta contro le cocciniglie. Gli oli bianchi! Capisco la suggestione: rimandano alle beauty farm. È incredibile quanto erotismo emanano certe parole. Solo che quegli oli bianchi sono ricavati dal petrolio. Sempre nel settore fossile siamo. Oppure: il rame che si usa in agricoltura biologica contro alcune crittogame non è mica un metallo pesante che può causare, in dosi eccessive, danni? No, è energia vitale. Energia vitale, capito? Mendeleev e la sua tavola periodica degli elementi non conta. Il rame non fa male perché è energia vitale.
Così mi ha detto un archeoagronomo. Cos’è? Non lo so, ma lavora tanto perché ci sono trasmissioni di sinistra che, appunto, sono brave nel denunciare la cattiva politica perché lì si va sul facile, ma non appena si tratta di affrontare un argomento complesso come quello legato all’agricoltura, be’, allora, si torna al passato, al biologico, all’archeoagronomia.
Fede, retorica, equivoci e così via. Non fa niente, a noi piace finanziare la fede, la retorica. Il nostro otto per mille quo...