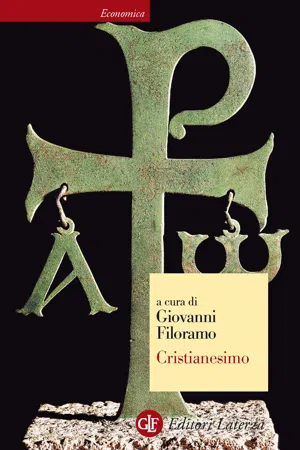
- 626 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Cristianesimo
Informazioni su questo libro
Viviamo, si dice da più parti, in un mondo adulto, una società post-cristiana che ha congedato Dio. Eppure, ancora oggi, i cristiani sono più del trenta per cento della popolazione mondiale e, all'inizio di un nuovo millennio, il cristianesimo si rivela forza sempre capace di incidere sul tessuto delle coscienze individuali e collettive. Questo volume copre l'intero arco della sua storia e ne ripercorre tutte le tappe, dalle origini a oggi.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Il cattolicesimo
dal concilio di Trento al Vaticano II
di Daniele Menozzi
Premessa
È evidente che lo spazio qui disponibile per la ricostruzione della storia del cattolicesimo moderno e contemporaneo non consente una trattazione sistematica ed esauriente di una vicenda che lo sviluppo della ricerca tende continuamente ad arricchire di conoscenze sempre più articolate e profonde, mostrando l’estrema complessità del suo svolgimento. Le pagine che seguono sono perciò il frutto non di un tentativo di inseguire una vana pretesa di completezza, ma di alcune scelte, che è opportuno segnalare preliminarmente. Sul piano tematico si è deciso di privilegiare, accanto alle fondamentali indicazioni sui mutamenti intervenuti nella vita interna dell’istituzione ecclesiastica, l’ottica del rapporto tra chiesa e società: non solo per preferenze e competenze personali, ma anche nell’intento di garantire la massima storicizzazione possibile di una materia in cui hanno ancora largo spazio l’apologetica e la polemica; e, all’interno di questa prospettiva generale, ci si è poi soffermati su quei momenti o quegli aspetti che manifestano il ruolo della chiesa nello svolgimento storico complessivo. Oltre alla necessaria insistenza sul papato, per l’incidenza che nel periodo qui esaminato ha nella definizione degli indirizzi generali della chiesa, a livello geografico si è da un lato posta attenzione sull’ambito italiano e dall’altro lato si sono di volta in volta sottolineate le chiese, i gruppi, gli ambienti, che, in qualunque area operassero, sembravano assumere significativa importanza in ordine al momento considerato. In conformità agli scopi dell’opera si è infine preferito, senza rinunciare del tutto alla discussione, garantire soprattutto una corretta informazione; e, in luogo di rapsodiche note, è parso più utile fornire il riferimento alle fonti principali sul corso dell’esposizione e un’essenziale bibliografia finale.
1. Dai movimenti di riforma ecclesiale al concilio di Trento
1. Le varie declinazioni di un’aspirazione alla riforma «in capite et in membris»
L’esigenza di una riforma morale e istituzionale sia nel vertice romano che nelle articolazioni locali della chiesa aveva trovato varia espressione nell’età del conciliarismo; ma, una volta risolta la crisi del grande scisma d’Occidente, le tendenze al rinnovamento erano rimaste circoscritte ad ambienti ristretti e talora operanti in maniera sotterranea, comunque osteggiati da un papato che, avendo il decreto Haec sancta (1415) del concilio di Costanza strettamente connesso riforma della chiesa e proclamazione della superiorità del concilio sul pontefice, non poteva che guardare con preoccupazione al riaffiorare di tali istanze. In questo contesto il persistere di orientamenti riformistici aveva spesso trovato espressione nella predicazione di carattere profetico, apocalittico e millenaristico di itineranti romiti, che, soprattutto dopo lo sfortunato esito del tentativo savonaroliano (1498), invitavano alla penitenza per sfuggire ai terribili castighi con cui Dio avrebbe provveduto ad avviare l’improcrastinabile rinnovamento collettivo; o alimentavano l’attesa di un «papa angelico», in cui si riponeva la speranza di una complessiva restaurazione della vita religiosa e sociale. Tuttavia all’inizio del Cinquecento si manifestano in diversi settori del mondo cattolico fermenti di trasformazione ecclesiale che assumono una diversa configurazione, anche se non si pongono sul piano di un intervento complessivo sull’istituzione ecclesiastica e sui suoi modi di presenza nella società. Alcuni di essi nascono prima del 1517, allorché Lutero con l’affissione delle sue tesi pone il problema non più solo sul piano morale e disciplinare, ma anche su quello teologico e dottrinale; altri si sviluppano parallelamente allo svolgersi della Riforma protestante, che ben presto si articola in correnti radicalmente differenziate tra loro, intrecciandosi e talora confondendosi con elementi proposti dai riformatori d’Oltralpe; altri ancora si coniugano con quella volontà di riconquista, anche coercitiva ed armata, del protestantesimo e di repressione violenta dell’eterodossia, che viene usualmente definita Controriforma.
Come ha mostrato la ricerca, intensa e vivace, sull’argomento, si tratta di una vicenda particolarmente complessa, fatta di tormentati itinerari individuali, di gruppi compositi dagli incerti collegamenti sociali e geografici, di evoluzioni ed esiti diversificati ed anche contraddittori: è perciò difficile ricorrere a sintetiche e generali categorie interpretative – come Riforma cattolica – che hanno avuto e continuano ancora ad avere largo corso e rigida applicazione nel dibattito storiografico. Risulta invece ancora assai utile far riferimento alla periodizzazione proposta da uno dei massimi storici del periodo, Delio Cantimori (1992), che individua alcune fasi fondamentali nell’ambito più specificatamente italiano, ma che possono avere un più generale valore indicativo. Conviene ora ricordarle sinteticamente, per poi illustrarle in maniera più diffusa. In un primo periodo il movimento di riforma, che, in una situazione complessiva di grande incertezza e fluidità dottrinale, presenta aspetti talora comuni con temi luterani, giunge fino agli inizi degli anni Quaranta. A queste date la morte o la fuga di alcuni protagonisti, l’apertura del Tridentino e la costituzione del Sant’Uffizio segnano un irrigidimento, con l’emergere nella chiesa di personaggi e correnti che puntano al recupero organizzativo e alla repressione delle istanze di riforma attraverso una solidale e compatta azione del potere politico e dell’autorità ecclesiastica: ai loro occhi essa è resa necessaria dall’inevitabile riflettersi del mutamento religioso sul generale assetto sociale con il conseguente pericolo di rovesciamento di tutti i poteri stabiliti. In questo secondo periodo, che si svolge fino all’inizio degli anni Sessanta, è comunque ancora attiva – spesso in una personale ed intima adesione ad alcuni dei princìpi fondamentali della Riforma protestante e talora occupando posizioni di rilievo nella gerarchia – una generazione di riformatori: nonostante fughe, esili, manifestazioni di nicodemismo, essa si propone di giungere ad un compromesso coi protestanti attraverso un moderato rinnovamento ecclesiale. Nel terzo momento la chiusura del concilio tridentino, con l’assunzione da parte del papato dell’applicazione dei suoi decreti in un’ottica di forte accentramento romano, e il saldarsi di un sostanziale (anche se non esente nei suoi termini concreti da scarti e oscillazioni) accordo tra la Santa Sede e le potenze cattoliche nell’opera di restaurazione determinano la sconfitta delle tendenze ireniche e conciliatrici, la fine del movimento di riforma e il trionfo della prospettiva più strettamente controriformistica. Il massacro dei Valdesi insediati tra Calabria e Puglia (1561), in cui collaborarono fianco a fianco il viceré di Napoli e l’Inquisizione, è in qualche modo emblematico dell’aprirsi di questa nuova stagione, che poi vedrà, oltre ad ulteriori stragi, ad esempio la notte di S. Bartolomeo a Parigi (1572), a livello individuale l’invio al supplizio come eretici convinti di alcuni protagonisti del tentativo di rinnovamento.
Nella prima delle fasi cui si è ora accennato le istanze novatrici si presentano con un programma che, pur vario ed articolato, ha come elemento fondamentale l’esigenza di mutare atteggiamenti e comportamenti individuali. Questa linea è ben visibile presso i laici che promuovono la formazione di associazioni, di cui è tipico esempio la Compagnia del divino amore, nata a Genova sullo scorcio del XV secolo, ad opera di E. Vernazza e poi irradiatasi in numerose città italiane, particolarmente, anche se non solo, del Settentrione. La riforma personale che gli aderenti ad essa si propongono trova la sua attuazione in un duplice comportamento: da un lato il perfezionamento spirituale da attuarsi attraverso un approccio diretto e frequente alla Scrittura, l’assiduità alla messa e ai sacramenti, la preghiera; dall’altro lato la cura, spesso compiuta in segreto, di quei bisognosi per i quali la società contemporanea non apprestava strumenti di soccorso, in particolare di quanti venivano di solito rifuggiti perché considerati ripugnanti (appestati e malati di sifilide). Ma il mutamento dello stile di vita del singolo credente viene in alcuni ambienti inserito in una prospettiva più ampia. La riforma individuale appare qui la necessaria premessa di una lenta e graduale estensione di un rinnovamento culturale che investirà tutta la chiesa, fino al suo vertice, il papato. Tuttavia tale trasformazione viene affidata all’operare della Provvidenza, perché il problema cruciale di questi ambienti resta pur sempre quello di garantirsi la salvezza personale. Emblematico della temperie spirituale di questo periodo è il fatto che nel 1511 un nobile veneziano, G. Contarini, avesse avuto quella stessa esperienza di drammatica ricerca interiore della giustificazione e di una sua successiva individuazione nella fede che poi determinerà tutto l’orientamento di Lutero (Turmerlebnis). Comunque a questa più larga linea di rinnovamento si richiama quella corrente del primo Cinquecento, che si è soliti definire col nome di evangelismo, ma che è impossibile inquadrare in schemi rigidi, per la frequente molteplicità e intercambiabilità delle posizioni dei suoi esponenti. Ad essa appartengono gruppi di umanisti cristiani (ben rappresentati da Erasmo da Rotterdam), che si propongono di superare l’arido formalismo teologico della scolastica attraverso il ritorno ad una lettura della Scrittura e dei Padri filologicamente corretta, in modo da purificarla dalle successive superfetazioni. Nel suo alveo operano anche circoli di spirituali – gli alumbrados spagnoli, raccolti attorno ai francescani J. de Olmillos e F. de Ocaña; e quanti fanno riferimento in Italia a J. de Valdés e al cappuccino B. Ochino, in seguito passato al protestantesimo – o gruppi influenzati dagli autori (con ogni probabilità B. Fontanini e M.A. Flaminio) di un libretto dallo straordinario successo editoriale, Il Beneficio di Cristo: al di là della variamente declinata ricerca dell’esperienza mistica, vi è in essi l’assunzione della prospettiva secondo cui la salvezza eterna dipende dai meriti acquisiti dal sacrificio di Cristo più che da quelli conseguibili con opere umane, senza però che questo implichi adesione alla complessiva visione di Lutero o Calvino né alla loro «ribellione». E alla medesima corrente dell’evangelismo si possono infine ricondurre ambienti – come quelli radunati a Meaux attorno a Lefèvre d’Etaples o a Parigi attorno a Margherita di Navarra, ma diffusi in tutta Europa – che si propongono una imitazione di Cristo attraverso il recupero di una religione spirituale ed intima; un culto purificato dalle devozionalità esteriori; comportamenti semplici e fraterni; il ripudio di quelle utilizzazioni a scopi personali del sacro che appariva ai loro occhi blasfema superstizione – un ritorno, insomma, a quell’atteggiamento che con felice e sintetica definizione Erasmo aveva chiamato philosophia Christi.
Le istanze di rinnovamento non rimangono comunque confinate sul piano della trasformazione personale e culturale, ma investono anche le istituzioni ecclesiastiche. Tra il 1512 e il 1517 si teneva a Roma il concilio Lateranense V, voluto da Giulio II per contrastare il tentativo del re di Francia, Luigi XII, di convocare a Pisa un’assise ecumenica nell’intento di mettere in difficoltà politica il papa, che aveva unito i principi italiani contro il sovrano. Ottenuto questo obiettivo immediato, e morto il pontefice, cui succedeva Leone X (1513-1521), l’assemblea affrontava anche alcune delle questioni che travagliavano la chiesa contemporanea. Al suo interno circolarono allora diversi progetti di riforma, tra cui il più famoso è il Libellus ad Leonem X di due nobili veneziani, V. Giustiniani e T. Quirini, che erano entrati in età matura nell’austero ordine eremitico dei camaldolesi. Pur in un quadro complessivo che si richiamava, secondo moduli medievali, al potere teocratico del papa, essi, denunciando l’ignoranza, la...
Indice dei contenuti
- Prefazione
- Dalle origini al concilio di Nicea. di Giorgio Jossa
- Dal concilio di Nicea a Gregorio Magno. di Salvatore Pricoco
- Il cristianesimo medievale in Occidente. di Grado Giovanni Merlo
- Le chiese orientali di Lorenzo Perrone
- La Riforma protestante (1517-1580) di Paolo Ricca
- Il cattolicesimo dal concilio di Trento al Vaticano II di Daniele Menozzi
- Il protestantesimo dalla fine del XVI secolo ai giorni nostri di Fulvio Ferrario
- La chiesa ortodossa di Cesare Alzati
- Le missioni cattoliche di Jacques Gadille
- Le missioni protestanti di Paolo Ricca
- Il movimento ecumenico di Paolo Ricca
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Cristianesimo di Giovanni Filoramo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Storia del cristianesimo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.