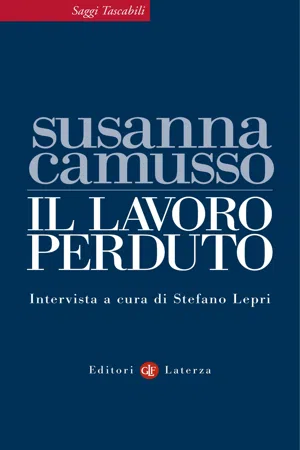1. Quale ruolo, oggi, per il sindacato?
D. Gli italiani oggi hanno poca fiducia nei sindacati. I lavoratori si sentono deboli e divisi, ma non sempre si rivolgono a voi. In passato suscitavate invece grandi speranze oppure grandi timori...
R. Il sindacato, soggetto ideale del lavoro, vive, come tutti i soggetti di rappresentanza, una crisi profonda. Frammentazione del paese, sfiducia diffusa determinano l’idea che nessun soggetto rappresenti e sia in grado di interpretare desideri e bisogni. Le grandi trasformazioni promosse dal movimento dei lavoratori appaiono lontane nel tempo; una stagione difensiva come quella attuale non riesce a trascinare. Il grande rischio che vedo è proprio quello che ci si rassegni all’ineluttabilità della crisi e della divisione, e quindi all’assenza di una prospettiva. Resta comunque vero, però, che molti guardano al sindacato, alla Cgil in particolare, come al soggetto che non rinuncia ad indicare una prospettiva, un orizzonte; non la somma di tanti piccoli interessi, ma un’idea del paese. Se poi ci si riferisce ai sondaggi, da tempo si percepisce uno strano fenomeno in Italia: si tende ad accomunare tutti i soggetti del confronto politico-sociale. Mi succede con una certa regolarità, in diversi luoghi, di ascoltare lavoratori, persone, che mi avvicinano e imputano alla Cgil anche cose che nulla hanno a che fare con la nostra attività, o che magari abbiamo subìto, nel senso che le ha fatte il governo, o sono scelte del Parlamento; oppure, addirittura su materie che proprio non riguardano aspetti sindacali. Credo che questo avvenga per due motivi. In parte si tratta della personalizzazione, ovvero dell’effetto dell’avvicendarsi di tanti volti in tv, senza che si riescano a cogliere le diverse funzioni dei soggetti, ed è uno dei tanti problemi del nostro paese. Dall’altra parte incide la distanza che c’è, almeno nella percezione delle persone, tra dove si sopportano le conseguenze e dove si decide. Nello stesso tempo, occorre anche notare che mentre crolla il consenso di tutti i soggetti, soprattutto dei partiti e del Parlamento, noi almeno nell’ultimo periodo siamo in controtendenza: fino a una decina di anni fa – è bene ricordarlo – rispetto a noi erano i partiti a ricevere maggior gradimento. Una conferma, questa, del bisogno di avere comunque dei punti di riferimento; e immagino che a orientare questo bisogno sia, tra gli altri, soprattutto il tema del lavoro. Altrimenti, dato che come sindacati ci troviamo in una stagione di scarsissimi risultati e molto difensiva, non si spiegherebbe la crescita del consenso nei nostri confronti. Naturalmente tutto ciò ha risvolti diversi a seconda dei casi, perché dove esiste una più solida tradizione sindacale la confusione è minore. Viceversa, dove manca una particolare esperienza, dove il sindacato non è ben conosciuto, ho la sensazione che le persone non sappiano bene chi rappresento. Talvolta, ad esempio, mi sento chiamare «onorevole»; insomma, c’è un insieme magmatico in cui vengono collocati tutti quelli che fanno attività pubblica, quale che sia.
D. Nell’insieme chi appare in televisione, dirigenti sindacali compresi, appartiene a «quelli in alto» di cui si è scontenti. Ma se è così anche per voi, una organizzazione ramificata nel paese, può significare che alla base funzionate poco. A seconda dei sondaggi di opinione l’indice di fiducia nei sindacati va da un minimo del 20% a un massimo del 34%; la Cgil può consolarsi di essere di poco preferita a Cisl e Uil. Perfino tra i lavoratori dipendenti, circa un terzo vi vede in modo negativo.
R. Direi che questo è l’effetto della sensazione diffusa che non si riescano a raggiungere risultati, ovvero che ci sia una perdita di potere, di efficacia, di rappresentanza. Inoltre, credo che la forma della nostra organizzazione non abbia saputo dare sufficienti risposte ai cambiamenti della struttura produttiva. Qui è il nodo. Si è continuato a difendere il nostro modello di sindacalizzazione, quando ormai molto gli sfugge. Forse, si è creduto di porre rimedio con la comunicazione, pensando che fosse sufficiente andare in televisione per essere presenti, anziché provare a organizzare le persone. Facciamo un confronto: quante volte hanno mandato me in televisione, quante volte c’era andato Luciano Lama? Ecco, questa stagione di leaderismo personalizzato sugli schermi non favorisce il contatto con la gente. In Cgil ne abbiamo discusso, abbiamo fatto una conferenza sull’organizzazione; abbiamo progettato di tornare ad ampliare il nostro insediamento territoriale, di far crescere le sedi periferiche, perché ci deve essere un luogo dove le persone possano andare, dove trovare un punto di riferimento. Ma tutto questo non è bastato, e non è tuttora sufficiente a colmare un vuoto che c’è.
Comunque, oggi, tra il sindacato e i partiti c’è una differenza molto importante, su cui vorrei insistere. Nei partiti, anche alla base, prevale un meccanismo di cooptazione, è venuto meno l’insediamento nel territorio, l’adesione partecipativa. Tra noi no: le nostre strutture periferiche sono elettive, dunque più aperte a chi vuole impegnarsi; e abbiamo un forte ricambio di iscritti ogni anno. È vero invece che c’è un problema riguardo ai risultati della nostra azione. Questa carenza è figlia della lunga stagione berlusconiana, che ha chiuso le possibilità di confronto con il governo per la definizione della politica economica.
D. Il calo di fiducia nel sindacato era cominciato già prima. E oggi tra i motivi di protesta che emergono, la solidarietà non svolge un gran ruolo, mentre per i sindacati è essenziale; tanto che la mancanza di solidarietà viene citata dai vostri militanti come primo ostacolo. C’è rabbia tra la gente, c’è rancore, ma poca spinta a unirsi riconoscendo che si condividono bisogni simili. Dove sono finite le grandi speranze?
R. C’è un po’ di tutto. Oggi non ci sono più le grandi fabbriche, non c’è più un livello di confronto centrale con il governo, c’è altro. Sono tutti elementi che alla fine sortiscono il medesimo effetto, ovvero la sensazione che il sindacato non riesca ad essere efficace come i lavoratori vorrebbero che fosse. Diciamo che il Novecento è stato segnato dal processo di conquista della cittadinanza per tutti i lavoratori; io lo riassumo così. Questo processo è stato, ovviamente, lungo. Oggi è difficile immaginare un’idea universale che abbia dimensione, fascino, forza di trascinamento equivalenti. Gli eventi del nostro tempo non appaiono incidere con altrettanta profondità nei rapporti sociali ed economici; la diseguaglianza scompare dal dibattito. Oggi l’unico fenomeno in qualche modo analogo è la conquista della cittadinanza da parte degli immigrati, per la quale ci stiamo impegnando molto; ma si tratta soltanto di estendere a queste persone diritti che altri lavoratori hanno già. Vero è che solidarietà è parola invocata e molto difficile da ritrovare nei comportamenti quotidiani. Questo è l’effetto di anni, tanti, di frammentazione, di divisione, prodotti dal liberismo. Si è propagato e consolidato un egoismo sociale, l’idea che il tuo futuro dipenda esclusivamente da te e colui che hai di fronte sia un potenziale nemico. La ricostruzione dell’idea che c’è un destino collettivo, solidale appunto, può partire solo dalla convinzione che esiste una condizione comune. Questa è la sfida. Quale grande tema attraversa la condizione di tutti più del lavoro? Il lavoro da difendere, da creare, da ricercare?
D. D’accordo, la stagione delle grandi conquiste è terminata con il Novecento. Però qui c’è altro: sempre più, da diverse parti – talvolta anche da esponenti del Partito democratico –, siete percepiti come una forza di conservazione.
R. Il fatto è che secondo alcuni i grandi risultati storici del secolo scorso si dovrebbero disfare. Mi spiego meglio: quando nel dibattito si dà facilmente per scontato che in fondo possiamo dimenticare il Novecento perché vetusto, non si dimenticano soltanto l’Olocausto e le guerre, si dimentica anche la grande conquista della cittadinanza, che rappresentò – e voglio sottolinearlo – anche la conquista della cittadinanza da parte delle donne. Al suffragio davvero universale, ossia esteso alle donne, siamo arrivati solo nel 1946. Insisto sul valore fondante del mutamento di cui stiamo parlando. Molto spesso nella ricostruzione storica si attribuisce alla borghesia la funzione di aver posto le basi della nostra società attuale. Ora è indubbio che la borghesia abbia svolto un ruolo rilevante, anche riguardo alla democrazia; ma in realtà è la cittadinanza dei lavoratori che ha cambiato il fondamento sociale del paese.
D. Ovvero diritto di sciopero, contrattualizzazione del rapporto di lavoro, Stato sociale. Insomma, secondo lei l’articolo 1 della nostra Costituzione – la Repubblica fondata sul lavoro – coglie davvero il punto.
R. Me l’hanno insegnato anche i miei genitori. Entrambi avevano vissuto la guerra e come molti loro coetanei dopo la Liberazione credevano, giustamente, che il lavoro fosse fondamento non solo della nostra società, ma anche dell’esistenza di ognuno. Il lavoro è il luogo dove ci si può esprimere; permette di autodeterminarsi, di essere autonomi, di costruirsi una identità.
D. Tutto questo però non basta a far sì che i lavoratori si uniscano. Oggi, nel XXI secolo, esistono tanti tipi di lavoro, diversissimi tra loro. Non si tratta più di soddisfare bisogni e diritti primari. Qual è la molla della solidarietà?
R. Durante lo straordinario processo di trasformazione del Novecento sono cambiate anche le figure al centro del movimento sindacale. Prima ci sono stati i braccianti, poi l’operaio della catena di montaggio. Allora ci si aggregava attorno a una figura centrale. Oggi il mondo del lavoro è più diversificato, più vario: in Italia abbiamo fra i 3 e i 4 milioni di lavoratori industriali, 4 milioni di lavoratori del commercio e dei servizi, dai 3 ai 4 milioni di dipendenti pubblici, un milione di edili. Nel Novecento, si erano posti via via dei mattoni che si davano per acquisiti e consolidati; benché non sia né così vero né così scontato che siano acquisiti e consolidati. Oggi anche il movimento sindacale – come peraltro l’intera società – deve misurarsi con il fatto che conquiste di quelle dimensioni non sono prevedibili né immaginabili, ma neppure sono sostituibili. Mentre nel passato si indicavano grandi traguardi, oggi il sindacato si trova da un lato a dover difendere ciò che viene posto in discussione, e dall’altro deve immaginarsi come accompagnare una trasformazione di cui non è chiaro l’orizzonte.
D. Per un certo periodo era di moda pensare che il lavoro manuale sarebbe scomparso, almeno nei paesi avanzati. Ora si è capito che questo vale soltanto per alcuni lavori manuali, per altri no. Nello stesso tempo è molto difficile presentare i problemi del lavoro come un tutto unico, dentro il quale si giustifica la solidarietà. Tanto per cominciare, c’è il dualismo tra precari e fissi...
R. Di dualità me ne vengono in mente tante, di cui forse quella del mercato del lavoro è la più facile da individuare e affrontare, perché le altre sono più profonde. C’è la dualità tra italiani ed immigrati, o tra nativi e migranti per meglio dire. C’è la dualità, inedita, prodotta dalla maggiore durata della vita. Durante la stagione delle grandi conquiste sindacali i sessantenni erano pochi, mentre oggi ci misuriamo col tema degli ottantenni. Tornando alla dualità nel mercato del lavoro troppo facilmente si vuole interpretarla come dualità tra giovani e adulti; vero è che non si sa più quando si diventa adulti. In ogni caso, il circuito della precarietà non è solo giovanile, è un circuito parallelo che riguarda tutte le fasce di lavoratori: si pone qui la questione che chiamo del «lavoro povero». Non parlo soltanto di immigrati, attenzione. Il lavoro che non è pagato abbastanza non riguarda solamente gli immigrati. Nell’Italia in cui abbiamo vissuto fino a ieri, lavoro e povertà erano incompatibili. Il superamento dell’Ottocento fu anche questo. Negli anni delle conquiste il lavoro garantiva una vita dignitosa, oggi non è più così. Quindi è nata una divisione del tutto inedita, un nuovo proletariato, per usare le categorie classiche. E questa componente può anche confliggere con un’altra parte del lavoro; non automaticamente con l’impresa, ma con altri lavoratori.
D. Ridare dignità al lavoro appare, in astratto, una parola d’ordine unificante per il sindacato. Si riallaccia alle sue tradizioni, all’orgoglio del lavoratore. In concreto, quale attrattiva può avere oggi? Spesso il sindacato, specie in alcune sue parti, viene accusato di tutelare il contrario, la pigrizia, la sciatteria nello svolgere le proprie mansioni.
R. Avverto un forte bisogno di etica pubblica. Innanzitutto occorre averla nei comportamenti: chi è sulla scena pubblica, chi occupa un posto di responsabilità, ha il dovere di tenere un comportamento etico. Per tutti noi, penso che il grande traguardo di oggi sia un paese onesto, sentirci parte di un paese a legalità certa. È un bisogno che riscontro in tante piccole cose. Ho visto, ad esempio, le persone in fila per pagare l’Imu, e protestavano dicendo che si erano ridotte a fare le code dell’ultimo giorno perché solo all’ultimo erano riuscite a mettere insieme i soldi, contestavano i molti aspetti iniqui che questa imposta – per come è fatta – mi pare abbia; però dicevano anche che a tutti tocca fare dei sacrifici per salvare il paese. Ecco, secondo me l’idea di salvare il paese è una idea che fa breccia e costruisce consenso.
In questo ho visto un cambiamento positivo del governo Monti, benché lo ritenga un governo conservatore. Cose del genere non avvenivano affatto con il governo Berlusconi. Al di là della condivisione o meno delle singole misure adottate – personalmente ritengo che in molti casi la strada scelta da Monti sia sbagliata – si è ritrovata una dimensione collettiva del paese che da tempo si era persa; anzi, il governo precedente incoraggiava e lavorava per la divisione tra i soggetti. Alla domanda a che cosa serva il sindacato oggi, rispondo così: ancora ed esattamente a organizzare il lavoro, a chiedere lavoro e a rappresentarlo, ad indicare che è il grande assente; anzi, il grande negato dalle ex politiche liberiste come da quelle del «rigore».
D. Se parliamo di ritrovare uno spirito collettivo del paese, vuol dire che il concetto di lotta di classe è ormai da archiviare. Eppure c’è chi sostiene che la lotta di classe non è mai finita: lo scrive Luciano Gallino, in un libro recente che ha avuto un certo successo.
R. Di sicuro la lotta di classe oggi non è – e non può essere – quella del passato. Questo perché il luogo dove si scontrano gli interessi, anche per come è ormai strutturato l’apparato produttivo nel nostro paese, non è più soltanto quello classico tra lavoratori e imprese. Mi sento di dire che dal punto di vista dei lavoratori una parte delle imprese sta dalla parte del lavoro: sono quelle che tentano di salvare il lavoro. Poi c’è la Fiat che adotta un modello di comportamento del tutto diverso. Ma non è sufficiente a identificare il mondo del lavoro come diviso tra lavoratori e imprese. Peraltro mi pareva bizzarro, per usare un eufemismo, che il ministro del Welfare nel governo Berlusconi invitasse alla «complicità» tra imprenditori e lavoratori. O sei complice o sei fuori da tutto, pareva dire. La parola complicità si usa per i reati, o nei rapporti affettivi. Il sindacato costruisce accordi e mediazioni, non fa il complice di nessuno. Ecco, per sintetizzare: di recente il presidente della Confindustria Giorgio Squinzi ha detto che in una situazione come quella attuale lavoratori e imprese sono sulla stessa barca. Non direi, anche perché sulla barca del modello Fiat di Sergio Marchionne non si può proprio stare. È vero, però, che ci sono interessi comuni del lavoro e della produzione, a partire dalla necessità di una politica industriale.
D. In effetti, una qualche complicità tra sindacati e imprese si è vista, per esodi, prepensionamenti ed altro. Insomma, non si può più parlare di lotta di classe?
R. Non direi questo, perché non credo che le divisioni di classe siano scomparse. Dico che quella impostazione storica molto ideologizzata in rigidi termini marxisti oggi non funziona, non descrive più la realtà, anche perché non contempla l’esistenza di una classe media e ignora altre contraddizioni. Nei fatti la questione dell’unicità di classe del lavoro l’abbiamo superata da tempo, proprio ragionando del lavoro e della sua complessità; altrimenti non avremmo un sindacato dei dipendenti bancari, tanto per fare un esempio. Ma aveva ancora il suo peso, nella Cgil, quando si discusse a lungo se costituire o no un sindacato degli insegnanti (che poi si formò nel 1967). Era un argomento controverso perché gli insegnanti venivano percepiti come qualcosa di diverso dai lavoratori, soprattutto manuali. Certo, nella visione classista c’era il vantaggio di una figura comune in cui tutti potevano identificarsi. Avveniva lo stesso anche nella politica: penso al Partito socialista di un secolo fa e più, la cui base erano i braccianti; o al Partito comunista e all’iconografia del lavoro operaio. Poi la mobilità sociale che c’è stata in Italia – oggi è proprio la sua mancanza che fa tornare attuali le divisioni di classe – ha cambiato profondamente le cose. Attualmente è difficile ridurre a una figura unica la complessità del mondo del lavoro. La figura, o le figure, di riferimento del lavoro rappresentano per l’appunto la grande sfida per il sindacato.
D. Dove passa allora per voi il confine tra alleati e avversari, oggi?
R. Detto brutalmente, c’è una società divisa tra chi paga i conti e chi approfitta della situazione. Questa è la dimensione in cui dobbiamo collocarci come sindacato. In questa dimensione, che conferma ancora una volta la disponibilità del mondo del lavoro a fare la propria parte di sacrifici per il futuro del paese purché non siano solo i lavoratori a farne, ma che, giustamente, richiede eguaglianza, la vicenda d...