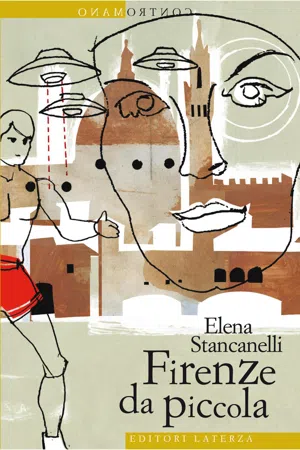
- 172 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Firenze da piccola
Informazioni su questo libro
Piazzale Michelangelo e il David, le Cascine, il concerto di Lou Reed e le puttane, diquaddarno e dilàddarno, il ventre caldo della biblioteca Marucelliana e i Canti orfici di Campana, il caffè delle Giubbe Rosse e Tondelli, il Mac Donald a due passi dalla chiesa di Orsanmichele, Footlocker in pieno centro storico, il tratto di Lungarno appaltato allambasciata americana. Vivere a Firenze è unarte complicata: la città sfida chi la abita a mescolare quotidiano ed eccezionale, giorno dopo giorno.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
Crescita personaleCategoria
ViaggiDiquaddarno
1 www.psicosi.it
Quando ero piccola volevo esserci sempre.
Nella testa dei bambini, grazie a un innato istinto di sopravvivenza, si forma subito il pensiero dell’abbandono. Per questo non dormono, si disperano se lasciati in una stanza da soli. Sanno di essere appesi a un unico chiodo sospeso sul nulla, e quel chiodo sono i genitori. E ci si aggrappano con tutta la loro forza.
Senza la ragnatela di relazioni, impegni, progetti dell’età adulta, dentro la quale poi finiamo prigionieri e dalla quale passiamo il resto della vita a volerci svincolare, siamo niente. È quell’inferno ingestibile delle responsabilità che ci garantisce di essere vivi, che testimonia la nostra esistenza. Memoria e affetto, rancori, desiderio, interessi. Le persone e le cose, amici, amori, compagni di classe, il dentista, la maestra di yoga, il pusher, la donna delle pulizie, la signora da cui facciamo le pulizie, il meccanico e poi contratti, fatture, bolli, ricevute, Sms, tabulati, impegnative, assegni, post-it, badges dei congressi, messaggi in segreteria, targhe della macchina, prenotazioni alberghiere, tessere di palestre, indirizzi email, fotografie.
La vita degli adulti può essere verificata da centinaia di controlli incrociati. Ma se i genitori si scordano di un figlio o lo perdono, quel figlio scompare, viene inghiottito nell’orrorifico indistinto dell’esistenza senza nome, bestiale.
Non sono scemi i bambini. Sanno di essere in pericolo, per questo vorrebbero esserci sempre e piangono e si disperano prima di addormentarsi. Ma anche quando i genitori escono di casa senza di loro, o se vengono esclusi da una conversazione, o semplicemente lasciati dietro una porta chiusa.
O almeno era così negli anni sessanta, quando io ero bambina. Adesso che siedono a tavola con i grandi e li seguono quasi ovunque, i bambini hanno nevrosi più raffinate. Tutti abbiamo nevrosi più raffinate rispetto agli anni sessanta. C’è un sito – ce ne saranno molti, ma questo si chiama proprio www.psicosi.it – dove se ne presenta un repertorio.
Le lettere dei ciber-pazienti su www.psicosi.it ribadiscono ciò che l’esperienza di chiunque di noi aveva già intuito: chi soffre, nell’epoca delle separazioni seriali, soffre soprattutto per amore. «Che cos’è questo modo vertiginoso, angosciante, depravato / Di affrontare la vita formando e distruggendo coppie» si chiede Rodrigo García, drammaturgo argentino, in un testo intitolato significativamente Il bello degli animali è che ti vogliono bene senza chiedere niente.
Le nostre nevrosi si nutrono della sciagurata disorganizzazione sentimentale di questi anni. Forse, quando abbiamo deciso che separarsi è lecito, avremmo dovuto pensare a cosa fare di quella libertà ottenuta. Limitarsi, come facciamo adesso, a cercare di ridarla indietro in cambio di un nuovo vincolo, prima possibile, come una palla avvelenata, forse non è la migliore soluzione. Dal punto di vista della salute mentale, voglio dire. Della morale non mi intendo e non mi immischio.
Ma questo succede adesso. Allora, al tempo in cui Gino Bramieri faceva la pubblicità delle ciotolone colorate di moplèn e io abitavo in via Arnolfo, in una casa sotto le cui finestre l’Arno sarebbe scrosciato portandosi via le macchine parcheggiate e tutto quello che tenevamo in cantina, noi bambini eravamo più bambini di adesso. Eravamo in un certo senso i primi veri bambini, i bambini prototipo. La nascente società del consumo era a caccia di quelli che sarebbero diventati i «target». Tra questi, ancora incerti sulle gambine da compratori, c’eravamo noi, la nuova gigantesca risorsa del mercato. Squaletti nani, pronti a spalancare le fauci per inghiottire prodotti. Bastava trovare il punto dove stimolarci e saremmo presto stati in grado di influenzare con i nostri desideri le scelte dei genitori, persino su cibi e automobili.
Negli anni sessanta, mentre nella testa dei creativi della Nintendo si formava l’immagine embrionale del bambino coi genitori lavoratori e i pollici sviluppatissimi, io e mio fratello eravamo in camera nostra, a giocare ignari a Subbuteo o con il camper di Barbie.
Per noi, bambini in fase sperimentale, non c’era ancora una produzione fascinosa di abiti e dolciumi. Vestivamo come nanetti. Niente scarpe da ginnastica se non per fare ginnastica, e per coprirsi cappotti come quello del nonno ma di taglia piccola. C’erano gli smarties, e certe gomme da masticare lunghe e sottili, tipo calzascarpe piatto, giallognole e incartate nella carta verde trasparente, o rossa. Altre erano rosa a carro armato, morbidissime, ma se invecchiavano nei bar si coprivano di una equivoca patina bianca, diventavano rigide e si spezzavano. C’era la spuma, la coca-cola (della cui caffeina i nostri genitori pre-salutisti non si preoccupavano molto) e l’aranciata. Per Carnevale, ci vestivamo da olandesina, zorro, pirata, pulcinella, fata, moschettiere, cappuccetto rosso. Niente supereroi o cartoni animati. Nell’asilo dei miei nipoti quest’anno ho visto due Teletubbies (Laa-Laa e Tinky Winky), Tigro, l’amico di Winnie the Pooh, qualche Power Ranger e altra gente della quale io ignoravo l’identità. Le nostre maschere erano antiche, uguali a quelle dei nostri genitori. Spesso erano addirittura proprio quelle dei nostri genitori. Io, per esempio, conquistai il mio vestito da fata alla soglia dell’adolescenza. Brandii la mia bacchetta magica un istante prima di cominciare a vergognarmene. Perché per tutti gli anni in cui mi corrispose come taglia, dovetti indossare invece un filologico costume da bavarese, un’eredità della famiglia di mio padre (siciliana). Non fu divertente. Non mi piacque affatto dover rispondere alla domanda: da cosa sei vestita? E più ancora sapere che stavo indossando un costume senza alcun dubbio concepito per un maschio. A tre anni l’identità di genere è vispa e del tutto sprovvista di ironia.

2 i giardinetti
Dopo via Arnolfo ci trasferimmo nella prima delle due case di via dei Della Robbia. Indirizzo che mi dava molto da pensare, a livello di preposizioni articolate. Avrei preferito senz’altro vivere in via Della Robbia, variante neanche tanto peregrina essendo la robbia una pianta dalle cui radici si ricava una polvere usata per colorare le pelli e le stoffe di rosso, polvere il cui commercio è all’origine della fortuna della famiglia di ceramisti in questione, i Della Robbia.
Sfido infatti qualsiasi bambino di tre anni a dire «deidellarobbia» senza inciampare. Avevo però ideato uno stratagemma. Alla domanda dove abiti rispondevo in «viadeidella» e poi, staccato, «robbia». Mi veniva più facile, ma ovviamente non significava niente. Sillabato in questo modo, il mio indirizzo diventava una filastrocca senza senso. Era come avessi risposto che abitavo in via trullallero, in piazza perepepè. Odiavo quell’indirizzo che mi metteva nelle condizioni di essere considerata una bambina scema, che non sa quel che dice. Che poi era vero. Cos’era questa robbia, e deidella era forse un nome proprio?
Sarebbe stato molto più generoso, da parte dell’amministrazione comunale, intitolare una via a Luca, una ad Andrea, a Giovanni, a Girolamo... un bel reticolato di strade per tutta la famiglia. E non solo per rendere la mia infanzia più serena. Non avrei infatti avuto nessuna difficoltà a rispondere che abitavo in via Luca Della Robbia, dal momento che nelle classi a Firenze non mancano mai un paio di nobilucci, sia pure di basso lignaggio. In città, tutti abbiamo molta confidenza con dei o del o della. Almeno l’avevamo negli anni sessanta. Forse adesso i rapporti sono diversi. I nobili e nobiletti naturalmente fanno meno figli e le loro preposizioni articolate saranno state fagocitate da un appello di Chung, Ajatashatru, Krystzof, Mutu, Pablo... Presto saranno loro a dare i nomi alle nostre strade, e allora sì che saranno guai per i bambini. Ma forse i nuovi bambini cresceranno con una consapevolezza linguistica migliore della nostra. Saranno facilitati dal contatto fin da piccoli con tanti accenti, tanto impaccio nel pronunciare le parole che produrrà una lingua nuova, più viva e allegra.
Là intorno, comunque, ci sarebbero stati benissimo tutti quanti i Della Robbia. Tra Donatello, Giambologna, Masaccio, Andrea del Castagno e addirittura via degli Artisti, se a qualcuno non fosse ancora chiaro di cosa stiamo parlando. Il quartiere a est di piazza Donatello è infatti per gran parte occupato da vecchi studi di pittori, soprattutto nella zona compresa tra via Masaccio e piazza Savonarola. Piazza che, pur ospitando una statua del fratacchione, non fu il luogo del suo martirio. La pira sulla quale fu arso il 23 maggio 1498 era stata eretta infatti in piazza della Signoria, e un disco di granito incastonato a terra, vicino alla statua di Cosimo I, identifica il luogo esatto. Più o meno nello stesso posto dove soltanto un anno prima, l’ultimo giorno del Carnevale del 1497, il furibondo Savonarola aveva fatto ammucchiare barbe, maschere e nasi finti, libri licenziosi tra i quali il Decameron e il Morgante del Pulci (oltre che rarissimi manoscritti e preziose pergamene), specchi, acconciature e trabiccoli da donna, liuti, arpe, scacchiere, carte da gioco e infine ritratti di donne celebri per la loro bellezza, da Cleopatra ad allegre signore dei suoi tempi. E poi gli aveva dato fuoco. Chissà se mentre il fumo gli saliva agli occhi e le fiamme gli lambivano i piedi ha maledetto la sua intransigenza e l’ironia del destino.
Sulla piazza Savonarola, alla destra della chiesa, c’è un palazzo, con grandi vetrate affacciate sulla strada, evidentemente uno studio di artista. L’edificio potrebbe essere ottocentesco, ma non si sa. Di certo la facciata è stata ricostruita intorno al 1910, su progetto dell’architetto Enrico Lusini. L’artista Rinaldo Carnielo, nato a Treviso, sembra vi si fosse trasferito verso la fine dell’ottocento. Il palazzo è su due piani, ma la parte centrale è sovrastata ulteriormente da una specie di timpano, illuminato da un finestrone tripartito, enorme e decorato da ghirlande. Ha un’aria austera ma occhieggiante al Liberty, secondo le regole della stagione modernista. Sulla piazza, alle estremità delle due ali, si aprono i due ingressi laterali, con sopra un finestrone quadrato. Al primo piano c’è un cartiglio con la scritta «Onorate l’arte che è vita della vita». Sopra l’ingresso centrale, un architrave regge un’iscrizione in bronzo: «Non omnis moriar». Non tutto morirà.
Quando ero bambina, la tata mi portava in questa piazza, insieme a mio fratello. Questa pratica veniva da noi chiamata «andare ai giardinetti». Chissà se era una specie di lessico familiare o tutti i figli andavano «ai giardinetti». Del resto a casa non c’era niente da fare, nei pomeriggi degli anni sessanta. La televisione, ancora nell’austero bianco e nero, funzionava in maniera diversa da adesso. Per esempio aveva degli orari. Come il cinema, o la scuola, la televisione iniziava a una certa ora e dopo una certa ora finiva. Se ti capitava di avere un attacco di ansia la notte alle quattro, o un vuoto di immaginazione in tarda mattinata, una crisi di solitudine prima di pranzo, non potevi contare sul magico scatolone colorato. Fino alle ore in cui partiva la sigla con le nuvole e il traliccio, il televisore se ne stava tranquillo e nero nel bel mezzo del salotto, impossibilitato a reagire a qualsiasi provocazione del nostro umore. Fin quando non calava il buio, taceva, come il telefono nelle giornate tristi, quando il mondo si dimentica di te.
Già, chissà come accade. Per me, ad esempio, è il mercoledì. Ci ho fatto caso. Non capisco per quale motivo, l’unica specialità del mercoledì è infatti quella di stare grosso modo al centro della settimana, ma è poco per fare di lui un giorno funesto. Il mercoledì di solito il mio telefono tace a lungo. Spesso per tutta la giornata. Se sono con qualcuno, ogni tanto lo tiro fuori dalla tasca e lo guardo di sfuggita, fingendo di voler controllare l’ora. A volte penso che è per questo che non porto più l’orologio, per avere la scusa di controllare di sfuggita il telefonino il mercoledì. Mi illudo di non aver sentito la suoneria, l’avviso di entrata di un Sms. Brutta storia i telefonini. Non serve a niente lasciarli a casa, perché del loro pensiero non ti liberi lo stesso. Bisognerebbe semplicemente che non fossero stati inventati.
O anche smettere di contare sull’attenzione degli altri per avere certezza della nostra esistenza.
3 Galleria Rinaldo Carnielo
La Galleria Rinaldo Carnielo ha sede nell’edificio di piazza Savonarola dove l’artista visse e lavorò. È aperta il sabato dalle nove alle tredici, e basta. C’è un bel gonfalone rosso che lo annuncia, uguale in tutto e per tutto ai tanti gonfaloni che, appesi ai muri in giro per la città, segnalano la presenza di un museo, di un luogo di interesse storico. Decine, centinaia. Ogni tanto verrebbe voglia di operare in maniera contraria, e, anziché storicizzare una bottega trasformandola in un museo, ritrasformare certi musei in botteghe, negozi, abitazioni. Semplici edifici della vita quotidiana. Giusto per non aver sempre paura di dove si mettono i piedi. So che sembra incredibile, ma a Firenze non esistono le pizzerie al taglio. Ci sono i McDonald’s, l’inaugurazione dei quali ha suscitato il consueto scandalo, ci sono paninifici in tutte le declinazioni possibili, ma se vuoi mangiarti un pezzo di pizza, al centro, ti devi mettere seduto a un tavolo.
Detto così sembra quasi bello, ma non è normale. Non è che io voglia fare una crociata per la pizza al taglio. Trovo anch’io, come tutti, che quelle teglie coi carciofini intirizziti e la fetta di prosciutto imbarcata siano struggenti. Per non parlare di quando te la scaldano, e la pasta si insecchisce tutta, la mozzarella ti buca il dorso della mano come piombo fuso. Ma la pizza è un indice. Nel mercato dello spuntino, a Firenze, siamo fermi agli anni sessanta. Escluso McDonald’s, che non chiede permesso ma è stato catapultato nel mondo imbottito di dollaroni. Le novità sono state tutte bloccate da sentinelle isteriche al checkpoint di chissà cosa.
Perché Firenze ha un rapporto letterale con le sue risorse. Come la famiglia Della Robbia. Fosse nato un figlio, o un nipote, sprovvisto del minimo talento, sarebbe stato comunque destinato a mescolar polveri, a cuocere formine. Nessuna possibilità di scampare alla ceramica.
Così la città. Non sa sfruttare il patrimonio che ha a disposizione. Se i turisti hanno fame, la città gli dà un panino. Come nelle colonie estive, o nelle scuole elementari quando c’erano ancora i poveri. Sarebbe...
Indice dei contenuti
- — dedica
- — epigrafe
- Se io resterò più a lungo nella grotta
- Diquaddarno
- Diladdarno
- Materiali
- Ringraziamenti
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Firenze da piccola di Elena Stancanelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Crescita personale e Viaggi. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.