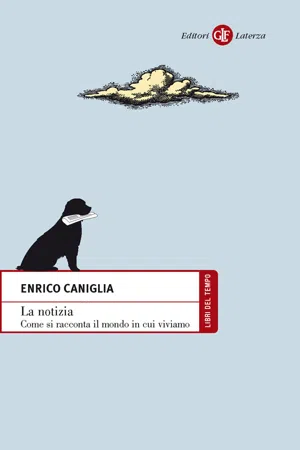1. Comprendere le notizie
L’etnometodologia e l’analisi dei testi
L’etnometodologia è un approccio sociologico di tipo empirico-naturalistico incentrato sullo studio delle pratiche con cui sono portate avanti le diverse attività sociali sia nella vita quotidiana che negli ambiti professionali e istituzionali. In particolare, al centro dell’interesse dell’etnometodologia è lo studio delle pratiche relative alla produzione del significato socialmente condiviso. Secondo gli etnometodologi, noi tutti facciamo riferimento a un insieme comune di competenze, assunti e metodi, da cui deriva per l’appunto il termine “etnometodologia”, ovvero lo studio dei metodi della gente (etno-metodi) con i quali si conferisce un ordine di senso alle attività sociali. Tale insieme stratificato di competenze, risorse e metodi costituisce il senso comune, ed è proprio questo l’oggetto principale dell’analisi etnometodologica. Rispetto all’espressione “senso comune” occorre subito fare una precisazione. Nel significato prevalente, per “senso comune” si intende una serie di conoscenze, rappresentazioni o credenze, spesso errate, socialmente diffuse. Per l’etnometodologia, invece, il senso comune non è soltanto costituito da conoscenze condivise, ma anche da un insieme di metodi, procedure, competenze e ragionamenti pratici condivisi dai membri di una medesima società. In altre parole, nell’accezione etnometodologica, il senso comune non è soltanto un sapere, cioè un insieme di conoscenze, quanto e soprattutto un saper fare: ad esempio, saper usare il linguaggio naturale (mastery of natural language) in modo da attribuire un senso a cosa scriviamo, a cosa leggiamo o quando parliamo (Garfinkel e Sacks 1986).
Il linguaggio naturale è al centro dell’interesse etnometodologico. Per linguaggio naturale si intende il linguaggio usato nella vita quotidiana, contrapposto al linguaggio come sistema astratto che è invece l’oggetto della linguistica. Occorre subito precisare che l’etnometodologia non analizza il linguaggio nei suoi aspetti sintattici o morfologici, e neanche intende lo studio del linguaggio come studio del lessico, ovvero le “parole” analizzate dal punto di vista della loro chiarezza, del loro valore estetico, della loro ricorrenza, del loro registro tecnico-specialistico etc. Al contrario, l’etnometodologia studia le azioni che vengono realizzate nel e attraverso il linguaggio. L’etnometodologia rifiuta il presupposto convenzionale, ancora largamente diffuso tra sociologi e linguisti, secondo cui il linguaggio è essenzialmente una risorsa simbolica che serve per rappresentare o per denominare i fenomeni sociali. Al contrario, per l’etnometodologia il linguaggio è un modo per fare qualcosa e non solo per dire qualcosa. Tale concezione distingue l’etnometodologia non solo dalla linguistica e dalla sociolinguistica, ma anche dai prevalenti approcci comunicativi. L’impostazione tradizionale degli studi comunicativi intende il linguaggio esclusivamente come uno strumento per trasmettere o comunicare informazioni. La nota “metafora del canale” di Shannon e Weaver prevede una fonte che immette un messaggio in un canale e in questo modo lo invia a un destinatario. In tale schema, il linguaggio è un canale di trasmissione del messaggio: tramite un codice un messaggio viene inserito in parole, frasi o enunciati, e per questa via spedito a un destinatario. Per contro, l’etnometodologia assume il linguaggio come un mezzo per compiere azioni piuttosto che come semplice “canale di trasmissione”. Nella vita di tutti i giorni, sia professionale sia ordinaria, noi usiamo il linguaggio non solo come un mezzo per veicolare significati, ma anche e soprattutto come uno strumento per compiere una serie particolare di azioni, come fare una descrizione, fornire una spiegazione o fare un’interpretazione.
Applicata al giornalismo, la metafora del canale ha il grosso limite di far immaginare che l’attività giornalistica consista meramente nel comunicare, insomma nel trasmettere qualcosa (la notizia) a qualcuno (cfr. Roidi 2009). L’approccio etnometodologico permette, invece, di porre in evidenza come il lavoro giornalistico non si limiti al “comunicare informazioni”, ma consista nella realizzazione di una serie di azioni, come il descrivere, lo spiegare, l’interpretare, il commentare e il raccontare gli eventi. In particolare, l’etnometodologia è interessata al come – con quali pratiche, risorse, metodi e competenze – i giornalisti usano il linguaggio per fare tutto ciò all’interno delle notizie.
Inizialmente, l’etnometodologia si è concentrata sull’analisi della conversazione ordinaria, per poi spostare i propri interessi alle interazioni verbali che avvengono in contesti istituzionali: attività di laboratorio, interrogatori nei tribunali, interviste giornalistiche, visite mediche, lezioni universitarie e tanto altro ancora. Col tempo i suoi interessi si sono progressivamente estesi oltre la sfera dell’interazione sociale. In particolare, alcuni filoni di ricerca si sono occupati di testi scritti (Schenkein 1979; McHoul 1982; Jayyusi 1991b; Smith 1993; Livingston 1996; Watson 1998). Riguardo ai testi scritti, la loro pervasiva presenza nella vita sociale ne dimostra la straordinaria rilevanza. Per l’etnometodologia, il nostro mondo è organizzato attraverso le parole, anzi è “fatto di parole” (worded entity):
non solo libri, ma tatuaggi, biglietti dell’autobus, assegni circolari, insegne stradali, indicazioni dell’orario sugli orologi, orari ferroviari, titoli di programmi televisivi, epigrammi sulle magliette, passaporti, pagine di quotidiani e di settimanali, tastiere del computer, biglietti di auguri, certificati di nascita e di matrimonio, schede elettorali, carte di credito, diplomi di laurea, ricette mediche, appunti di lezioni, insegne dei negozi, istruzioni per uso di elettrodomestici, slides etc. Solo questi pochi esempi ci danno l’idea del carattere pervasivo della scrittura nella nostra società (Watson 1998, 80).
Per l’etnometodologia, i testi non sono da intendere come un mero insieme di segni inerti su una pagina, ma sono “fenomeni sociali”. I testi sono fenomeni sociali perché ogni attività sociale possiede i suoi aspetti testuali: lo svolgimento di un’attività sociale coinvolge spesso l’uso, la lettura di testi o l’ascolto di testi pronunciati. Inoltre, molti fenomeni sociali sono fatti esclusivamente di parole. Per questa ragione è sbagliato immaginare le “parole” come qualcosa di distinto dalle “cose”. In realtà, le parole non sono qualcosa che “sta per” i fenomeni reali, ma sono di per sé dei fenomeni reali. La notizia, ad esempio, è un fenomeno sociale che è fatto di e con le parole. Negli approcci sociologici convenzionali, il testo di una notizia è visto come un mero canale passivo e trasparente che permette al lettore di accedere a un fenomeno che “sta oltre” quel testo, insomma un fenomeno che sta nel mondo reale, sia esso un incidente ferroviario o l’elezione di un presidente. Contro questa visione, l’etnometodologia ha contrapposto il concetto di testo attivo: il testo è qualcosa di attivo perché compie un’azione o organizza un’attività (Smith 1993). Ad esempio, i titoli e gli articoli dei giornali sono testi attivi perché svolgono l’attività di trasformare i “fatti del mondo” in “storie nelle notizie”.
L’idea diffusa che i testi, come un cartello su cui è scritto “Vietato fumare”, siano entità passive dipende soprattutto dal fatto che il loro significato ci appare immediato e autoevidente. Ma per l’etnometodologia è proprio questo l’aspetto fondamentale di tutta la faccenda, ciò che va indagato: come è possibile che un testo ci appaia autoevidente e trasparente? Come è che riusciamo a cogliere il suo significato in modo tanto ovvio e naturale? Nelle analisi convenzionali, la comprensibilità di un testo è vista unicamente come il risultato dell’applicazione delle regole sintattico-lessicali della lingua, così come ci spiegano i linguisti: se noi comprendiamo un testo giornalistico è perché conosciamo la lingua italiana. Ma le conoscenze sintattico-lessicali della lingua sono solo una delle competenze necessarie. L’etnometodologia intende dimostrare come la pratica della lettura-ascolto di un testo mediatico sia il prodotto del concorso di una più ampia gamma di competenze e di risorse socialmente condivise. La stessa riflessione vale anche per l’elaborazione di un testo. Le competenze che guidano la redazione di un testo non sono solo quelle relative alla conoscenza sintattico-lessicale della lingua, ma la sua “leggibilità-comprensibilità” è realizzata attraverso il concorso di una più diversificata serie di competenze e risorse socialmente condivise. L’etnometodologia è interessata a scoprire queste competenze e queste risorse.
La questione della comprensibilità dei testi giornalistici è sempre stata oggetto di attenzione da parte degli stessi giornalisti che riflettono sul lavoro dell’informazione. Purtroppo, le loro analisi sono viziate dal prevalere di un’immagine tradizionale del linguaggio inteso come un insieme di “parole” e di “frasi” in cui il significato è ridotto a un problema morfologico, sintattico o di scelte lessicali, per cui la riflessione su questo tema è stata impostata in un modo fin troppo semplificato: in molti manuali giornalistici, la comprensibilità delle notizie si baserebbe sull’adozione di quello che viene chiamato il “linguaggio corrente”, espressione con cui si intende l’impiego di parole semplici e non tecniche, difficili o oscure, e lo scrivere in modo scarno e privo di ricercatezza (Lepri 1986, 112). Ma la comprensibilità di una notizia non è solo qualcosa che riguarda la chiarezza delle parole o delle espressioni impiegate, quanto qualcosa che attiene alla comprensione del tipo di azione che viene compiuta con il linguaggio, sia essa una descrizione o una critica, un’interpretazione o una spiegazione.
I giornalisti, i reporter e i redattori sono dei professionisti, nel senso che possiedono scopi specifici e si caratterizzano per la creazione di tipi particolari di testi. Tuttavia, le risorse e le competenze con cui nel loro lavoro utilizzano il linguaggio per fare una descrizione o per fornire una spiegazione non sono qualcosa di totalmente distinto rispetto alle pratiche di produzione del significato che si rintracciano nell’uso ordinario del linguaggio, non fosse altro perché l’obiettivo fondamentale dei giornalisti è la comprensibilità dei loro testi da parte dell’anonimo lettore-ascoltatore. Da questo punto di vista, se c’è qualcosa che testimonia la possibilità dell’intersoggettività del significato è senz’altro l’esistenza dei mass media (Stetson 1999, 95). Il problema è che i giornalisti usano tali competenze e risorse in modo implicito e dandole per scontate. L’obiettivo dell’analisi etnometodologica è di far emergere e rendere visibili tali competenze e risorse. A questo scopo, non è necessario predisporre strumentazioni metodologiche particolari: non si tratta di andare dai lettori e sottoporre loro un questionario strutturato o un’intervista al fine di raccogliere dati su come leggono le notizie; piuttosto, si tratta di fare leva sul fatto che anche il sociologo è un membro della società, per cui anche lui legge e comprende le notizie giornalistiche né più né meno come fanno tutti gli altri. In altre parole, il ricercatore è in grado di scoprire i metodi e le pratiche che sono costitutive dell’attività sociale di leggere o di ascoltare le notizie non perché egli disponga di strumenti metodologici particolari – come vuole invece la tradizione sociologica positivistica incarnata nell’uso di questionari, test, interviste e analisi del contenuto – tali da offrirgli un punto di vista conoscitivo “esterno” o “superiore” rispetto a quello della gente comune, ma perché condivide con i “profani” gli stessi assunti, metodi e competenze per riconoscere e comprendere le descrizioni e le spiegazioni contenute nelle notizie. Se tali metodi e competenze sono “senso comune”, allora tutti i membri di una società li possiedono, compreso il sociologo. L’analisi delle notizie può quindi avvenire attraverso quella che possiamo chiamare una «ricerca etnometodologica fatta dalla poltrona» (Francis e Hester 2004, 35).
Ribadisco: il mio obiettivo non è quello di produrre interpretazioni più profonde rispetto a quelle dei normali lettori, come se il sociologo avesse un’abilità “superiore” che gli permetta di definire una volta per tutte il vero significato di una notizia o di scoprire significati nascosti. Piuttosto, l’obiettivo è lo studio della normale comprensione dei testi mediatici, al fine di scoprire come le notizie acquistano normalmente significato per i lettori-ascoltatori: quali sono i metodi, le competenze e i ragionamenti con cui comprendiamo il significato delle notizie.
La gran parte delle procedure e delle competenze impiegate dai lettori-ascoltatori per comprendere le notizie e dai giornalisti per elaborarle è qualcosa di dato per scontato e quindi una conoscenza tacita. La natura invisibile di queste pratiche e competenze è un problema per il ricercatore. Ma esistono delle soluzioni. Il primo passo per rendere visibili e far emergere tali metodi e tali competenze consiste nel cercare di rendere strana l’attività normale di leggere il giornale o di seguire il telegiornale. A questo scopo, ho proceduto a conservare le notizie, leggendole o ascoltandole molto tempo dopo. Ciò assicura una sorta di “estraniamento” rispetto al contenuto. Non è infatti il contenuto che interessa, quanto il come si produce tale contenuto, e cioè il significato, la comprensibilità e altre caratteristiche di quel contenuto, quali la capacità di suscitare curiosità, di essere neutrale o invece partigiano etc.
Un altro espediente utile è quello di provare a riscrivere la notizia in certi suoi aspetti, mantenendo tuttavia l’aderenza alla storia notiziata. Ciò mi ha consentito di afferrare meglio i “meccanismi” che sono incassati dentro il testo-notizia e da cui dipende la sua “leggibilità-comprensibilità”. Riscrivendo in altro modo una specifica notizia le si fa perdere la sua capacità di produrre certi effetti e ciò consente finalmente di rendere pienamente visibili i meccanismi che producevano tali effetti, meccanismi altrimenti nascosti nel “dato per scontato”. Riscriverla mi ha permesso di capire meglio l’importanza di certi dettagli, in apparenza banali, che alla semplice lettura o ascolto della notizia possono facilmente sfuggire. I meccanismi di significazione delle attività sociali sono nascosti nei dettagli e in altri aspetti in genere trascurati o «visti ma non notati» (seen but unnoticed), per citare l’espressione di Garfinkel (Garfinkel 1984, 36). L’obiettivo finale dell’analisi etnometodologica è di trarre dall’opacità questi dettagli. Chi legge le ricerche etnometodologiche non ha l’impressione di cogliere qualcosa di nuovo, ma rimane sorpreso nel notare aspetti a cui non aveva mai fatto caso prima. L’attenzione dell’etnometodologia si concentra quindi su aspetti e dettagli minimi, in apparenza banali, ma di cui si mette in risalto l’importanza come potenti risorse per leggere-ascoltare una notizia o per elaborare una notizia.
Rendere strana l’attività normale di leggere le notizie
Proviamo a porci la seguente domanda: come è possibile che le notizie acquistano significato per noi lettori e, cosa altrettanto degna di nota, significano allo stesso modo per la stragrande maggioranza di noi? Innanzitutto, occorre scartare la risposta dei linguisti: infatti, non è soltanto la competenza relativa al lessico e alla grammatica della lingua italiana che permette ai lettori la comprensione immediata, ovvia e naturale di un testo giornalistico. Questo perché un testo come un titolo, un articolo o una presentazione pronunciata da uno speaker in un notiziario radio-televisivo significa molto di più di quanto esprime il suo contenuto letterale. Detto in modo più elementare, leggere o ascoltare un testo comporta necessariamente andare oltre il suo significato letterale. Un testo non comunica esplicitamente la gran parte del contenuto che effettivamente riferisce, ragion per cui attribuire un significato a un titolo, a una foto, a un articolo o a un servizio comporta l’aggiungere una serie di informazioni mancanti. Bisogna immaginare un testo mediatico come qualcosa che acquista il suo significato attraverso l’opera di riempimento dei suoi “vuoti” che viene operata dal lettore-ascoltatore. Ma questo “aggiungere” non avviene in modo arbitrario o casuale, bensì in maniera metodica e sulla base di procedure condivise da tutti. Tale “riempimento” avviene attraverso il ricorso a conoscenze e assunti relativi a come va il mondo (Hester ed Eglin 1997b).
Contrariamente a quanto sostenuto negli studi classici, secondo cui la notizia sarebbe una sorta di «comunicazione decontestualiz...