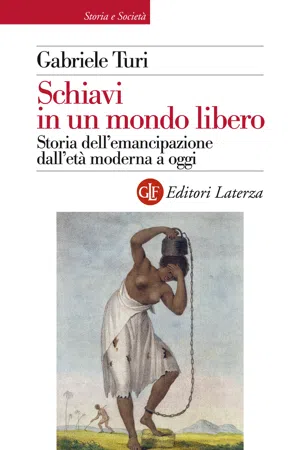Lo schiavo e gli schiavi
Qual è la realtà da cui parte la nostra storia a metà del Settecento? Per comprendere contro cosa e perché si combatte saranno utili alcuni cenni su dimensioni, estensione geografica e caratteri della schiavitù, come su volume, organizzazione e percorsi della tratta. Cosa significa, in primo luogo, parlare di schiavitù? La domanda non è retorica e la risposta non è scontata: prevede scenari, costumi, norme e articolazioni molteplici, i quali contribuiscono a spiegare le forme e i tempi diversi dell’emancipazione legale e di quella reale, fino alle permanenze o alle eredità individuabili nelle manifestazioni odierne.
Pur ammettendo che ci sia stata, «tra la schiavitù in tempi antichi e la schiavitù in tempi moderni, una continuità istituzionale maggiore di quel che non si sia generalmente creduto», e che «i termini ‘servo’, ‘servo della gleba’ e ‘schiavo’ sono stati spesso accettati come sinonimi», le definizioni convenzionali o giuridiche per qualificare chi è «schiavo» in età moderna sono concordi nel distinguerlo da quello dell’antichità e dal servo della gleba, e nell’individuarne alcuni tratti generali comuni nella maggior parte delle colonie europee e nelle Americhe, ma anche, per alcuni aspetti, in Asia e in Africa: esso era proprietà del padrone, che nel caso della chattel slavery lo poteva vendere ad altri, a differenza del servo era un outsider – non appartenente alla stessa comunità etnica, religiosa o linguistica del proprietario –, non aveva alcun diritto legale né libertà di scelta nei rapporti sessuali o matrimoniali, e la sua prole passava automaticamente alle dipendenze del padrone, di quello della madre se i genitori erano proprietà di persone diverse.
Insistere solo sul concetto di proprietà non esaurisce tuttavia la specificità della schiavitù, così come non la spiega del tutto la distinzione di Marx fra lo schiavo, soggetto a un «lavoro coatto immediato», e il salariato che dipende da un «lavoro coatto mediato». La schiavitù si distingue ovunque – ha osservato Orlando Patterson – non tanto come la proprietà di un essere umano, la sua durata a vita e la sua ereditarietà, quanto come la più estrema delle relazioni di dominio, in cui il padrone acquista l’intera vita dello schiavo rendendolo un individuo «socialmente morto», isolato anche dal rapporto con antenati e discendenti e spogliato della sua dignità per l’assenza di qualsiasi potere, per cui «la schiavitù è il dominio permanente e violento di una persona alienata per nascita e del tutto privata dell’onore»: una persona senza storia e senza un futuro personale e culturale. Un oggetto, quindi, o un animale da sfruttare a piacimento mantenendolo in vita per trarre profitto dal suo lavoro? Questa era l’opinione più diffusa; ma lo schiavo era un oggetto o un animale particolare, in quanto era pur sempre un essere umano, come non potevano non riconoscere gli stessi proprietari nel mondo occidentale insistendo, ad esempio, sulla necessità della sua conversione al cristianesimo.
Già il Code Noir emanato da Luigi XIV nel marzo 1685 per regolare il sistema schiavistico nelle colonie caraibiche della Francia – che assieme alla revoca dell’editto di Nantes sulla libertà di culto dei protestanti, nell’ottobre dello stesso anno, intendeva affermare l’autorità del re a spese delle minoranze –, pur definendo gli schiavi «esseri mobili» (art. 44), cioè dei beni che il proprietario poteva vendere ad altri o trasmettere agli eredi, e pur precisando quali punizioni corporali potevano essere loro inflitte, ancor prima si era preoccupato che fossero «battezzati e istruiti nella religione cattolica, apostolica e romana» (art. 2), vietando la professione di altre religioni (art. 3), il lavoro nei giorni festivi (art. 6) e il matrimonio fra non cattolici (art. 8).
La conversione, non solo nel caso francese, corrispondeva a uno spirito evangelizzatore presente fin dal periodo della Conquista, ma si spiega anche con l’esigenza di controllo sociale. «Ho incontrato al Sud molta gente di colore, buona e religiosa, soggetta alla mistificazione che Dio richiedesse loro di sottomettersi alla schiavitù e di portarne le catene con mitezza e umiltà. Io non potevo dar fede a un tale nonsenso», scrive nella sua autobiografia l’ex schiavo Frederick Douglass; anche la distinzione bianchi-neri, ricorda, era attribuita alla volontà di Dio dai padroni, pur consapevoli della diversa interpretazione che si poteva dare dei testi sacri: «Se impara a leggere la Bibbia si sentirà poi inadatto ad essere uno schiavo», sosteneva il suo proprietario ritenendo pericolosa l’istruzione dei neri.
Gli schemi generalizzanti non rendono conto della varietà delle situazioni. I modi di acquisizione «originaria» degli schiavi, prima della loro vendita, erano molteplici: non solo in Africa, che fra Settecento e Ottocento ne fu la maggior «produttrice» per il mercato estero, essi potevano diventarlo come prigionieri di guerra, vittime di rapimenti, condanne a pene giudiziarie per assassinio, furto, adulterio o stregoneria, o perché erano consegnati dai genitori o si consegnavano volontariamente in schiavitù per pagare un debito e quindi assicurarsi la sopravvivenza. Erano quasi sempre degli outsiders, ma i criteri per considerarli tali erano diversi e non sempre distinguibili per macrocategorie: affermare che gli europei giustificavano la sottomissione degli schiavi su base razziale, considerandoli naturalmente e irrimediabilmente inferiori, e che la religione era invece la ratio usata dagli islamici, che non facevano in genere schiavi musulmani, semplifica una realtà ben più complessa. Il panorama che segue non intende entrare nel merito del dibattito sulle funzioni o sulle condizioni di vita degli schiavi, ma solo indicare le dimensioni del fenomeno all’inizio del processo abolizionista, alcuni dei caratteri che esso aveva nelle diverse aree del mondo e come fosse percepito da sfruttatori e sfruttati: ciò, occorre ripeterlo, può contribuire a spiegare i modi e i tempi diversi con i quali si è arrivati all’emancipazione o a forme diverse di assoggettamento.
Il caso della schiavitù nelle Americhe è quello che più ha colpito i contemporanei e più continua a suscitare interrogativi e indagini, non tanto per le sue dimensioni – minori che in Africa e in Asia –, quanto per la sua novità nell’età moderna, in una fase in cui vengono formulate e in parte messe in pratica le prime teorie liberali e liberiste, per gli effetti economici – la rivoluzione industriale inglese di fine Settecento ha usufruito del cotone greggio coltivato da schiavi nel Sud degli Stati Uniti, per fare un esempio –, per le conseguenze socioculturali con la costituzione di intere comunità nere – assenti in Asia –, per le eredità lasciate fra i discendenti degli schiavi e nei paesi «fornitori», o per il dibattito sul rapporto tra schiavitù ed economia capitalistica e sul problema morale che la prima ha suscitato nella cultura occidentale.
Prima ancora che nelle Americhe la schiavitù era presente in Asia e in Africa, mentre all’interno dei paesi europei era stata dichiarata illegale verso la metà del Settecento, anche se la servitù della gleba sopravvisse ancora per un secolo nell’Europa orientale. Le forme in cui si manifestava erano tuttavia molto diverse, tanto che sono stati messi in dubbio la liceità di un comune denominatore per qualificarle con lo stesso termine «schiavitù». Il dibattito è nato tra gli africanisti, quando nel 1977 Suzanne Miers e Igor Kopytoff contrapposero al modello americano di sfruttamento economico e di isolamento sociale dello schiavo quello dei regni africani prima della colonizzazione europea: nelle società del continente africano, in cui non avevano alcun significato i concetti occidentali di proprietà e di libertà, la schiavitù era una relazione sociale relativa ai diritti della persona, che coinvolgeva i legami di parentela e di clientela, con la tendenza dei padroni a ridurre la marginalità degli schiavi integrandoli nel proprio lignaggio; di qui la mancanza di violenza e di rivolte paragonabili a quelle registrate nel Nuovo Mondo. La risposta a questa tesi fu immediata: pur riconoscendo le differenze, Martin Klein affermò che anche in Africa gli schiavi erano beni mobili sfruttati a fini economici, e che proprio l’assenza di una loro identità sociale ne aveva facilitato la vendita e la tratta, mentre Frederick Cooper ha negato l’esistenza di una specifica «schiavitù africana» ricordando come nella stessa America lo schiavo – pur privato dei suoi legami di parentela – non fosse una pura proprietà mobile ma anche un simbolo di prestigio sociale per il proprietario, e come in America latina i poteri dei padroni trovassero un limite nell’intervento della Chiesa cattolica. Un’analisi globale della schiavitù, quale si è sviluppata in tempi recenti anche per l’Asia e il Medio Oriente, deve quindi tener conto dei caratteri comuni e delle differenze, senza la pretesa di imporre a tutte le realtà un presunto «modello occidentale».
Il dibattito fra gli storici sembra essersi assestato su questi risultati, forse anche per la suggestione di un concetto di schiavitù di cui nel corso del Novecento le prese di posizione degli organismi internazionali hanno ampliato il significato. Resta comunque valido l’invito di Cooper non solo a cogliere le differenze all’interno di un sistema che mantiene caratteristiche comuni di fondo, ma anche a «vedere le forme di schiavitù non come strutture fisse ma come processi interattivi, formati dagli schiavi così come dai loro padroni». L’esistenza nei vari paesi di numerosi termini per definire questa istituzione testimonia la complessità e la variabilità di un rapporto di soggezione che, mentre si distingue da quello della servitù della gleba che non prevedeva la vendita individuale del servo, ha confini spesso labili con altre forme di sfruttamento. Alcuni studiosi anglosassoni preferiscono parlare non di slavery ma di bondage, per indicare «un sistema più ampio di obbligo a lavorare per un patrono senza una ricompensa diretta»: un termine già usato da Moses Finley per forme di asservimento diverse dalla schiavitù nel mondo antico....