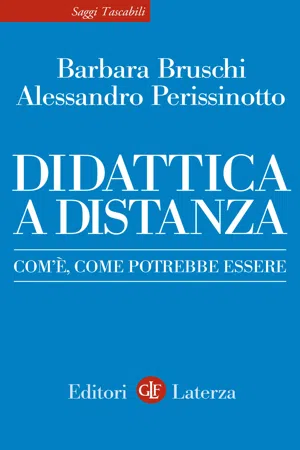1.
Non siamo nati ieri:
breve nota sulla preistoria
della didattica a distanza
Intorno al 1840 Isaac Pitman, un insegnante inglese, inventa quello che sarebbe diventato il più famoso metodo stenografico per la lingua inglese. Pitman era un uomo curioso e creativo e cercò tutte le soluzioni possibili per diffondere la sua scoperta, con l’obiettivo di raggiungere non solo i discenti che potevano frequentare la sua scuola, ma anche chi era troppo lontano per farlo. Per questo decise di affidare i propri «insegnamenti» al sistema postale, che nasceva nella sua forma «moderna» proprio in quegli anni. In cambio del pagamento di una modesta somma di denaro era possibile recapitare, in tutto il Paese, le dispense che illustravano il suo metodo, raggiungendo così quel pubblico troppo adulto e troppo impegnato per tornare sui banchi di scuola.
Nasce quindi la prima soluzione di formazione a distanza. Da quel momento in poi l’evoluzione del servizio postale ha condotto ad una rapida e piuttosto intensa diffusione delle proposte formative per corrispondenza. Queste erano rivolte in particolare ad adulti in cerca di promozione sociale e vanno collegate allo sviluppo di una società nella quale apparivano sempre più necessarie l’istruzione di base, una buona cultura e la padronanza di competenze specifiche. Le materie insegnate per corrispondenza erano quelle che avrebbero permesso alla nuova classe di ricchi commercianti di avere accesso ai salotti della nobiltà, soprattutto quella britannica, per stringere rapporti commerciali chiacchierando amabilmente di letteratura e poesia. Il discente per corrispondenza era generalmente un uomo d’affari adulto che, grazie alle proprie capacità imprenditoriali, aveva raggiunto un livello economico pari a quello di molti nobili, ma a differenza di questi non poteva contare sulle proprie conoscenze per farsi strada in quei circoli che costituivano, a tutti gli effetti, il vero centro nevralgico delle attività redditizie.
Questi signori, rigorosamente uomini, avevano denaro per acquistare i materiali didattici, tempo per studiarli e soprattutto spazi adatti a favorire la concentrazione e l’apprendimento. Tali aspetti non sono elementi di colore appartenenti a un’epoca lontana, ma fattori fondamentali per capire il percorso evolutivo della formazione a distanza. Infatti, va subito detto che la locuzione «formazione a distanza» da sempre ha contrassegnato quelle soluzioni formative che, nel senso comune, venivano viste come un rimedio rivolto a chi non aveva avuto la possibilità di ricevere un’educazione di alto livello e doveva, in età adulta, recuperare quel gap culturale che gravava sulla sua esistenza personale e professionale. In Europa, per lungo tempo (il dibattito più recente ci fa pensare che quel tempo non sia ancora terminato), la formazione a distanza è stata intesa come una soluzione di serie B che permetteva di recuperare ciò che si era perso, ma che non sarebbe mai stata capace di raggiungere, sul piano della qualità e dell’efficacia, la formazione scolastica.
Negli Stati Uniti la didattica per corrispondenza segue un percorso differente e già nel 1873 viene istituito, presso la Illinois Wesleyan University di Bloomington, un dipartimento per l’erogazione di corsi a distanza. Trattandosi di formazione universitaria, i corsi erano rivolti a un pubblico con una solida formazione precedente, il quale raggiungeva, grazie a questa opportunità, un riconoscimento di tipo accademico. La platea non è più composta esclusivamente da adulti, ma comincia a comprendere studenti più giovani. A partire da questa esperienza, la formazione per corrispondenza comincia a diffondersi e nel 1905, sempre negli Stati Uniti, un istituto scolastico sperimentale privato propone corsi per la formazione primaria a circa cinquecento alunni. Qualche anno dopo (1910), in Australia, vengono avviati, su iniziativa dell’amministrazione pubblica, corsi a distanza per l’alfabetizzazione dei bambini residenti in regioni isolate. La didattica a distanza comincia così il suo percorso teso ad avvicinare la formazione a chi è fisicamente troppo distante e rischierebbe di non ricevere l’istruzione adeguata alla propria età.
Tornando in Europa, ma procedendo sulla linea del tempo, arriviamo alla fine della seconda guerra mondiale, che rappresenta un momento particolarmente favorevole per la diffusione della formazione a distanza. La ricostruzione e lo sviluppo dell’economia generano, infatti, una forte richiesta di figure professionali specializzate che siano in grado di rispondere adeguatamente alle richieste di sviluppo e innovazione del periodo. Le aziende, al culmine della fase post-bellica, cominciano ad avere necessità di professionisti in diversi settori, ma non sono in grado di sostenere i costi di una formazione che preveda l’allontanamento degli operai dal luogo di lavoro. La didattica a distanza rappresenta, ancora una volta, la soluzione migliore per ottenere lavoratori all’altezza delle nuove sfide senza ridurre i ritmi di produzione. Su queste basi nasce in Italia uno degli esperimenti sulla didattica a distanza più importanti d’Europa: la Scuola Radio Elettra. Viene inaugurata a Torino nel 1951 e rappresenta un modello per la didattica per corrispondenza. Le sue origini si devono alla pressante richiesta di elettricisti e di esperti in telecomunicazioni proveniente dalle imprese pubbliche e private impegnate nella ricostruzione dell’Italia del dopoguerra.
Nonostante le grandi potenzialità, la didattica per corrispondenza presentava diverse criticità di tipo metodologico. Innanzitutto, le interazioni erano totalmente assenti: solo in alcuni casi erano contemplati scambi epistolari tra discente e docente, finalizzati, per lo più, alla consegna e correzione di materiali di studio. I feedback, quando previsti, richiedevano tempi estremamente lunghi, che ne riducevano drasticamente l’efficacia e l’utilità. I materiali erano prevalentemente testuali, con una didattica basata in larga misura sulla dimensione nozionistica. Nonostante ciò, non è possibile non rilevare il ruolo che, in molte nazioni, questa soluzione formativa ha svolto nel percorso verso lo sviluppo e come essa abbia consentito a molti giovani di dare una svolta alla propria esistenza. Quei giovani, che per vari motivi non avevano potuto frequentare la scuola, se non avessero avuto la possibilità di specializzarsi attraverso la formazione per corrispondenza avrebbero avuto la vita segnata e il loro Paese non avrebbe potuto disporre della manodopera specializzata di cui aveva tanto bisogno per ripartire.
Nel 1920 a Salt Lake City viene inaugurata la prima emittente radiofonica per l’erogazione di corsi universitari; cinque anni dopo Radio Lussemburgo esordisce con le prime programmazioni con finalità educative. A differenza di quanto era accaduto nel caso della formazione per corrispondenza, la radio trova immediatamente applicazione nell’educazione scolastica dei minori, tant’è che nel 1927 la BBC propone una programmazione a supporto della didattica in classe.
Ma il nuovo mezzo non riesce ancora a migliorare le interazioni e queste, come nella formazione di prima generazione (quella per corrispondenza), rimangono assai scarse. Proprio per rispondere in qualche modo al bisogno di scambi tra docente e discente, la formazione radiofonica viene presto integrata con il telefono, che a partire dagli anni Quaranta è impiegato, in particolare, come servizio per le persone con disabilità e per chi è impossibilitato a raggiungere altre soluzioni formative. Sin dalle prime esperienze, la didattica per telefono si rivolge a un pubblico adulto, proponendo per lo più corsi universitari. Nonostante l’introduzione del telefono, questa nuova soluzione formativa non soppianta la didattica per corrispondenza, che continua a rappresentare, per molto tempo, la soluzione più efficace per la gestione del percorso didattico. Infatti, il servizio postale permette almeno l’invio di esercizi e di compiti che i discenti possono svolgere per ricevere feedback rispetto al proprio apprendimento. Al contrario, le soluzioni basate sull’integrazione di radio e telefono sono, da questo punto di vista, assolutamente inadeguate.
Verso la fine degli anni Quaranta hanno inizio le prime sperimentazioni di impiego della TV nella formazione a distanza. Inizia così quella parte di storia della televisione che la vede associata ai percorsi di alfabetizzazione e di formazione, anche superiore, che continua ancora oggi. La televisione si presenta subito come un fattore di cambiamento nella didattica, sia perché introduce linguaggi (quello delle immagini statiche e in movimento, ad esempio) che, per ovvi motivi, non erano mai stati impiegati prima; sia perché non sarà utilizzata esclusivamente nell’erogazione a distanza dei contenuti, ma entrerà anche nelle aule, introducendo nuove prospettive per l’insegnamento disciplinare. Questo non significa affatto che la TV abbia avuto, da subito, vita facile. Gli esordi della televisione nel mondo dell’educazione sono stati faticosi e a lungo essa è stata vista come uno spazio artificioso e superficiale, assai lontano dal rigore scientifico che pedagogia e didattica ricercavano nel campo dell’apprendimento. Ne sono testimonianza i numerosi studi che negli anni Settanta e Ottanta hanno cercato di dimostrare i pericoli connessi all’esposizione televisiva dei più piccoli e l’inutilità dei programmi della TV.
Esiste però un altro lato della medaglia, rappresentato da due trasmissioni che andarono in onda, per la prima volta, a pochi anni di distanza l’una dall’altra. La prima è Telescuola, la seconda Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per il recupero dell’adulto analfabeta. Entrambe nascevano dalla collaborazione tra il ministero della Pubblica Istruzione e la RAI e rappresentavano una soluzione per supplire alle carenze del sistema scolastico, che in quegli anni vedeva ancora una porzione piuttosto ampia di popolazione esclusa dall’istruzione. Il 25 novembre 1958 va in onda la prima puntata di Telescuola, una sperimentazione di avviamento professionale che permette agli studenti residenti in aree prive di scuole di seguire delle vere e proprie lezioni. La seconda trasmissione conquistò invece una fama più ampia, anche grazie alla figura carismatica del maestro Manzi che, dal 15 novembre 1960 al 1968, insegnò a leggere e scrivere a migliaia di adulti non alfabetizzati che mai sarebbero andati a scuola.
Manzi e la sua scuola per televisione hanno avuto una funzione sociale fondamentale, sia perché hanno contribuito a una diminuzione dei tassi di analfabetismo, sia perché hanno posto in evidenza il ruolo della scuola e dell’istruzione per lo sviluppo del Paese e dei suoi cittadini.
Dal punto di vista metodologico Manzi può essere riconosciuto come un anticipatore della più moderna formazione in remoto. Riportiamo di seguito un frammento di un’intervista in cui egli racconta come si è avvicinato alla sua aula televisiva:
...hanno portato una sessantina di fogli di carta, io li ho fatti attaccare al muro, ho preso un pezzo di gesso e ho cominciato a disegnare. La soluzione qual era..., nessuno si era posto il problema che la televisione..., io che non la conoscevo però pensavo che la televisione è immagine in movimento, se io mi fermo venti minuti addormento tutti, se voglio tenerli svegli devo fare qualcosa che si muove. Allora o metto le ballerine, ma non era degno della scuola, o faccio qualsiasi altra cosa, però non rientrava nella scuola. Allora l’unica cosa era disegnare, bastava schizzare qualcosa, meglio che fosse stato incomprensibile all’inizio e poi si capiva alla fine, in maniera che quello stava lì guardava e intanto mi stava a sentire.
Manzi, nel momento stesso in cui entra nello studio televisivo, intuisce che la formazione al di fuori della classe deve essere riprogettata. Essa va ripensata per aderire alla variabilità delle forme di fruizione di chi apprende e per essere coerente con i linguaggi e i codici tipici di quel contesto. Il maestro aveva chiaro, sin da subito, come insegnare «per televisione» non significasse solo trasmettere i contenuti attraverso una tecnologia, ma che occorresse ridefinire le strategie comunicative in funzione del diverso setting di insegnamento e di apprendimento. Il suo era già a quei tempi un modello didattico incentrato sullo studente: nella progettazione egli partiva dalle necessità di chi apprende per individuare delle soluzioni coinvolgenti e adeguate a mantenere alta l’attenzione. Ecco che riflette sui tempi della lezione (parla di moduli da venti minuti) e sui mediatori didattici che più di altri possono contribuire a ridurre quello stato di fruizione passiva facilmente indotto dallo schermo televisivo. Egli stabilisce un dialogo costante con i suoi discenti attraverso l’uso sapiente della «lavagna» e ricorrendo a varie soluzioni dialogiche, tra le quali spicca un costante flusso di domande.
Passano molti anni prima che la televisione italiana torni a proporre un piano formativo di vasto respiro. Dobbiamo infatti arrivare al 1992 per vedere la nascita del Consorzio Nettuno che porta in TV l’università a distanza. Alla base del progetto c’è la convinzione che la formazione, anche quando erogata in remoto, debba essere di qualità e debba avere i suoi fondamenti nelle università in presenza. Gli insegnamenti diffusi via etere hanno quindi due versioni: la prima prevede lezioni frontali in presenza; la seconda propone gli stessi contenuti scientificamente validati e di alto livello trasmessi in televisione. Le prime esperienze di «teleuniversità» sono metodologicamente piuttosto essenziali e, generalmente, prevedono: un setting standard, costituito da una lavagna e una scrivania; un docente che spiega per circa un’ora l’argomento del giorno; nessun tipo di adeguamento delle forme di comunicazione al medium; un livello di interazione decisamente basso. Nel tempo, il Consorzio si è adeguato all’evoluzione della normativa e delle tecnologie (l’istituzione delle università telematiche, con il decreto MIUR del 17 aprile 2003, determinava la fine della prima fase del progetto e la nascita dell’università telematica internazionale Uninettuno) e nella sua seconda fase, iniziata nel 2018, il progetto è a tutti gli effetti orientato sulla dimensione telematica.
Esplorando il panorama internazionale, notiamo che la BBC, sin dal lontano 1957, ha occupato un ruolo di tutto rilievo nell’erogazione di contenuti didattici attraverso la televisione. Ancora oggi il colosso britannico propone interessanti format utilizzabili sia in self learning sia in affiancamento ai percorsi scolastici in presenza. Il passaggio al digitale ha permesso di integrare formati differenti e di definire soluzioni piuttosto innovative che possono rappresentare un ingrediente stimolante nell’organizzazione delle lezioni.
Ampliando ulteriormente l’orizzonte, ci accorgiamo che le iniziative educative basate sulla televisione sono ancora oggi numerose. In Thailandia, dal 2008, la Distance Learning Foundation ha svi...