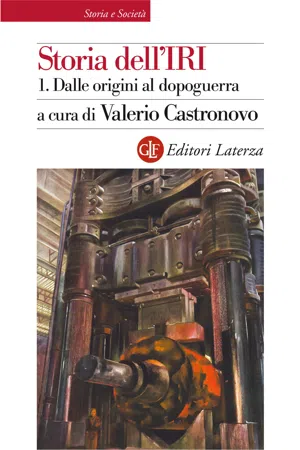1. Stato e mercato, i precedenti: dall’interventismo ai salvataggi degli anni Venti
di Anna Maria Falchero
La nascita dell’Istituto per la ricostruzione industriale, lungi dal rappresentare la risposta estemporanea ad una crisi di portata mondiale tardivamente approdata ad un’economia relativamente arretrata, costituiva in realtà il punto di arrivo di un lungo percorso caratterizzato non solo da un «supporto» statale, apparentemente irrinunciabile, al faticoso processo di industrializzazione del paese, ma anche dal crescente ricorso allo Stato quale finanziatore (di solito a fondo perduto) di salvataggi bancari e industriali di portata sempre più vasta.
Allo Stato imprenditore, infatti, si perviene attraverso approssimazioni successive, con un percorso tutt’altro che graduale e lineare, costellato di emergenze e di interventi straordinari puntualmente definiti «temporanei», che finivano per trasformarsi, esaurite le alternative, in altrettanti «salti di qualità» dell’interventismo statale.
La struttura di funzionamento e il metodo di finanziamento dell’IRI rappresentavano a loro volta il punto di approdo di «riflessioni pratiche» su un nuovo modello di interventismo statale sperimentate attraverso, appunto, approssimazioni successive sia nell’ambito della Banca d’Italia (dal Consorzio sovvenzioni su valori industriali all’Istituto di liquidazioni) sia attraverso i vari istituti – dal Crediop all’Icipu – progettati e varati nel decennio precedente dal suo ideatore, Alberto Beneduce.
Se le radici dello «Stato imprenditore» vanno ricercate nelle «tare d’origine» e nelle anomalie del «capitalismo all’italiana», ripercorrerne la genesi e sottolinearne le peculiarità risulta indispensabile premessa ad un’attenta ricostruzione del ruolo e dell’effettivo peso esercitato dall’IRI nella successiva evoluzione dell’economia del paese.
Focalizzeremo pertanto l’attenzione su due aspetti, entrambi fondamentali per individuare una sorta di «path dependency» nell’evoluzione dell’interventismo statale: da un lato, l’evoluzione della struttura del sistema bancario italiano e gli effetti determinati dalle crisi sui vari comparti; dall’altro, la vexata quaestio della destinazione degli impieghi bancari e del finanziamento all’industria.
Pur consapevoli dell’indubbio peso esercitato su tali aspetti dalle vicende del cinquantennio post-unitario, e segnatamente dalla genesi e dai riflessi delle grandi crisi finanziarie internazionali del 1873 e del 1907, assumeremo come termine ab initio un evento che ha tutte le caratteristiche di un «elemento di discontinuità»: la Grande Guerra. La prima guerra mondiale, infatti, non solo modificò in misura notevole l’assetto e gli equilibri del sistema industriale e di quello creditizio, ridisegnando il rapporto tra banca e industria, ma rappresentò un’efficace «incubatrice» per la nascita di quella nuova tipologia di strumenti finanziari di ispirazione pubblica che in ambito nittiano si andavano progettando da circa un decennio e che intendevano affrontare in maniera innovativa l’annoso problema del finanziamento dell’enorme mole di interventi pubblici indispensabili per la modernizzazione del paese.
1. Guerra e dopoguerra
Prima ancora dell’entrata in guerra dell’Italia, lo scoppio del conflitto mondiale aveva fatto da catalizzatore per la nascita, nel dicembre 1914, di due organismi che, con ruoli e natura ben diversi, avrebbero figurato tra i protagonisti della crisi del primo dopoguerra: la Banca Italiana di Sconto e il Consorzio sovvenzioni su valori industriali (Csvi).
Nel caso del Csvi, istituito con r.d. 20 dicembre 1914 e considerato, non a torto, all’origine dello Stato imprenditore, il nesso risulta evidente e venne tra l’altro fortemente sottolineato dal suo principale artefice, Bonaldo Stringher, mentre per quanto concerne la «banca italianissima» tale nesso venne esplicitamente richiamato nell’atto di costituzione dell’istituto, sottoscritto il 31 dicembre 1914. In entrambi i casi si trattava di progetti che erano andati maturando a partire dalla crisi del 1907, ma che soltanto con lo scoppio delle ostilità e con l’affermarsi della concreta possibilità di una partecipazione italiana alla guerra avevano finito col concretizzarsi.
Il rischio che il mercato dei valori industriali, «abbandonato a se stesso, senza un valido appoggio», finisse per crollare e la preoccupazione per un possibile precipitoso ritiro dei depositi avrebbero infatti convinto il direttore generale del principale istituto di emissione a riproporre, in funzione preventiva e con una partecipazione allargata alle banche di diritto pubblico e ad alcune casse di risparmio, uno strumento «eccezionale e transeunte» almeno in parte simile al Consorzio interbancario che aveva debuttato, in qualità di intermediario, nel «salvataggio» della Società bancaria italiana.
Dotato di un capitale iniziale di 25 milioni di lire, elevato a 40 milioni pochi mesi dopo, con il contributo di vari istituti di credito, il Consorzio sovvenzioni su valori industriali, che avrebbe dovuto cessare la sua attività al termine del conflitto ma che venne ripetutamente prorogato, avrebbe visto ben presto ampliati i propri compiti e i relativi mezzi finanziari, sino a configurarsi nel dopoguerra, per dirla con le parole di Ernesto Cianci, come «un meccanismo di primaria importanza nella patologia economica del paese», una sorta di «lebbrosario» nel cui portafoglio si accumulavano «crediti di lunga e difficile esazione, fonte immancabile di perdite».
Anche per quanto concerne la costituzione della Banca Italiana di Sconto, lo scoppio delle ostilità avrebbe giocato un ruolo fondamentale nel concretizzare il progetto di dar vita a un istituto di credito «italiano» (ma a forte partecipazione francese) che contrastasse efficacemente, anche dal punto di vista politico, l’influenza delle banche tedesche.
Infatti, sino alla vigilia del primo conflitto mondiale il vertice dell’apparato creditizio italiano appariva saldamente occupato dalle due grandi banche miste costituite, con il decisivo contributo di capitali esteri (in particolare tedeschi), all’indomani del fragoroso crollo del Credito Mobiliare e della Società Generale: la Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano, che i finanzieri d’oltralpe non sembravano in grado di scalzare, dovendo accontentarsi di partecipazioni azionarie in istituti di credito periferici, come la Società italiana di credito provinciale, o peggio ancora pencolanti, come la Società bancaria italiana.
Eccezion fatta per il Banco di Roma, un istituto peraltro per molti versi «anomalo», il dominio esercitato da Comit e Credit, presenti in qualità di finanziatori ma anche di azionisti nella gran parte delle maggiori imprese industriali, sembrava perciò non dover lasciare spazio per l’affermarsi di un ulteriore «grande» istituto di credito, nonostante sin dal 1913 circolassero voci di trattative in corso per una fusione tra le banche a partecipazione francese e lo stesso Banco di Roma, peraltro alle prese con le pesanti perdite provocate dalla politica espansionistica che aveva accompagnato la guerra di Libia.
La guerra si rivelò, invece, un catalizzatore efficace di tutti gli elementi che, pur preesistendo, non avevano fino a quel momento avuto che scarse occasioni per unire le proprie forze e porsi obiettivi comuni. All’acuirsi del disagio in cui si trovavano quasi tutte le imprese, alle quali le banche avevano immediatamente ridotto il già scarso aiuto creditizio nel timore di dover far fronte a un’ondata di ritiri dei depositi, faceva riscontro la necessità di incrementare la produzione e di prepararsi a rispondere a una domanda che, nel settore siderurgico, elettrico e tessile, non poteva che aumentare. Il problema dei finanziamenti all’industria, che assillava le imprese italiane già a partire dal 1907, diveniva, in queste condizioni, centrale, e la crisi del Banco di Roma contribuì ad aggravarlo e a convincere una parte degli imprenditori italiani della necessità di dar vita a un nuovo e potente istituto di credito. A questo stato di necessità si accompagnava, almeno per quanto riguarda i dirigenti dell’Ansaldo Pio e Mario Perrone, l’opportunità, fino a quel momento soltanto vagheggiata, di rovesciare il loro «rapporto di sudditanza» verso le banche e, per altri e non meno importanti personaggi, quella altrettanto allettante di liberarsi dalla «tutela» esercitata dalla finanza tedesca.
Quanto ai gruppi finanziari coinvolti nell’iniziativa – da cui peraltro il Banco di Roma rimase escluso –, la situazione creatasi all’indomani della dichiarazione di guerra aveva reso ormai improrogabile la necessità di liberarsi, senza dover palesare perdite troppo gravi, degli enormi immobilizzi che gravavano, a partire dalla crisi del 1907, sui bilanci dei due istituti di credito, trasferendo parte delle attività a società di liquidazione, nonché di realizzare un risparmio non indifferente sui costi generali di esercizio che le nuove succursali richieste dall’operazione di rastrellamento capillare del risparmio avevano incrementato in misura notevole.
Il conflitto mondiale non si limitò soltanto ad imprimere un carattere di urgenza ai motivi che avrebbero indotto quei gruppi industriali e finanziari a fondare la «banca italianissima»; esso sortì effetti notevoli anche per quanto concerne l’azione della finanza e della politica francese nella Penisola, cosicché la Banca Italiana di Sconto nacque, con il modesto capitale iniziale di 15 milioni, in un clima tutt’altro che sereno, che avrebbe finito col condizionarne l’esistenza: la sua fondazione da parte di un coacervo di forze cui il conflitto mondiale aveva offerto obiettivi comuni suonava come una dichiarazione di guerra al maggior istituto di credito ordinario del paese e alle sue alleanze politiche, e tale in effetti si sarebbe rivelata.
Sei mesi più tardi, le trattative per la fusione con la Società italiana di credito provinciale e la Società bancaria italiana andarono in porto. Il nuovo istituto, così come risultava dalla fusione – che aveva portato tra l’altro il capitale a 70 milioni –, costituiva una realtà abbastanza consistente: gli interessi rappresentati nel suo consiglio di amministrazione erano notevoli e la «banca italianissima» risultava legata, a pochi mesi dalla sua costituzione, a molte imprese in quasi tutti i settori industriali.
A partire da tale «piattaforma di lancio» Angelo Pogliani avrebbe dato il via ad una frenetica attività di finanziamenti e partecipazioni industriali che, nel corso del conflitto, portarono la Banca Italiana di Sconto – che nell’aprile 1917 aveva effettuato un nuovo aumento di capitale a 115 milioni – ad affermarsi in tutti i settori, non solo supportando i proprietari dell’Ansaldo e il loro ambizioso progetto di realizzare un sistema verticale integrato che comprendesse tutti gli anelli di una catena che andava dalle miniere alle società di navigazione, ma contendendo contemporaneamente alla Comit il ruolo di principale finanziatrice dell’industria italiana, in un clima «drogato» dalle commesse belliche. Cliente e fornitore d’eccezione, lo Stato fornì infatti le condizioni ideali per una crescita industriale di dimensioni impreviste, peraltro convulsa, che gli organismi preposti alla gestione dell’economia di guerra erano del tutto incapaci di regolare e disciplinare.
La grande occasione rappresentata dalle forniture belliche (che, lo ricordiamo, non si limitavano ad armi, munizioni, corazze, ma coinvolgevano anche l’industria leggera e le produzioni agricole) scatenò, nell’asfittico universo industriale italiano, una frenesia i cui prevedibili risultati (in larga misura deleteri) apparivano peraltro, agli occhi degli stessi protagonisti, tutt’altro che scontati. Tralasciando gli episodi di «pescecanismo» e le centinaia, o magari migliaia, di imprese minori, la guerra sembrava infatti aver spalancato di colpo orizzonti di opportunità sino a quel momento insperati, che ciascuno dei grandi gruppi bancario-industriali italiani aveva tutte le intenzioni di sfruttare a proprio beneficio, perseguendo piani di sviluppo e di integrazione sia verticale sia orizzontale da lungo tempo covati, o magari improvvisati sulla base delle occasioni che via via si presentavano.
Ne scaturirono – com’è noto da studi che risalgono ormai a vent’anni fa – oltre ad alcuni «doppioni» nel campo della siderurgia e della meccanica pesante, la cui contemporanea sopravvivenza in tempo di pace era quantomeno dubbia, e oltre ad una pletora di costosi impianti produttivi di difficile riconversione, anche consistenti progressi tecnici e un certo numero di nuove produzioni, segnatamente nei settori meccanico e chimico, che, indipendentemente dai risultati immediati, rappresentavano un autentico balzo in avanti dal punto di vista tecnologico.
A prefigurare l’intreccio, p...