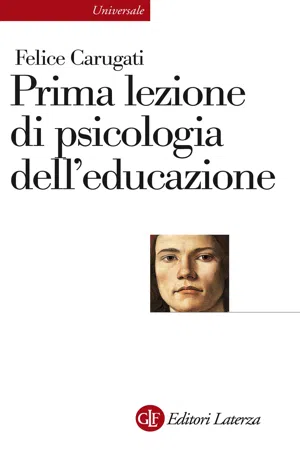Capitolo 1. Dal cervello alla mente
Spesso sentiamo l’esortazione ad abbattere il muro tra psicologia ed educazione, e spesso ci viene ricordato che trovarsi tra queste due discipline è come essere fra Scilla e Cariddi.
Ma di quali mattoni sarebbe fatto il muro? cosa separa Scilla da Cariddi? o, detto in altri termini, se certamente può esistere una psicologia senza educazione, può esistere un’educazione senza psicologia? nel qual caso, a che cosa fa riferimento allora il titolo di questo volume? è forse una decrepita etichetta su un contenitore vuoto, o piuttosto pieno di buon senso, luoghi comuni, ricette della nonna, istruzioni ad uso di genitori disperati o insegnanti disillusi ed esasperati, fra ministri funambolici e bricoleur, dirigenti dirigisti o lassisti, sindacati ‘alla canna del gas’, studenti immersi nel disagio giovanile?
Siamo di fronte ad un’ennesima mission impossible?
Per affrontare questo argomento proponiamo una breve digressione verso il tema della mente, ovvero delle funzioni cognitive specificamente umane, che costituiscono prerequisiti per ogni attività di insegnamento e apprendimento e per ogni ricerca o intervento in campo educativo.
Le neuroscienze: dai risultati ai miti
Da alcuni anni assistiamo ad una produzione accademica raccolta sotto l’etichetta di neuro-educazione8, denominazione che attira ovviamente la nostra attenzione e la cui eco si sta diffondendo anche in settori non specialistici. Si tratta di ricerche sul funzionamento del sistema nervoso grazie ai metodi di documentazione visiva (a colori vivaci ed accattivanti) delle aree cerebrali particolarmente attive durante l’esecuzione di un compito, la risoluzione di problemi, o addirittura quando si chiede ai soggetti di evocare immagini, eventi, concetti, stati emozionali. I diversi colori nelle immagini rappresentano l’attività elettrica, il consumo di ossigeno, il metabolismo del glucosio che si registrano durante le diverse attività.
Si potrebbe quindi temere che gli psicologi, quando utilizzano semplici osservazioni carta/matita, videoregistrano comportamenti, ma anche quando conducono interviste o somministrano questionari, si sentano fuori moda, tagliati fuori dalla ricerca che conta, se confrontati con lo splendore di immagini così sorprendenti per la curiosità anche dei non esperti.
Queste immagini sembrano non soltanto consentire di penetrare nei misteri del cervello, ma hanno anche attivato speranze per le possibili implicazioni nei confronti dell’apprendimento e dell’educazione. Pensiamo ai risultati di indagini internazionali quali quelli di Oecd-Pisa9 sul livello di competenze dei quindicenni, provenienti sia da paesi industrializzati10 sia da paesi considerati (con ironia del tutto inopportuna) da decenni ‘in via di sviluppo’: una quota non trascurabile di questi ragazzi raggiunge livelli poco soddisfacenti nella comprensione approfondita di concetti matematici e scientifici. Non c’è quindi da stupirsi della vivacità del dibattito sul fatto che questi risultati insoddisfacenti siano o meno la conseguenza – nei quindicenni – del non avere ricevuto appropriati stimoli cognitivi durante le fasi critiche dello sviluppo cerebrale.
D’altra parte molti genitori e insegnanti hanno interpretato con entusiasmo i risultati delle ricerche in neuroscienze, come un messaggio secondo il quale i primi tre anni di vita determinano nel futuro l’acquisizione delle abilità cognitive nei bambini e, in particolare, che interventi precoci farebbero diventare adulti di successo i propri figli/alunni. Forse che le porte del successo non potranno schiudersi se il cervello del proprio figlio non riceverà la giusta dose di stimolazioni nei momenti più appropriati? Esistono prove scientifiche che genitori e/o insegnanti siano effettivamente responsabili del successo così come dell’insuccesso intellettuale?
I dati su cui c’è consenso sono i seguenti: un rapido aumento dopo la nascita nel numero di connessioni sinaptiche nel cervello umano e di altre specie animali; l’esistenza di periodi critici nello sviluppo delle funzioni visive e nell’apprendimento del linguaggio. Nel cervello dei ratti, trasferiti da un ambiente meno complesso in un ambiente più complesso, l’aumento del numero di sinapsi è documentato. Nonostante l’interesse per questi risultati, numerosi autori hanno immediatamente messo in guardia dalla diffusione di una nuova mitologia soprattutto fra insegnanti, pedagogisti e politici: dettagliate analisi critiche delle ricerche mostrano che le immagini del cervello sono interpretabili in modo adeguato soltanto se sono integrate, per esempio, con dati derivanti dalla storia dell’apprendimento degli individui. Non a caso già dieci anni fa Kosslyn11 intitolava un suo lavoro con l’interrogativo: se le immagini del cervello sono la risposta, qual è la domanda? Titolo forse paradossale, ma indicativo della sproporzione fra i limiti dei risultati delle ricerche e le attese irrealistiche attivate da una rappresentazione fideistica della scienza.
Ma poiché non riteniamo che le persone di per sé siano credulone, ci domandiamo come si costruiscano questi miti12. Le posizioni più prudenti ipotizzano che ciò succeda quando i risultati di conoscenze specifiche (ognuno ben documentato ma distinto dagli altri) vengono interpretati tutti insieme per trarre la conclusione che i primi tre anni di vita costituiscono un periodo critico, una sorta di organizzatore nel senso psicodinamico del termine, per lo sviluppo del cervello. Questo è il mito: quando dei risultati scientifici sono sovra-interpretati ovvero ipersemplificati da parte di agenti sociali diversi dai ricercatori (mass media, responsabili delle politiche sociali ed educative), oppure (non si può escluderlo) da alcuni degli stessi ricercatori, per ragioni ideologiche o simili.
Fra questi miti, ne citiamo alcuni, che traiamo direttamente da un documento frutto di consenso internazionale fra ricercatori Oecd13. Eccone una sintesi:
Non bisogna perdere tempo: tutto ciò che è importante è deciso entro i tre anni.
Esistono periodi critici durante i quali certe materie devono essere insegnate e apprese.
Nella vita quotidiana noi usiamo soltanto il 10-20% del cervello!
Io sono un cervello sinistro, tu sei un cervello destro!
Credete: ragazzi e uomini hanno cervelli differenti da ragazze e donne!
Un bambino può imparare e padroneggiare soltanto una lingua per volta.
Aumenta la tua capacità di memoria!
Impara mentre dormi!
La cautela nei confronti di questi miti trova riscontro proprio in ambito neuro-scientifico. Il n. 45 del 2009 di «Cortex» ospita un dibattito centrato proprio sul rapporto fra neuroscienze e educazione.
Arriviamo così al centro della nostra riflessione.
Secondo Della Sala14 una percentuale molto elevata di insegnanti inglesi ritiene che conoscere il funzionamento del cervello sia molto importante per progettare interventi educativi o didattici, ma quando poi sono chiamati a illustrare quali siano le relazioni fra neuroscienze ed educazione la risposta è molto generica. Per un insegnante, seduto di fronte ai propri alunni, che utilità può avere sapere che l’ippocampo è implicato nell’apprendimento? Le neuroscienze possono offrire conoscenze utili per la diagnosi di condizioni patologiche associate all’apprendimento, a deficit cognitivi, a problemi di comportamento? Certamente sì. Ma se teniamo conto degli effetti delle etichette neuro, allora è utile esaminare lo stato dell’arte della questione, con tutte le cautele necessarie.
Se è ormai ben documentato il grande entusiasmo per i contributi che provengono dalle ricerche sul cervello, questo entusiasmo viene raffreddato quando si passa frettolosamente a realizzare interventi che abbiano effetti positivi, diretti e immediati sulle modalità d’insegnamento o addirittura sull’adozione di curricula didattici. Dove si è tentato di realizzare questi collegamenti diretti sono state fatte operazioni scientificamente infondate, che hanno dato luogo a insuccessi. Cubelli15 cita un caso verificatosi in alcune scuole inglesi fin dagli anni ’90. All’inizio dell’ora di lezione, o all’inizio della mattinata, gli insegnanti chiedevano ai bambini (si trattava di progetti condotti nelle scuole materne) di muovere alternativamente le gambe e di incrociarle, nella convinzione che l’attività bilaterale alternata favorisse la comunicazione fra gli emisferi cerebrali. Partendo dalla nozione che ogni emisfero cerebrale controlla prevalentemente l’attività motoria delle regioni controlaterali del corpo, sapendo che i due emisferi comunicano attraverso il corpo calloso, si è frettolosamente desunto che l’attività motoria bilaterale favorisse l’attività cerebrale, dunque migliorasse l’efficienza dei sistemi cognitivi. Risultati del tutto deludenti. È vero che gli emisferi cerebrali controllano prevalentemente l’attività senso-motoria delle regioni corporee controlaterali e che comunicano attraverso il corpo calloso, ma non c’è nessun dato che sostenga l’ipotesi secondo cui maggiore è l’attività bilaterale, maggiore è l’efficienza dei processi cognitivi. Ecco un esempio dell’applicazione, peraltro senza risultati effettivi, della cosiddetta ‘ginnastica del cervello’, un’eco moderna di ciò che suggerivano già molti decenni fa insegnanti di grande onestà e rigore a proposito della ‘ginnastica mentale’. Appare quindi opportuno seguire i consigli di chi afferma che è sbagliato (e inutile) credere che il cervello nasconda la ricetta per risolvere i mali della scuola. È sbagliato, cioè, pensare che si possa derivare direttamente da un modello scientifico, da una conoscenza della ricerca di base, un’operatività pratica, un metodo, che in qualche modo prescinda dall’esperienza concreta e dalla capacità professionali dei singoli insegnanti.
Cubelli è ancora più esplicito sulla prudenza. L’autore sostiene che per elaborare nuove strategie educative è molto più importante disporre di una maggiore conoscenza dell’architettura funzionale dei processi cognitivi, piuttosto che di una conoscenza dell’attività del cervello e dei meccanismi neurofisiologici che sono alla base del comportamento.
A questo scopo, Cubelli presenta due esempi circa i modelli della lettura e della memoria.
Dalla psicolinguistica, dalle ricerche sul neuroimaging e dalla neuropsicologia sappiamo che la lettura di parole richiede la trasformazione visiva delle stringhe di lettere in frazioni ortografiche astratte prima di accedere alla conoscenza semantica e fonologica, e cioè il significato – culturalmente condiviso – e la pronuncia della parole scritte.
I modelli più accreditati dell...