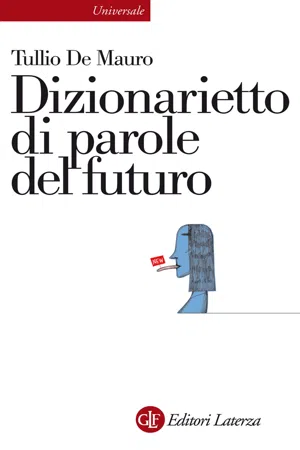
- 132 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Dizionarietto di parole del futuro
Informazioni su questo libro
Neocon, governance, europeità, coaching, empowerment, burnout, flessicurezza, internettaro… I più recenti neologismi che arricchiscono e colorano quotidianamente la nostra lingua, spiegati e interpretati dal maggiore linguista italiano.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Dizionarietto di parole del futuro di Tullio De Mauro in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Cultura popolare. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Cultura popolareDove nascono i neologismi?
[Quello che segue è il testo di una relazione tenuta all’Accademia Nazionale dei Lincei nel corso della Giornata di studio sulla fine dei neologismi, organizzata in collaborazione con il Lessico Intellettuale Europeo il 20 maggio 2005 per celebrare i cento anni della prima edizione del Dizionario moderno di Alfredo Panzini (Hoepli, Milano). La relazione è stata poi pubblicata negli atti del convegno Che fine fanno i neologismi?, curati da Giovanni Adamo e Valeria Della Valle, Olschki, Firenze 2006, pp. 23-32.]
Una domanda così formulata presuppone che sia acquisita la risposta a una domanda preliminare: che cosa intendiamo per neologismo? Si tratta d’una risposta tutt’altro che univoca.
Autorevoli dizionari della terminologia linguistica, da quello di Marouzeau a quelli di David Crystal, inclinano verso quella che pare l’accezione più comune: il neologismo è una parola nuova, in tedesco una Neubildung2. Un simpatico articolo di Enzo Golino, giornalista colto e attento alla linguistica, documenta che questa è la dominante acceptio recepta: un neologismo sarebbe per esempio paesanottismo, parola usata una volta da Andrea Camilleri in un’intervista3.
Non tutti si preoccupano (lo fa giustamente Crystal) di distinguere tra neologismi e nonce words o, come più spesso si dice, occasional words: le parole «di un momento», soltanto «occasionali»4. Ma c’è una disattenzione anche più rilevante. Non tutti includono nella categoria del neologismo, accanto alle neoformazioni, anche le innovazioni di significato5. Curiosamente stanno attenti a menzionare i neologismi di significato non tanto i dizionari specialistici della linguistica, quanto i lessicografi che lavorano, per dir così, sul campo, come Giovanni Adamo e Valeria Della Valle, e alcuni dizionari generali come quelli di Robert o Webster6.
Non è dunque una pedanteria o una banalità accostarsi alla materia cercando anche di introdurre e stipulare qualche precisazione terminologico-concettuale.
Un grande urbanista italiano del Novecento, Luigi Piccinato, nell’introdurre le sue lezioni sul tema città-campagna, amava ricordare: «Tutte le città nascono in campagna». Forse potremmo ripetere il bon mot e dire: «Tutte le parole nascono come neologismi».
Questo va detto almeno per tre motivi.
a) Il primo è cercare di placare l’animo spesso esacerbato di misoneisti e puristi, stirpe antica e tenace, dai tempi di Tucidide e Orazio a oggi.
b) Il secondo motivo è rendere esplicito che la nozione di neologismo non è assoluta, ma è relativa a una data epoca della tradizione di un patrimonio linguistico: accusa è un neologismo del XIII secolo; adesso è un neologismo poco più antico, che ha importato in italiano un ad ipsum, neologismo del latino medievale che sostituiva il classico nunc destinato a morte, anche per ragioni fonologiche, nelle lingue romanze; wida/guida e widare/guidare sono neologismi del latino medievale, passati poi nelle lingue romanze, marginalizzando o azzerando parole come dux, ductus e ducere e loro continuatori diretti. E si potrebbe continuare7. Ricorderò solo che in due lingue venerabili e venerande, da cui le lingue europee moderne hanno attinto a più riprese materiali per quelli che di volta in volta furono neologismi, il latino e il greco, solo il 35 e, rispettivamente, il 39% degli headwords, delle basi lessicali prime, sono di diretta eredità indoeuropea, mentre il 65 e, rispettivamente, il 61% sono costituiti da parole che latini e greci hanno raccattato o inventato attingendo ad altre fonti (e ciò, come può intuirsi, non esaurisce davvero la portata dei neologismi costitutivi delle due lingue, annidati anche entro le parole che riconduciamo all’indoeuropeo). Vi fu un giorno in cui parole bandiera della romanità, miles, orbis, populus, publicus, urbs, suonarono orribilmente neologistiche.
c) Ma soprattutto vi è un terzo motivo di natura teorica. Coglierlo a me pare che ci conduca presso il cuore della cosa: sia nel senso più ristretto del termine, che cercherò di proporre, sia in quello più largo, i neologismi, la produzione di neologismi, sono fisiologia linguistica, non patologia o bizzarria. Essi sono parte profonda e ineliminabile dei processi di innovatività permanente che caratterizzano l’uso che facciamo delle lingue e che le rendono oggetti singolari nell’universo semiotico.
Hanno insegnato Hermann Paul e Hugo Schuchardt, insegnava Saussure, che novations e fluctuations caratterizzano il comprendere e usare produttivamente parole e frasi di una lingua. È ciò che poc’anzi ho provato a chiamare «processi di innovatività permanente». Ma vorrei mettere in chiaro che l’innovatività linguistica si presenta, a me pare, con due grandi aspetti diversi, con la sedimentazione di due ordini di fenomeni e fatti diversi anche se complementari: il primo aspetto e ordine è, per usare un termine generalissimo, quello delle neoformazioni e neosemie, il secondo, cui ho già implicitamente accennato, è quello della obsolescenza.
Credo che si debbano guardare sempre da presso anche i fenomeni di obsolescenza se si vogliono capire i fenomeni di neoformazione. Nel GRADIT, che punta a registrare lessemi italiani che, da qualsiasi secolo provengano, sono in uso nel Novecento, su circa 250.000 lemmi se ne contano poco più di 10.000 qualificati come «obsoleti» in quanto, pur non risultando presenti nei testi novecenteschi spogliati, sono tuttavia registrati tra i 180.000 lemmi del Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia o tra i 150.000 delle opere lessicografiche dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. Questa cifra, pari a circa il 4% del lessico registrato, è puramente indicativa, e del resto è facilmente raddoppiabile se ai lemmi qualificati come obsoleti si aggiungono i circa 10.000 vocaboli qualificati come «letterari» in quanto, pur assenti nell’uso corrente, sono tuttavia presenti nei testi canonici della tradizione letteraria italiana, da aere a speme. Ma il tasso di obsolescenza del lessico è certamente assai maggiore. Per l’italiano potremo stabilirlo meglio quando disporremo di un dizionario storico della lingua. Tuttavia qualche assaggio è possibile se si lavora su una più lunga distanza linguistica. Un esempio: circa il 70% delle parole latine, registrate in un vocabolario del latino classico, non sopravvive in due grandi lingue romanze, come francese e spagnolo. E anche in una lingua assai più latinizzante e rilatinizzata come l’italiano la quota di parole latine scomparse, senza un continuatore diretto, è di poco inferiore al 50%8. Queste cifre sulla obsolescenza ci danno una prima idea complessiva, pur se ancora sommaria, dell’apporto dei neologismi stratificatosi nell’uso attuale delle tre grandi lingue romanze.
Ma non solo perciò vale la pena osservare almeno brevemente l’obsolescenza. Se sulla lunga distanza osserviamo la morte di parole legate a istituti, tecniche, cose del passato, come per bonagium «diritto di fissar limiti a una proprietà», dapifer «ministro di corte incaricato di sorvegliare i cibi», per troppe altre, come nel latino medievale dapsilitas «generosità», momentana «bilancia», placitatio «riserva, condizione di un contratto», regestorium «tesoro» o, stando all’italiano, per aere, boccare, buscatore, carezza «costosità», cetera «chiacchiera, lungaggine», mondia «mondatura», mondificamento «pulizia», nutritura «nutrimento», pappo «pappa», speme ecc., la consueta spiegazione referenzialista non ha basi. Se queste parole sono finite tra gli obsoleti o meramente letterari ciò non è dovuto a scomparsa di referenti o tecniche, come troppo spesso si dice e crede, ma al bisogno linguisticamente autonomo di nuove espressioni, di nuove accessioni sia di morfi sia di accezioni di morfi già esistenti. Se appena il linguista seguisse il consiglio di Ferdinand de Saussure e pensasse «à ce qu’il fait» (e anche a quel che dice), si avvedrebbe che non c’è alcuna scomparsa di referenti o tecniche che abbia determinato la sparizione di parole latine come vir o loquor o di una congiunzione come ut e la loro complementare sostituzione, rispettivamente, con la riarticolazione romanza del significato di homo (da «essere umano» a uomo, homme come «essere umano» e anche «essere umano maschio»), col ricorso al raccontar favole o parabole per dire hablar, parler, parlare, o a congiunzioni nuove, a polirematiche o strutture sintagmatiche diverse per sostituire finali e consecutive con ut. Se salio, salire perde il senso di «ballare» e per «ballare» i romanzofoni attingono a lingue germaniche, mentre salire e continuatori acquistano, a seconda delle aree romanze, i significati di «uscire» in Iberia, di «ascendere» in Italia, non si vedono i fatti esterni che abbiano inciso in ciò: i latinofoni smisero di ballare? I romanzofoni impararono improvvisamente a uscire o a sollevarsi? Non si vuol davvero negare con ciò l’incidenza di fatti esterni nell’uso delle lingue (rinvio per ciò alla non solo scherzosa nota 10), ma esse hanno tali risorse e vincoli sistemici del tut...
Indice dei contenuti
- Nota dell’autore
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- V
- W
- Y
- Appendice
- Dove nascono i neologismi?