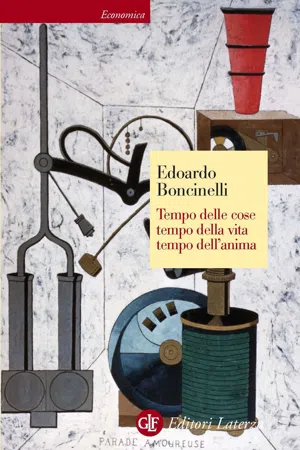I ritmi obbligati del tempo imposto
And what if all of animated nature
Be but organic Harps diversely fram’d
That tremble into thought?
Samuel Taylor Coleridge, The Aeolian harp
1. I tempi della vita e la vita nel tempo
Nell’ambito di qualsiasi riflessione sul tempo il mondo della vita è destinato a giocare un ruolo di primo piano, perché è soprattutto attraverso l’osservazione dei fenomeni biologici che possiamo renderci conto del passare del tempo, e perché la vita si mantiene e si propaga grazie ad una rigida programmazione e quindi una meticolosa gestione del tempo. Nella sua essenza, insomma, la vita scandisce il tempo, ma contemporaneamente lo cattura e quasi lo assoggetta.
Visti dall’esterno i fenomeni biologici ritmano in maniera tangibile il passare del tempo e ne portano una testimonianza bruciante, al punto che quasi sembrano accelerarne il ritmo. Nella vita di tutti i giorni sono gli esseri viventi i più immediati indicatori del trascorrere del tempo e l’evoluzione dei viventi rappresenta una delle più palpabili incarnazioni della sua irreversibilità. Quello della vita nel suo complesso si configura, insomma, come un tempo lineare e aperto.
Ma vista dall’interno, a livello dei singoli organismi e delle loro cellule, la vita si presenta come un complesso di eventi ciclici controllati da meccanismi a orologeria accuratamente regolati su scale temporali e ritmi diversi. Realtà finite nel tempo e nello spazio, gli organismi viventi non possono infatti che essere sede di eventi ciclici. La loro permanenza è anzi legata alla regolarità di tali cicli. È inutile far notare che questi servono anche a marcare il tempo biologico. Se possiamo pensare, abbiamo visto, un orologio come la combinazione di un oscillatore ciclico e di un contatore, ciascun essere vivente ne rappresenta l’incarnazione. I fenomeni vitali formano così un tutt’uno con il tempo e il suo trascorrere.
La vita è una realtà molto particolare. È il regno della singolarità; e anche le sue regolarità non hanno una validità universale. Solo una piccola porzione dell’universo la ospita, per quanto ne sappiamo, ma ciò non significa che non abbia senso studiarla, per se stessa e in relazione al resto dell’universo fisico. Oggi si è tutti convinti che gli esseri viventi sono entità materiali costituite di altre entità materiali che obbediscono alle leggi della fisica e della chimica. La peculiarità del vivente va quindi colta nel particolare modo di essere degli organismi viventi, tenendo presenti le condizioni nelle quali si sviluppano, prima fra tutte la gamma delle temperature. Gli esseri viventi possono esistere solo in un ristretto ambito di temperature e per quelli superiori l’ambito è ancora più ristretto. Non ha senso una vita a –100° C, né a +200° C. La biologia è una fisica degli oggetti estesi esistenti a temperature che si aggirano intorno ai 37° C.
Si tratta di un intervallo di temperature piuttosto angusto e spostato verso il basso. Il limite inferiore delle temperature, il cosiddetto zero assoluto, si trova appena 273° C sotto lo zero della nostra scala. La vita deve essere quindi considerata un fenomeno caratteristico delle basse temperature, con tutto quello che ne consegue: in primo luogo l’esistenza di stati di aggregazione di una certa dimensione e in secondo luogo la loro relativa permanenza nel tempo. Una temperatura molto più alta non avrebbe infatti permesso la formazione di aggregati di dimensione comparabile, se non per intervalli di tempo molto ridotti. Una conseguenza di tale permanenza è la possibilità di assegnare un certo grado d’identità agli oggetti viventi. Solo entità di una certa dimensione e dotate di un certo grado di permanenza possono mostrare un’identità. Abbiamo appena visto che le particelle elementari subatomiche non ne hanno alcuna. E non invecchiano. Per invecchiare occorre avere un’identità e attraversare un certo numero di campi temporali. Solo gli oggetti estesi possono farlo, e altri oggetti estesi e permanenti possono registrarlo. La vita nel suo complesso può essere vista come un gigantesco esperimento di fisica: un esperimento spontaneo, quasi isotermo e sufficientemente lento, che dura da circa quattro miliardi di anni.
Possiamo definire un essere vivente come un’entità fisica limitata nel tempo e nello spazio; costituita di materia organizzata secondo specifici criteri definiti e controllati dal suo patrimonio genetico, o genoma; capace di mantenersi tale metabolizzando materia ed energia, di riprodursi e di evolvere.
Come è chiaro, la parola chiave è organizzazione. Gli organismi viventi mostrano una particolare forma di organizzazione della materia, imperniata primariamente su quella straordinaria struttura biologica che è la cellula. Tutti gli esseri viventi sono costituiti di cellule, una o molte più di una. La cellula rappresenta la struttura biologica fondamentale del vivente, ma non è l’unica. Ne esistono molte altre. Potremmo anzi dire che una delle caratteristiche salienti della materia vivente è quella di articolarsi su vari piani e su vari livelli di organizzazione. Esiste infatti il livello delle molecole e delle macromolecole, quello degli organelli cellulari, quello delle cellule, quello dei tessuti, quello degli organi, quello degli apparati e dei sistemi, quello degli individui, quello dei gruppi sociali, quello delle popolazioni e delle specie, quello delle comunità più o meno estese, quello degli ecosistemi e infine quello della biomassa del complesso degli organismi viventi presenti sulla Terra.
Tali piani o livelli di organizzazione non rappresentano solo entità materiali caratterizzate da scale dimensionali diverse – come potrebbero essere i pianeti, i mari e le terre emerse, le montagne o le rocce – ma corrispondono a corpi relativamente chiusi e relativamente autonomi legati nondimeno l’uno all’altro da un rapporto gerarchico di implicazione. Non può esistere infatti un organo senza cellule o una specie in assenza di organismi, ma una cellula non è neppure pensabile senza le altre, così come un individuo senza compagni di specie o una specie che popolasse da sola il nostro pianeta. Le entità appartenenti ai livelli superiori raggiungono inoltre una stabilità, e quindi una durata nel tempo, superiore a quella delle entità dei livelli inferiori: l’organismo vive più a lungo della singola cellula, la specie sopravvive agli individui e la biomassa nel suo complesso trascende di gran lunga le singole specie.
«Organizzazione» deriva da òrganon, strumento. Uno strumento serve ad uno scopo, cioè a compiere una funzione. È evidente che gli esseri viventi sono composti di parti che compiono una funzione, hanno cioè uno scopo determinato. Come se ci fosse negli organismi un disegno o un piano di lavoro che li porta (loro e le loro parti) a compiere azioni che hanno uno scopo e che appaiono finalizzate in ultima istanza alla loro sopravvivenza e riproduzione. Il concetto di organizzazione è allora indissolubilmente legato a quello di funzione. I sassi, le nuvole, le montagne non hanno una funzione, esistono e basta, anche se possono subire delle trasformazioni drammatiche. Al contrario una cosa ha una funzione quando possiamo individuare un’azione per l’esecuzione della quale la sua presenza è particolarmente utile, necessaria o indispensabile. Questa definizione si attaglia perfettamente agli strumenti che l’uomo utilizza, ma può essere facilmente estesa agli organismi viventi e alle loro parti. Mentre una pietra o un mucchio di sabbia non hanno di per sé una funzione, l’antenna di un insetto serve ad esplorare l’ambiente circostante e la membrana cellulare serve a isolare e proteggere il contenuto della cellula. Le varie parti costituenti gli esseri viventi possono essere definite e caratterizzate in base alla loro funzione. Spesso siamo anzi portati a identificare un organo o una sua parte con la funzione da loro svolta.
Più complesso appare definire le parti di un organo. Per nostra fortuna, anche quando queste non sono anatomicamente isolate e delimitate con chiarezza, spesso lo sono funzionalmente. In tali casi si parla di una struttura biologica, intesa come un insieme di elementi contigui e collegati tra di loro che possono essere ritenuti congiuntamente necessari per compiere una funzione. Un tubulo renale, un villo intestinale, un alveolo polmonare, lo stoma di una foglia, ma anche un singolo recettore presente sulla membrana di una cellula sono altrettante strutture biologiche. È anche qui la funzione che definisce qualcosa, nella fattispecie una struttura. I vari elementi di una struttura biologica sono in continua trasformazione e si definiscono proprio nell’espletamento di una data funzione. Possiamo infatti spesso considerare una struttura non come una realtà statica e definita, ma come una sezione temporale di una funzione o di un complesso di funzioni, alla stregua di un fotogramma ideale estratto da un filmato. Siamo portati a pensare che esistono nel nostro corpo delle strutture biologiche che compiono specifiche funzioni, ma moltissime di queste sono state individuate attraverso le funzioni che compiono e sarebbe quindi più opportuno parlare di funzioni biologiche che per poter essere esercitate si appoggiano a certe strutture.
L’organizzazione non si esaurisce in un complesso di funzioni, e quindi di strutture funzionali. Oltre a quello di funzione occorre richiamare anche il concetto di correlazione. Proprio in virtù dell’elevato grado di organizzazione, le varie parti di una struttura biologica o di un organismo non vivono di vita autonoma. La struttura, la localizzazione e il modo di funzionare di una data regione corporea sono determinati e rifiniti tenendo conto dell’esistenza e delle proprietà delle altre parti. La relativa indipendenza di un organismo dalle condizioni dell’ambiente circostante è raggiunta proprio attraverso l’interdipendenza delle sue parti.
Il grado di correlazione si può misurare e corrisponde bene alla nostra immagine intuitiva di una delle caratteristiche fondamentali di un essere vivente. È inutile che questo contenga un cuore funzionante se non possiede al tempo stesso un polmone che operi in una data maniera, come è inutile che contenga i muscoli se non ci sono nervi capaci di regolarne la contrazione o il rilassamento. Gli esempi si potrebbero moltiplicare, ma il concetto è abbastanza chiaro: un organo e ancor più un organismo sono composti di parti che esplicano precise funzioni e che sono disposte e organizzate in modo da armonizzare il loro operato con quello di tutte le altre. Questa rappresenta una buona definizione di organizzazione in generale. A qualsiasi livello, naturale o sociale, individuale o collettivo, l’organizzazione va poi creata e soprattutto mantenuta. Noi sappiamo che gli esseri viventi la instaurano sulla base delle istruzioni del loro genoma e la mantengono degradando in continuazione l’energia catturata dall’ambiente. Quando il gioco non riesce più sopravviene la morte.
In aggiunta a tutto questo gli esseri viventi evolvono. Il concetto di evoluzione rappresenta il maggiore contributo concettuale portato dalla biologia alla cultura scientifica, se non alla cultura in generale. Lo studio dell’evoluzione dei viventi e della storia geologica del nostro pianeta ci ha costretto a prendere atto dell’enormità della scala dei tempi che ci hanno preceduto e dell’irreversibilità degli eventi. Le idee di evoluzione, di storia naturale e di irreversibilità si sono poi estese alla nostra visione dell’intero universo. Secondo la fisica attuale anche l’universo ha una storia e si è evoluto, anche se la scala dei tempi di questa evoluzione è ancora maggiore. Ad un certo punto, almeno in questo angolo dell’universo, si è originata la vita che ha attraversato numerose vicende e ha portato ad organismi abbastanza diversi. Nessun evento biologico viola alcuna legge della chimica e della fisica ma, all’interno di questa cornice normativa obbligata, l’evoluzione biologica ne ha veramente provate di tutte e ha compiuto un numero di scelte frequentemente arbitrarie. Molte cose potevano essere come sono, ma potevano anche andare in tutt’altra maniera. Nella sua evoluzione la vita rappresenta un’incessante esplorazione del regno del possibile.
Vita e tempo, quindi, s’intrecciano e si confondono, ma per ragioni espositive è opportuno distinguere almeno due diverse maniere di considerare il tempo rispetto alla vita. Da una parte ci sono i fenomeni temporali più o meno direttamente connessi con la vita; dall’altra c’è il fenomeno dell’evoluzione biologica come vivente illustrazione dell’irreversibilità degli eventi.
2. Un’identità e una permanenza faticosamente mantenute
Se c’è una caratteristica universalmente riconosciuta agli esseri viventi è quella della loro costanza nel tempo, nonostante essi seguano una propria dinamica interna con cui attraversano un certo numero di fasi e possono andare incontro ad innumerevoli vicissitudini. Ciò li differenzia nettamente dagli oggetti inanimati. Prendiamo in considerazione un sasso. Se non intervengono grandi cambiamenti delle condizioni fisiche circostanti, questo rimarrà intatto e simile a se stesso per anni e anni. Se poi ne analizziamo in dettaglio la composizione chimica o la disposizione dei gruppi di atomi al suo interno, vediamo che anche tutto ciò si mantiene costante, almeno a grandi linee. Un sasso è un elemento fisso e stabile della realtà terrena, costituito nel tempo dalle stesse componenti fisse e stabili. E tali sono tutti o quasi gli oggetti inanimati del mondo.
Non così gli esseri viventi, che sono in primo luogo la sede di un’incessante attività, autonoma e sostenuta nel tempo. Si può notare del movimento anche nel caso degli oggetti inanimati, ma si tratta di movimenti passivi. Gli esseri viventi invece si muovono, si agitano o agitano alcune loro parti, senza interruzione, utilizzando l’energia della quale si approvvigionano continuamente. Questa loro attività è finalizzata per la maggior parte a mantenersi vivi e sostanzialmente simili a se stessi, una certa porzione a moltiplicarsi e un’altra porzione a trasformare l’ambiente che li circonda. La caratteristica fondamentale di un essere vivente è appunto quella di essere il luogo di una grande attività, senza per questo perdere la propria identità, anzi allo scopo di mantenerla, per quei minuti o per quegli anni che durerà la sua esistenza.
Se osserviamo gli esseri viventi procedendo dall’esterno verso l’interno, possiamo notare una costanza della forma complessiva, del modo di reagire ai cambiamenti delle condizioni ambientali e di un complesso ordinato di strutture interne. Le cellule di tutte le specie hanno in comune un certo numero di aspetti microstrutturali, anche se al livello dell’organismo esistono anche delle chiare differenze fra una specie e l’altra. I diversi individui di ciascuna specie sono riconoscibili proprio in base al complesso di queste proprietà. È notevole la rigida determinazione di queste caratteristiche, come è interessante notare che un assetto microstrutturale più o meno costante è necessario per sostenere un complesso costante di funzioni che sono a loro volta richieste per mantenere costante l’assetto microstrutturale che le sottende. È proprio questa costanza assicurata a doppia mandata che colpisce chiunque osservi attentamente un essere vivente.
Tale costanza richiede chiaramente un lavoro di manutenzione ordinaria e un lavoro di manutenzione straordinaria. Quest’ultimo è il più facile da osservare: le cellule e gli organismi pluricellulari sono in grado di riparare molti dei danni che può aver loro procurato l’ambiente nonché di sostituire alcune loro parti. Quando si cominciarono a studiare e a misurare certe caratteristiche interne, ci si accorse che la cellula o l’organismo tendono a mantenerle il più possibile costanti, indipendentemente dalle variazioni esterne. Questa costanza dell’ambiente interno, detta anche omeòstasi, è una delle caratteristiche più significative e discriminanti dei viventi. La quantità di ossigeno o di zuccheri presenti nel sangue, la fluidità di questo, la sua acidità, la sua salinità, fino alla concentrazione di ioni dei vari elementi presenti all’interno di ogni singola cellula sono mantenute costanti, nei limiti del possibile, mediante meccanismi microscopici e macroscopici di controllo e di mantenimento. Se nel sangue c’è troppo zucchero, si attivano alcuni meccanismi che accelerano la sua utilizzazione da parte delle cellule dell’organismo. Se ce n’è troppo poco, altri meccanismi fanno sì che ne diminuisca il consumo da parte delle cellule del corpo. Se la pressione del sangue è troppo alta, la si fa scendere. Se è troppo bassa, si opera in modo da farla risalire. Tutti questi meccanismi sono detti genericamente omeostatici perché contribuiscono a mantenere l’omeòstasi dell’ambiente interno.
Per molti anni la fisiologia si è dedicata allo studio di questa costanza e dei meccanismi che la assicurano, offrendoci affascinanti spiegazioni di come questi intervengano. A partire da un certo momento alla fisiologia si è affiancata la biochimica e successivamente la biologia molecolare, e la comprensione di questa costanza si è estesa al livello subcellulare e molecolare. Così ci si è resi conto che l’attività che caratterizza le varie parti di un organismo accompagna e sostiene la sostituzione di tutte le componenti – usurate, danneggiate, ma anche perfettamente efficienti – delle varie cellule e quindi dell’intero organismo. Per mantenersi identico a se stesso ogni organismo deve sostituire incessantemente la maggior parte delle sue molecole. A differenza di quelli di un sasso o di un gessetto, gli atomi di carbonio, di idrogeno, ossigeno, azoto, calcio o magnesio, di cui siamo composti, non sono gli stessi di un mese fa, anche se si trovano nelle stesse identiche posizioni all’interno delle stesse molecole e delle stesse strutture biologiche. Gli esseri viventi quindi non si limitano a rimpiazzare alcune loro parti per un processo di manutenzione e riparazione straordinaria, ma sono anche il luogo di un incessante ricambio di atomi e di molecole che investe ogni loro struttura. Sono la sede di un continuo flusso di materia, oltre che di energia. La loro è quindi un’identità mantenuta e perpetuata attraverso una continua trasmutazione.
La costanza del sasso e il mantenimento della sua identità sono fenomeni spontanei che non richiedono nessuna attività e per la verità nemmeno una spiegazione. Semmai è da spiegare che cosa sia avvenuto nei casi in cui questa identità risulti alterata. L’identità del vivente invece deve essere spiegata: occorre dire, cioè, come sussiste e come si mantiene. Dietro il mantenimento di questa identità ci deve essere una regia, una permanenza di livello superiore e di natura più sottile. Oggi sappiamo che questa regia è rappresentata dalla lettura e dalla messa in pratica delle istruzioni contenute nel patrimonio genetico presente nel DNA di ciascuna cellula. L’identità di un essere vivente risiede nel suo patrimonio genetico, e il suo mantenimento richiede tutte quelle microstrutture e quei meccanismi che lo consultano e che ne mettono in continuazione in atto le istruzioni.
Il patrimonio genetico, o genoma, è quel complesso di istruzioni biologiche che ad ogni generazione passano di padre in figlio e che fanno sì che i figli siano simili ai padri e alle madri, ma che contribuiscono anche, giorno per giorno, se non minuto per minuto, a tenere in vita e a fornire di una precisa identità le cellule e l’organismo pluricellulare che le contiene. In qualsiasi istante partono dal DNA contenuto nei cromosomi delle cellule tutte quelle istruzioni che fanno di un gatto un gatto e di una felce una felce. È inteso che questa conversazione fra la singola cellula e il suo genoma, o fra le varie cellule e il loro genoma, deve aver luogo senza interruzione, deve toccare tutti i temi vitali e deve avere come conseguenza la pronta messa in atto dei provvedimenti suggeriti dal patrimonio genetico. L’identità biologica di specie deriva quindi dall’attuazione di una lista di istruzioni e questa si realizza attraverso un’incessante interrogazione e consultazione delle stesse. Un essere vivente non permane identico (o quasi identico) a se stesso per inerzia, ma attraverso un’alacre attivit...