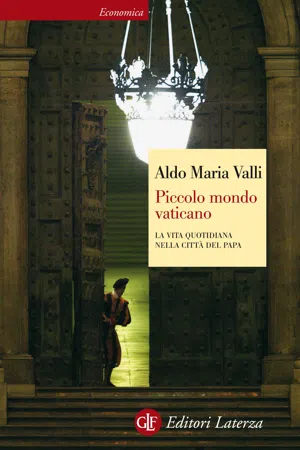Mondo piccolo
Dentro il villaggio Secondo il giornalista inglese John Cornwell fu monsignor Paul Marcinkus a definire il Vaticano «un villaggio di lavandaie». È un mondo piccolo, anzi piccolissimo, con i relativi pregi e difetti. E fra i secondi c’è la tendenza, da parte degli abitanti, a voler sapere tutto di tutti.
Comunque sia, un villaggio, per vivere, ha bisogno di alcune strutture. E il Vaticano non fa eccezione.
La farmacia Aperta nel 1874 per volontà del segretario di Stato Giacomo Antonelli e affidata al frate Eusebio Ludvig Fronmen, già direttore della farmacia dell’ospedale San Giovanni di Dio sull’Isola Tiberina, la farmacia vaticana nacque per garantire il rifornimento di medicinali a papa Pio IX, che dopo la presa di Porta Pia si era dichiarato prigioniero in Vaticano.
Se, entrando da porta Sant’Anna, si va all’Ufficio permessi per farsi registrare, si vede che la maggior parte dei visitatori si trova lì proprio per andare alla farmacia oppure ne viene via portando sacchetti bianchi, rigorosamente privi di ogni forma di pubblicità.
Per accedere al negozio occorrono un documento d’identità, la ricetta medica relativa al farmaco da acquistare e una buona dose di pazienza, perché spesso si formano code (regolate da un conta-persone).
Considerata la più frequentata al mondo, con circa duemila presenze al giorno, la farmacia è affidata ancora oggi all’ordine ospedaliero dei Fatebenefratelli fondato da san Giovanni di Dio e vi lavorano a pieno ritmo più di quaranta persone, quasi tutti laici.
Tanto successo è dovuto al fatto che nel suo negozio si trovano prodotti non in vendita in Italia, oppure che sul territorio italiano, a causa di più complessi meccanismi di autorizzazione, vengono messi in vendita qualche tempo dopo. Inoltre, grazie alla mancanza di tasse, i prezzi sono più bassi rispetto all’Italia. In media un dodici per cento in meno, ma per i prodotti da banco la differenza è del venti per cento e del venticinque per cento per integratori, vitamine e prodotti dietetici. Richiestissima è l’aspirina americana: se in Italia venti compresse costano poco meno di cinque euro, in Vaticano con cinque euro ne compri centrotrenta.
Ovviamente non è il caso di rivolgersi alla farmacia vaticana per il viagra, così come per contraccettivi e farmaci abortivi. Questi prodotti, per evidenti ragioni morali, lì non si trovano. Pare invece che il farmaco più richiesto sia un lenitivo per emorroidi non disponibile in Italia. Inoltre la farmacia vende, a prezzi imbattibili, i cosmetici delle migliori marche, e la richiesta è talmente alta da avere spinto i responsabili a un ampliamento dei locali per destinare uno spazio apposito proprio ai prodotti di bellezza.
Tranne che a Roma e provincia, i farmaci vengono spediti anche a domicilio: basta fare richiesta via email o via fax.
Fare la spesa In Vaticano c’è anche un supermercato che assomiglia moltissimo a quelli che sono in funzione in tutte le nostre città. È solo un po’ più piccolo. Ci si entra con un carrello, si prendono i prodotti dagli scaffali e si paga alla cassa. Come spesso succede nei supermercati, anche in quello vaticano ci sono problemi di parcheggio, e quando devi caricare sulla macchina sacchetti e scatoloni, bottiglie d’acqua minerale e pannolini, succede che qualcuno, a bordo di un’altra auto, stia lì a guardarti, senza nascondere l’impazienza, in attesa che tu te ne vada. Nel supermercato vaticano, posto in un edificio non lontano dalla tipografia, possono entrare i cittadini, i residenti e i soliti amici degli amici. Per accedervi occorre mostrare una tessera, dopo di che tutto avviene come negli altri megastore. La merce in vendita è di ottima qualità e i prezzi, per la nota mancanza di tasse, molto concorrenziali rispetto a quelli praticati pochi metri più in là, in Italia.
Nel supermercato si trova di tutto: carne, pesce, frutta, verdura, salumi, latte, burro, uova, pane, pasticceria, surgelati, gelati, bibite, succhi di frutta, prodotti per la casa, piccoli elettrodomestici. In particolari periodi ci sono offerte ancora più vantaggiose del solito, e così a Natale ecco panettoni e torroni, e a Pasqua uova di cioccolata e colombe. Il reparto alcolici è fornitissimo: vini, spumanti, birra e una nutrita rappresentanza di liquori e whisky.
Vedere un monsignore fare la spesa è un evento rarissimo. L’incombenza è lasciata ai collaboratori laici. Numerose sono invece le suore di vari ordini religiosi, che scelgono ogni prodotto con cura e riempiono i loro carrelli come brave massaie. Arrivano da uffici e abitazioni che si trovano dentro le mura, oppure da palazzi vaticani che stanno fuori ma fanno comunque parte della Santa Sede.
Il supermercato non è tuttavia l’unico luogo in cui è possibile fare la spesa in Vaticano. Per l’abbigliamento, l’oggettistica, gli orologi, l’elettronica e i tabacchi c’è un grande negozio nei locali della stazione ferroviaria, e anche in questo caso si tratta di prodotti di altissima qualità. Il meccanismo di ammissione e ingresso è lo stesso, ma qui l’atmosfera è più tranquilla e ovattata.
Le poste Dopo la costituzione della Città del Vaticano in seguito ai Patti lateranensi, una delle prime preoccupazioni dei responsabili vaticani fu quella di dotarsi di un servizio postale autonomo, che incominciò a funzionare il 1° agosto del 1929. In questo modo, dopo circa sessant’anni di interruzione in seguito alla dissoluzione dello Stato pontificio nel 1870, la Santa Sede poteva tornare a essere collegata con il resto del mondo attraverso un proprio servizio postale, erede degli antichi cursores o viatores apostolici che avevano funzione di araldi e portaordini.
Il primo ufficio postale ebbe sede nel torrione di Niccolò V (che oggi ospita l’Istituto per le opere di religione) e qui rimase fino al 1933, quando fu trasferito in una palazzina appositamente costruita sulla via del Belvedere, a poca distanza dall’ingresso di porta Sant’Anna. Sopraelevato nel 1962, l’edificio svolge ancora il suo compito ed è aperto al pubblico al piano terra.
Le poste vaticane svolgono tutte le operazioni ordinarie, con esclusione dei servizi bancari relativi a risparmi e conti correnti. Tre sono le succursali: due ai lati di piazza San Pietro e una nei Musei vaticani, dove si trovano anche le buche per spedire la corrispondenza. Le tariffe per l’affrancatura sono le stesse in vigore in Italia, ma lettere e buste destinate al papa, se spedite dagli uffici postali vaticani, non hanno bisogno di affrancatura.
Parlare di poste vuol dire occuparsi anche di francobolli e, come si sa, quelli vaticani sono particolarmente appetiti dai collezionisti, così come le monete. Il servizio filatelico e numismatico ha diversi punti vendita: in piazza Pio XII, in piazza Santa Marta e presso i Musei vaticani. Esiste poi un punto vendita nella Libreria internazionale «Paolo VI», che si trova a Roma in via di Propaganda, nei pressi di piazza di Spagna.
Dal 1929 a oggi le emissioni filateliche vaticane si sono succedute regolarmente. Tra i francobolli più recenti, quelli per i sessant’anni di sacerdozio di Benedetto XVI, per la Giornata mondiale della gioventù di Madrid 2011 e per i centocinquant’anni dell’«Osservatore Romano».
La stazione A proposito di stazione, va ricordato che il «villaggio» possiede anche una ferrovia. È lunga solo ottocento metri, ma la sua storia è interessante.
L’articolo 6 dei Patti lateranensi prevedeva che l’Italia avrebbe dovuto costruire una stazione ferroviaria all’interno del Vaticano e metterla in collegamento con la rete esterna attraverso la vicina stazione di San Pietro. L’area fu individuata alle spalle del palazzo del Governatorato, ma prima di procedere furono necessari faticosi lavori di sistemazione del terreno per portarlo alla stessa quota (trentotto metri sul livello del mare) della ferrovia italiana. Oltre alla stazione, il Regno d’Italia realizzò anche un viadotto, e nell’aprile del 1932, esattamente tre anni dopo il via dei lavori, la prima locomotiva entrò in Vaticano per il collaudo del tracciato.
Gli ingegneri furono più rapidi di politici e burocrati. Soltanto il 12 settembre 1934 avvenne infatti lo scambio delle ratifiche della convenzione ferroviaria fra Santa Sede e Italia, e fu necessario attendere il 2 ottobre 1934 perché il ministero dei Lavori pubblici potesse consegnare la ferrovia ai rappresentanti vaticani.
Quando fu costruita la stazione si immaginava che sarebbe stata utilizzata soprattutto per il traffico passeggeri e che anzi sarebbe stato quello il primo luogo incontrato dai visitatori illustri arrivando in Vaticano. Così si largheggiò in marmi e decorazioni, ma in realtà le cose andarono diversamente. Dai tempi di Pio XI a oggi la stazione è stata usata quasi esclusivamente per il traffico merci, e in misura sempre minore, dato che il trasporto su gomma è diventato più rapido e conveniente. Lo stesso papa Ratti, che in seguito alla Conciliazione con il Regno d’Italia volle il collegamento ferroviario, non viaggiò mai in treno.
Una data importante è quella dell’11 aprile 1959, quando dalla stazione ferroviaria vaticana partì un convoglio speciale messo a disposizione della Santa Sede dalle Ferrovie italiane per la traslazione a Venezia della salma di Pio X, mentre per vedere un pontefice salire su un treno in partenza fu necessario aspettare il 4 ottobre 1962, quando Giovanni XXIII incominciò così il suo pellegrinaggio a Loreto e ad Assisi per mettere sotto la protezione della Madonna l’imminente Concilio Vaticano II. Quella mattina il convoglio partì alle 6.30 e il viaggio fu una festa. Ovunque il papa, lungo il percorso, venne accolto e salutato da folle gioiose. La prima sosta in territorio italiano fu alla stazione Tiburtina, dove sulla carrozza papale salì il presidente del Consiglio, Amintore Fanfani.
In tempi più recenti, la piccola stazione vaticana è tornata agli onori della cronaca il 24 gennaio 2002, quando Giovanni Paolo II è salito in treno per recarsi ad Assisi, in occasione della giornata di preghiera da lui voluta per la pace nel mondo, mentre nel 1985 papa Wojtyła, al rientro da un viaggio pastorale, arrivò in Vaticano in treno a causa delle forti nevicate che colpirono il centro Italia e resero impraticabili le strade.
Nel dicembre del 1999 il visitatore accolto in stazione fu di notevoli dimensioni: un abete alto ventiquattro metri, proveniente dalla Repubblica Ceca e destinato ad abbellire piazza San Pietro per le festività natalizie.
A dimostrazione del fatto che la ferrovia vaticana funziona pochissimo (gli scambi sono ancora oggi a mano), la Città del Vaticano non possiede materiale rotabile e alle sue dipendenze non ci sono ferrovieri, ma nel giugno del 2005 un treno speciale, partito dalla stazione Termini di Roma con destinazione finale la stazione vaticana, ha trasportato cinquecento ferrovieri italiani per un’udienza con Benedetto XVI.
Visto che stiamo parlando di trasporti, spendiamo una parola anche sull’eliporto vaticano, realizzato nel 1976 durante il pontificato di Paolo VI, primo papa viaggiatore dell’era moderna. Situato nei giardini vaticani, tra la torre di San Giovanni e le mura, in posizione elevata per favorirne la visibilità, occupa un’area paragonabile a quella di un campo di basket. È usato di norma per i viaggi del papa in Italia, per i suoi spostamenti dal Vaticano agli aeroporti di Roma e per i brevi trasferimenti da e per la residenza di Castel Gandolfo. Il papa tuttavia non possiede un suo elicottero, ma utilizza di norma un apparecchio messo a disposizione dall’Aeronautica militare italiana.
Scuole & bambini In Vaticano non ci sono scuole, ma c’è un seminario. Anzi, un preseminario. È intitolato a san Pio X ed è definito come «Istituto di orientamento vocazionale». Voluto da Pio XII nel 1956, ospita una trentina di ragazzi dagli undici ai diciassette anni che, inviati dalle loro diocesi, frequentano scuole private di Roma e vengono preparati a una possibile scelta sacerdotale. Se davvero la vocazione matura in loro, dopo la scuola media i giovani sono avviati alla formazione nei normali seminari diocesani.
Oltre che nello studio, gli alunni sono impegnati, come ministranti, nel servizio liturgico all’interno della basilica di San Pietro. In pratica fanno i chierichetti per le moltissime funzioni religiose che ogni giorno, fin dalle prime ore del mattino, si tengono nella basilica e nelle Grotte vaticane.
Non è una vita facile. Gli orari sono proibitivi e l’impegno richiesto è altissimo. La sveglia è alle 6.20, e alle 7 in punto i ministranti devono essere pronti, con la veste e la cotta in perfetto ordine, per assistere nella celebrazione preti che arrivano da tutto il mondo. Ai più bravi può succedere di assistere importanti cardinali o il papa stesso.
Fu un sacerdote di origine comasca, don Giovanni Folci, a dare inizio al preseminario portando a Roma alcuni giovani valtellinesi. Era il gennaio del 1956 e da allora nell’istituto sono passati circa settecento giovani di tutta Italia.
Quando, in estate, gli alunni del preseminario tornano in famiglia per le vacanze, vengono sostituiti da ragazzi di quinta elementare e prima media disposti a vivere una vacanza certamente alternativa: anziché andare al mare o in montagna, trascorrere una ventina di giorni in Vaticano per servire messa. In genere sono i vescovi e i parroci a segnalare i ragazzi desiderosi di fare questa esperienza, e pare che le domande non manchino.
Come tutti i ragazzini, anche i chierichetti del Vaticano hanno voglia di giocare, e così può capitare di vederli improvvisare partite a pallone vicino ai palazzi o ai giardini vaticani, sotto l’occhio attento ma anche divertito dei gendarmi.
A proposito di bambini, può capitare di vederne qualcuno girare in bicicletta. Com’è possibile? Si tratta dei figli di alcune guardie svizzere che in Vaticano vivono con le loro famiglie. Le guardie, al momento del reclutamento, devono essere celibi, ma una volta raggiunto il grado di caporale possono sposarsi, e non è raro che preferiscano avere la famiglia con sé, in Vaticano, piuttosto che in Svizzera. Così ecco spiegata la presenza di bambini, anche molto piccoli, i quali comunque, per frequentare asili e scuole, devono recarsi... a Roma.
Il traffico La Città del Vaticano da qualche secolo non è più nel mirino di invasori reali o potenziali, ma è comunque sotto assedio. Piccola com’è, accoglie ogni anno più di due milioni e duecentomila persone per le varie cerimonie che vi si celebrano, alle quali occorre sommare quattro milioni e mezzo di persone che si recano in visita ai musei e più di quattro milioni di visitatori che salgono alla cupola di San Pietro. Anche se il meccanismo è ben oliato, ricevere tutti è una sfida quotidiana.
Un problema è poi quello delle auto. Sebbene sia un’enclave, il Vaticano è pur sempre dentro la città di Roma. Dire Roma vuol dire, fra le altre cose, traffico, e di traffico è malato anche il piccolo Stato del papa. Le cifre sono impressionanti. Nel corso del 2010 hanno oltrepassato le mura leonine più di due milioni di automobili, circa seimila al giorno. Francamente troppe. Il che ha spinto le autorità vaticane a introdurre norme restrittive. Ora la nuova legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso, firmata da Benedetto XVI, prevede infatti che l’ingresso su quattro ruote sia consentito solo per esigenze valide documentabili.
Oltre a quelle personali dei cardinali e degli altri cittadini, residenti o dipendenti, in Vaticano circolano ovviamente varie auto ufficiali, a disposizione del papa, del segretario di Stato e degli altri rappresentanti delle alte sfere. Il garage è suddiviso in tre sezioni: pontificio, nobile e di servizio. Il primo comprende auto di rappresentanza particolarmente esclusive, magari vecchiotte ma conservate in perfette condizioni, anche perché percorrono distanze sempre limitatissime. Il secondo custodisce vetture importanti ma un po’ meno prestigiose. Nel terzo si trovano quelle che servono tutti i giorni per le varie necessità dello Stato.
L’autoparco vaticano è collocato nella zona «industriale» della Città del Vaticano, verso le mura che si affacciano su piazza Risorgimento. Quando fu costruito, tra il 1956 e il 1957, durante gli scavi venne alla luce una necropoli romana di quasi trecento metri quadrati, a conferma del fatto che la zona del Vaticano era usata anticamente soprattutto come cimitero.
Da quel che si sa, è dal 1909 che in Vaticano esistono automobili a disposizione del papa, ma solo vent’anni dopo, con i Patti lateranensi, nascono i primi accordi per la circolazione. Tra il 1929 e il 1930 nel garage pontifico c’...