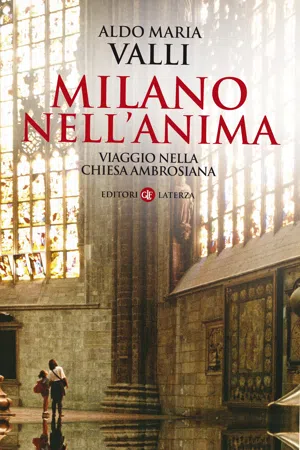Una storia che parte da lontano
Sotto il Duomo
Dopo l’editto del 313 a Milano non tardano a sorgere le prime chiese. I cristiani, forti del nuovo provvedimento, smantellano progressivamente gli edifici pagani e talvolta ne usano i materiali per costruire i propri luoghi di culto.
A memoria d’uomo, l’area in cui sorge il Duomo è sempre stata adibita a centro religioso. Anticamente pare ci fosse un tempio dedicato a Minerva, e quando, in seguito all’editto, i cristiani possono costruire una chiesa, proprio lì viene edificata, dal 313 al 315, una basilica alla quale nel giro di pochi decenni se ne affiancherà una nuova: la prima, più tardi intitolata a Santa Maria Maggiore, sarà quindi definita Basilica vetus o minor, mentre la seconda, che diventerà la cattedrale cittadina e sarà intitolata al Salvatore e poi a Santa Tecla, prenderà il nome di Basilica nova o maior.
Santa Tecla doveva apparire imponente: era lunga ottantadue metri e larga quarantacinque, aveva cinque navate e sorgeva parallela agli attuali portici della Galleria Vittorio Emanuele, con la facciata rivolta verso via Mercanti.
Esistono belle foto in bianco e nero del 1961 che mostrano l’allora arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini (futuro papa Paolo VI), mentre visita gli scavi per la costruzione della metropolitana sotto piazza Duomo. Fu proprio in occasione di quei lavori che vennero alla luce i resti del battistero ottagonale intitolato a San Giovanni alle Fonti, dove, come si è ricordato, Ambrogio battezzò Agostino. Situati a quattro metri di profondità, i resti del battistero sono visitabili attraverso una scala alla quale si accede dalla controfacciata del Duomo.
Quando Ambrogio, il 7 dicembre 374, riceve l’ordinazione episcopale, le chiese di Milano sono ormai una decina. All’interno delle mura ci sono le due basiliche di cui s’è detto (la vetus e la nova), mentre le altre sorgono in posizioni più esterne, in aree cimiteriali, ma con Ambrogio si procede a ulteriori costruzioni.
Secondo la tradizione, come vere e proprie sentinelle, le basiliche ambrosiane sorgono lungo le principali vie d’accesso alla città. Abbiamo così la Basilica Apostolorum presso Porta Romana (detta anche di San Nazaro, perché custodisce le reliquie del martire), la Basilica Martyrum verso Vercelli (l’attuale basilica di Sant’Ambrogio), la Basilica Virginum verso Como (l’attuale San Simpliciano, nei pressi di corso Garibaldi) e la Basilica Prophetarum (o di San Dionigi) nella zona di Porta Venezia, verso Aquileia. A parte quest’ultima, distrutta nel Settecento per lasciare spazio ai giardini pubblici e in seguito al Museo civico di Storia naturale, le altre esistono ancora e ognuna di esse si distingue per qualche aspetto architettonico oltre che religioso. La Basilica Apostolorum, per esempio, è considerata la più antica chiesa con pianta a croce latina nella storia dell’arte occidentale, mentre la facciata della Basilica Virginum è considerata una delle meglio conservate dell’architettura romanica.
Successiva alle basiliche ambrosiane (la datazione è incerta) ma comunque antichissima è la basilica di San Lorenzo, presso Porta Ticinese, che nel corso dei secoli ha subito molteplici trasformazioni e ricostruzioni. Da quel che si sa, per ovviare all’instabilità del terreno paludoso, l’edificio venne eretto sopra un cumulo artificiale lungo la Via Ticinensis, impiegando anche pietre provenienti dal palazzo imperiale e dall’anfiteatro, che sorgevano nei pressi.
Del periodo imperiale sopravvivono le sedici colonne in marmo, con capitelli corinzi, che sostengono una trabeazione. Le colonne si ergono proprio di fronte alla basilica, guardate dalla statua dell’imperatore Costantino. Facevano parte probabilmente di un complesso termale e costituiscono una testimonianza preziosa della Milano dei primi secoli dopo Cristo.
Fino al 1935 lo spazio tra la basilica e le colonne, oggi uno dei luoghi principali della movida notturna milanese, era interamente occupato da case popolari che costituivano uno degli angoli più pittoreschi della città ma nello stesso tempo impedivano la vista della basilica. L’amministrazione comunale del tempo, in piena epoca fascista, decide dunque di abbattere le case liberando l’intera area. Meno di dieci anni dopo, i bombardamenti alleati su Milano provvedono a distruggere anche le abitazioni che sorgevano sul retro della basilica, in uno spazio che nel dopoguerra è destinato a verde pubblico: nasce il parco delle Basiliche, che si chiama così perché sorge tra San Lorenzo e Sant’Eustorgio.
Un lago e un patibolo
A dispetto di come si presenta oggi, Milano è sempre stata città d’acqua. Dunque non c’è da stupirsi nell’apprendere che nel luogo in cui ai giorni nostri c’è il parco delle Basiliche, ora intitolato a Giovanni Paolo II, c’era un tempo un piccolo lago o piuttosto una conca d’acqua, nei pressi di un canale con un piccolo porto. Non doveva essere acqua pulitissima. Anzi, diciamo pure che era acqua maleodorante, perché lì confluivano canali di scolo e a un certo punto la conca venne utilizzata dai conciatori di pelli. Proprio lì, dove adesso c’è piazza Vetra («vetraschi» erano detti appunto i conciatori) si eseguivano le punizioni pubbliche e le condanne a morte, sia per impiccagione sia, per gli eretici e le streghe, con il fuoco (motivo per cui oggi piazza Vetra è considerato uno dei luoghi più demoniaci di Milano).
In piazza Vetra, nel 1630, in piena epidemia di peste, sono bruciati, dopo aver subito terrificanti torture, il commissario di sanità Guglielmo Piazza e il barbiere Gian Giacomo Mora, accusati ingiustamente, sulla base della testimonianza di una donna di nome Caterina Trocazzani, di essere untori (vicenda narrata dal Manzoni nella Storia della colonna infame).
È, quella del 1630, una delle epidemie più devastanti conosciute da Milano. Portato dai lanzichenecchi, il morbo uccide più della metà dei duecentocinquantamila abitanti di allora. Una delle autorità che più si prodigarono nell’assistenza dei malati è l’arcivescovo Federico Borromeo (1564-1631), del quale Alessandro Manzoni, nei Promessi sposi, parla così: «Federigo dava a tutti, com’era da aspettarsi da lui, incitamento ed esempio. Mortagli intorno quasi tutta la famiglia arcivescovile, e facendogli istanza parenti, alti magistrati, principi circonvicini, che s’allontanasse dal pericolo, ritirandosi in qualche villa, rigettò un tal consiglio, e resistette all’istanze [...]. Visitava i lazzaretti per dar consolazione agl’infermi, e per animare i serventi; scorreva la città, portando soccorso ai poveri sequestrati nelle case [...]. Si cacciò in somma e visse nel mezzo della pestilenza, maravigliato anche lui, alla fine, d’esserne uscito illeso».
Avremo ancora modo di occuparci del cardinale, ma ora torniamo in piazza Vetra. Che il luogo abbia qualcosa di sinistro lo dimostra il fatto che in anni recenti è diventato uno dei punti prediletti da spacciatori e consumatori di droga, tanto da costringere il Comune, alla fine degli anni Novanta, a circondarlo con una cancellata che alle dieci di sera viene chiusa. Ora che la situazione sembra migliorata qualcuno vorrebbe eliminare la recinzione e riaprire la piazza, soprattutto per alleggerire la pressione della folla che nelle ore notturne frequenta la zona delle colonne di San Lorenzo.
I tempi cambiano, così come le esigenze delle città, e Milano non fa eccezione. Sull’altro lato del parco, quasi a fare da vedetta, assiste all’evolversi della situazione la basilica di Sant’Eustorgio, con il suo bel campanile sormontato da una stella a otto punte.
I Re Magi erano qui
Se la stella vi ricorda quella dei Re Magi, avete perfettamente colto nel segno. All’interno della basilica si trova infatti il sarcofago che un tempo ospitò proprio quelle che erano ritenute le reliquie dei saggi visitatori della capanna di Betlemme.
Per le prime notizie sui resti dei Re Magi bisogna tornare all’imperatrice Elena. La madre di Costantino, instancabile ricercatrice di reliquie cristiane, nell’anno 326, durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, trova infatti, oltre a quella che è ritenuta la Vera Croce, anche i resti dei Magi e li porta con sé a Costantinopoli. Pare che il trasferimento a Milano sia dovuto ai crociati, ma la leggenda narra un’altra storia. Sarebbe stato, a metà del IV secolo, il greco Eustorgio, mandato da Costantinopoli a Milano come governatore e poi eletto vescovo della città, a trasportare le reliquie su un carro trainato da due vacche. Durante il viaggio un lupo ne assale una e la sbrana, ma Eustorgio riesce ad ammansirlo e a convincerlo a proseguire trainando il carro al posto dell’animale morto. Arrivato nei pressi di Milano, il carro si fa pesantissimo e le ruote si bloccano, tanto che Eustorgio, intenzionato a entrare in città attraverso la via Ticinese per portare le reliquie nella cattedrale, decide di fermarsi e di far costruire proprio lì una chiesa per dare adeguata sepoltura ai resti di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre.
Il racconto contiene alcuni elementi tipici di queste leggende (il viaggio, il trasporto, il santo che riesce a domare la bestia feroce). Quel che è certo è che le reliquie, a lungo dimenticate, vengono riscoperte nel 1158, quando i milanesi rafforzano le difese della città. Pochi anni dopo, tuttavia, l’imperatore Federico I, meglio noto come il Barbarossa, dopo aver assediato e distrutto Milano, rispondendo a un desiderio dell’arcivescovo Rainaldo di Dassel (che vuole le reliquie in Germania perché Milano, in quanto città ribelle, non sarebbe degna di conservarle), le fa trasportare a Colonia, dove vengono poste in un’arca di argento dorato, nella chiesa di San Pietro, poi trasformata in cattedrale gotica.
Per secoli la città di Milano cerca di tornare in possesso almeno di una parte delle reliquie, cosa che avviene nel 1904, grazie a un accordo fra l’arcivescovo dell’epoca, Andrea Carlo Ferrari, e l’arcivescovo di Colonia, Antonius Fischer. Le reliquie (due fibule, una tibia e una vertebra) vengono così collocate dentro un’urna di bronzo, accanto al sarcofago rimasto vuoto, sul quale campeggia ancora la scritta Sepulcrum Trium Magorum.
Nonostante il furto subito, o forse proprio per quello, Milano resta fedele alla memoria dei Magi. Sappiamo infatti che sotto i Visconti i tre sapienti orientali venivano ricordati con un fastoso corteo che comprendeva cavalli, personaggi in costume e animali esotici. Una bella tradizione ripresa a partire dal 1962 con un corteo che nel giorno dell’Epifania si snoda dal Duomo fino a Sant’Eustorgio attraverso via Torino, la basilica di San Lorenzo (dove si rievoca l’incontro dei Magi con il re Erode) e corso di Porta Ticinese.
Ai nostri tempi la basilica di Sant’Eustorgio è la prima che il nuovo arcivescovo di Milano visita quando fa il suo ingresso in città. Qui il cerimoniale prevede che il novello pastore doni alla basilica il suo rocchetto, la veste liturgica in lino bianco, ricevendo in cambio una piccola urna contenente un po’ di terra del cimitero nel quale riposano i primi martiri cristiani.
Magi a parte, la basilica di Sant’Eustorgio è degna di nota anche per un gioiello del Rinascimento lombardo: la Cappella Portinari, che deve il suo nome a colui che la commissionò, Pigello Portinari, direttore della filiale milanese del Banco Mediceo, che ne volle fare il luogo della propria sepoltura e il reliquiario di Pietro da Verona, predicatore e inquisitore domenicano nella Milano del XIII secolo, assassinato nel 1252 e quasi decapitato a colpi di roncola nei boschi di Seveso, dove alcuni sicari lo raggiunsero mentre andava a piedi da Como a Milano. Proclamato santo in quanto martire, Pietro da Verona, secondo le agiografie, prima di esalare l’ultimo respiro avrebbe intinto un dito nel proprio sangue tracciando per terra la parola «Credo».
Realizzata dal 1462 al 1468, la cappella (sul nome del progettista gli storici dell’arte non hanno raggiunto un accordo) è stata restaurata e riaperta in anni recenti dopo una storia, tanto per cambiare, alquanto tribolata, con un susseguirsi di interventi sciagurati: dai tempi della pestilenza del 1630 sono stati ben sette, si è calcolato, gli strati di intonaco sovrapposti, a nascondere i bellissimi affreschi di Vincenzo Foppa, il pittore protagonista del Rinascimento lombardo, nella Milano di Francesco Sforza.
A proposito del martire Pietro circola anche una leggenda. L’arcivescovo Giovanni Visconti soffriva di continue emicranie e non vi trovava rimedio. Perché? Si rese conto che i mal di testa erano incominciati da quando non aveva saputo resistere alla tentazione di impossessarsi della testa di san Pietro prelevandola dalla chiesa di Sant’Eustorgio per tenerla in casa propria. Così riportò la testa dove stava, le emicranie cessarono e da quel giorno si pensa che il 29 aprile (festa di san Pietro martire) toccando il reliquiario si ottenga l’esenzione dal mal di testa per tutto l’anno.
In questa carrellata sulle basiliche di Milano non può mancare San Babila, che sorge nella piazza omonima, a due passi da corso Vittorio Emanuele, e prende il nome dal vescovo di Antiochia, il patriarca Babila, che secondo la tradizione fu arrestato durante le persecuzioni anticristiane del II secolo e morì in carcere.
Il fatto che la chiesa sia intitolata a quell’antico patriarca conferma i legami della Chiesa di Milano con l’Oriente cristiano (legami rafforzati dalla presenza a Milano di religiosi siriaci, particolarmente devoti a Babila), ma di certo il santo di Antiochia (oggi Antakya, in territorio turco, poco distante dal confine con la Siria) non poteva immaginare che molti secoli dopo il suo appellativo sarebbe stato ricordato per motivi ben diversi da quelli religiosi.
Babila dà infatti il nome a una piazza che negli anni Settanta del secolo scorso diventa luogo di ritrovo dei giovani dell’estrema destra (i cosiddetti sanbabilini, secondo il neologismo inventato dai giornalisti in quel periodo) e a un famoso teatro che si trova proprio lì, accanto al «quadrilatero della moda».
Oggi i sanbabilini non ci sono più. Ci sono invece tanti turisti stranieri che si aggirano nella piazza prima o dopo lo shopping nel quadrilatero d’oro della moda, comprendente le vicine vie Montenapoleone e della Spiga. Poche le persone che entrano nella chiesa, vera oasi di pace e di silenzio, e pochissime quelle che alzano lo sguardo verso la dedica che sta sopra la trifora che orna la facciata: Sanctis Babylae Episcopo Tribusque Pueris, ovvero «al santo vescovo Babila e ai tre fanciulli». Chi erano i tre fanciulli? Si chiamavano Urbano, Prilidano ed Epolono e, almeno così dice la leggenda, subirono il martirio insieme al vescovo.
Un’altra leggenda racconta che i veneziani, volendo conquistare Milano, avessero organizzato una spedizione. Armati di tutto punto, si presentarono all’alba dalla parte di Porta Orientale, l’attuale Porta Venezia, con l’intenzione di invadere la città, ma furono spaventati da un rumore di tamburi. Pensando che i milanesi si fossero accorti dell’invasione e stessero per attaccare, ritennero opportuno darsela a gambe. Ma quello che sembrava essere un rullo di tamburi era solo il rumore provocato da un mattiniero panettiere (in dialetto milanese si dice prestinèe) che setacciava la farina. La leggenda dice che i veneziani, nella fuga, lasciarono sul campo la riproduzione di un leone simile a quello di piazza San Marco, lo stesso che da allora se ne sta sulla colonna di fronte alla basilica, e che in realtà risale al 1626 ed è semplicemente l’emblema dell’antico sestiere di Porta Orientale.
Un capolavoro precario
Non leggenda ma storia è invece quella narrata da un’altra celeberrima chiesa milanese, Santa Maria delle Grazie, basilica appartenente all’ordine domenicano, completata nel 1482 per volontà del duca di Milano Francesco I Sforza e considerata dall’Unesco patrimonio dell’umanità insieme al Cenacolo di Leonardo da Vinci che è conservato nel refettorio del convento.
Anche qui i turisti sono tanti, ma in questo caso più che all’haute couture sono interessati ai vertici raggiunti dall’arte leonardesca. Un’arte tuttavia effimera, perché il genio, volendo sperimentare una tecnica innovativa per la pittura su intonaco asciutto, consegnò la sua creazione a un destino di precarietà e di continui restauri, l’ultimo dei quali, concluso nel 1999, è durato vent’anni, dunque cinque volte più del tempo impiegato da Leonardo per realizzare l’opera, a partire dal 1494.
Oggi i visitatori vengono fatti entrare a gruppi di venticinque persone ogni quarto d’ora, per non alterare il microclima, e quello che si trovano di fronte è un miracolo se pensiamo che già nel 1517 era evidente che il capolavoro incominciava a deteriorarsi, che nel 1612 il cardinale Federico Borromeo, temendo di perderlo, ne fece eseguire in fretta una copia, e che nel 1943 una bomba, dopo aver colpito in pieno il refettorio dei frati abbattendo una volta e un muro, lasciò tuttavia integro il capolavoro leonardesco.
Un po’ per colpa di Leonardo e della sua sce...