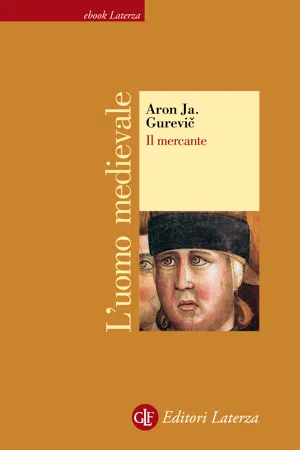Il mercante
Avvertenza del traduttore: di deliberato proposito tutte le citazioni sono tradotte dal russo.
La strada percorsa dal ceto mercantile dell’Europa occidentale nel corso dei secoli XI-XV riflette le modificazioni di straordinaria importanza che in quel periodo si produssero nell’economia, nella struttura sociale e nella cultura. Da elemento notevole, ma purtuttavia secondario di una società in prevalenza agraria, qual era il mercante all’inizio del Medioevo, egli si trasformò gradualmente in una figura di primo piano, nel portatore dei nuovi rapporti che minavano i fondamenti tradizionali del feudalesimo. Noi qui, però, ci occuperemo non tanto dell’attività economica dei mercanti di per sé, quanto del mercante come tipo umano. La mentalità dei mercanti si distingueva sotto molti aspetti in modo sostanziale da quella dei cavalieri, del clero o dei contadini. Il quadro del mondo, formatosi a poco a poco nella coscienza del ceto mercantile via via che esso andava sviluppandosi, entrava in contrasto con la visione del mondo degli altri strati e ceti della società feudale. La professione e il modo di vita degli uomini d’affari favorirono il formarsi di nuovi orientamenti etici, di un tipo diverso di condotta.
1. All’inizio dell’XI secolo in Europa, quando la stragrande maggioranza della popolazione viveva nelle località di campagna, esistevano le città e c’era una componente della società costituita dai mercanti. Anzi, il loro ruolo non era affatto di poco conto. I sovrani, i prelati, l’aristocrazia e in parte anche strati più ampi della popolazione necessitavano di articoli e mercanzie di vario genere, i quali non potevano essere prodotti sul posto e dovevano, perciò, essere importati da altri luoghi, talvolta lontani. Non solo vesti e tessuti di lusso, vasellami pregiati e altre rarità, capaci di soddisfare i bisogni di prestigio dell’élite dirigente, ma anche merci ordinarie venivano spesso fornite dai mercanti lungo le vie d’acqua o di terra. I mari dell’Europa meridionale e settentrionale, i grandi fiumi e qua e là anche le strade ereditate dai tempi dei Romani, venivano utilizzati come arterie commerciali.
Il mercante dell’alto Medioevo è un personaggio radicalmente diverso dal mercante del Medioevo sviluppato e tardo. In questo senso sono paradigmatici i commercianti che operavano nell’Europa settentrionale nell’età dei Vichinghi. Il Vichingo è guerriero, conquistatore, predatore, navigatore ardito e colonizzatore. Gli abitanti della Francia e dell’Inghilterra, dell’antica Rus’ e del Mediterraneo patirono gli attacchi dei Vichinghi provenienti dalla Scandinavia. Là dove comparivano i loro drappelli, bruciavano i villaggi e le città, cadevano in rovina i monasteri, soccombevano uomini e bestiame. I Vichinghi s’impadronivano di ricchi bottini, compresi i tesori delle chiese e gli schiavi. In Europa s’innalzavano preghiere a Dio per la protezione dagli assalti normanni. Ma non si deve dimenticare che le spedizioni vichinghe erano strettamente legate al commercio. Non di rado il viaggio di un Norvegese o di uno Svedese nel paese limitrofo rappresentava una specie d’impresa mista. Egli portava con sé merci – i prodotti della caccia o dell’artigianato – e le scambiava con le cose necessarie. Tra i numerosi reperti dell’età vichinga gli archeologi hanno trovato, oltre alle armi, bilance con pesi di cui si servivano i navigatori scandinavi, e certo non tutti i numerosi tesori di monete d’argento e d’oro ritrovati nel Nord, erano il risultato di rapine – una parte del denaro proveniva dal pacifico scambio mercantile. Ma, come risulta dalle saghe islandesi, il viaggio commerciale dello Scandinavo si concludeva spesso con il suo assalto contro gli abitanti locali e quello che egli non scambiava, lo strappava loro con la forza. Commercio e rapina andavano di pari passo.
Ma anche i mercanti del primo periodo medievale non coinvolti nel brigantaggio, non potevano essere del tutto privi di bellicosità. Essi dovevano recarsi con le loro carovane in paesi lontani, peregrinare tra genti e popoli stranieri, imbattendosi in molti pericoli di diverso genere, dai predoni ai signori locali, assai simili ai briganti, che si davano da fare per mettere le mani sulle loro ricchezze, o pressandoli con dazi o semplicemente togliendo loro mercanzie e guadagni. I mercanti soffrivano per le burrasche del mare e per le afflizioni dei transiti di terra a causa dell’impraticabilità delle strade. Il profitto delle merci rare poteva essere assai elevato, ma non minore era anche il rischio ad esso collegato. Nel colloquium dello scrittore ecclesiastico e abate inglese Aelfric (inizio dell’XI secolo), nel quale sono caratterizzate le varie professioni, oltre al monaco, all’agricoltore, al pastore, al tessitore, al salinatore, al pescatore, al cacciatore, al fabbro, è citato anche il mercante. Sulle sue labbra sono poste le parole: «Sono utile al re, al nobile, al ricco e a tutto il popolo. Salgo sulla nave con le mie merci e navigo fino ai paesi d’oltremare, vendo la mercanzia e acquisto le cose pregiate che non si trovano qui nel nostro paese. Le trasporto con grande rischio e faccio talvolta naufragio, perdendo ogni avere e salvando a stento la vita». Il mercante porta vesti e tessuti costosi, pietre preziose e oro, vino e olio, avorio, ferro e altri metalli, vetro e una gran quantità di altre cose. L’interlocutore gli chiede: «Vendi queste merci al prezzo al quale le hai comprate?» «No. Che cosa altrimenti mi darebbe la mia fatica? Vendo più caro di quanto ho comprato proprio allo scopo di trarne un profitto e mantenere così moglie e figli».
Ciò nondimeno, nella valutazione di Aelfric, per la società è più importante il lavoro dell’aratore che sfama tutti. Il «pensiero economico» dell’alto Medioevo non usciva dall’orizzonte tracciato dall’economia naturale. Esattamente allo stesso modo i teorici della società feudale in formazione, rappresentandola in guisa di un sistema trinomiale con a capo il monarca, menzionavano soltanto il clero («coloro che pregano»), i cavalieri («coloro che combattono») e i contadini («coloro che arano la terra»). La popolazione urbana, gli artigiani e i mercanti sfuggono alla loro attenzione. Non perché, s’intende, il loro ruolo fosse affatto insignificante, ma perché nella società dei secoli XI-XII, nella quale predominava la tradizione, i vecchi schemi concettuali conservavano fino a tal punto il loro antico vigore da poter ignorare la viva varietà della realtà concreta. Se per il funzionamento dell’organismo sociale il lavoro dell’agricoltore è altrettanto necessario delle preghiere dei monaci e dei chierici, e delle gesta belliche dei guerrieri, le occupazioni urbane, in particolare il commercio, restano dubbie e circospette dal punto di vista dell’etica dominante. La sfiducia dei contadini e la boria sprezzante dei nobili verso il mercante trovavano sul piano ideologico un parallelo e una motivazione nell’insegnamento della Chiesa.
L’atteggiamento della società verso il mercante era estremamente contraddittorio. Da un lato era difficile farne a meno. Le istruzioni date dal padre al figlio nello Speculum regale, che descrive i diversi ceti e categorie sociali della Norvegia dal punto di vista di un Norvegese istruito del primo terzo del XIII secolo, iniziano con la caratterizzazione dell’attività del mercante. «L’uomo che si propone di diventare mercante – dice il padre – espone la sua vita a molti pericoli, sia sul mare sia in terre pagane e tra popoli stranieri. Egli deve perciò attenersi costantemente alla prudenza là dove si trova. Sul mare è necessario saper prendere decisioni immediate ed essere dotati di grande coraggio. Quando invece giungi in una località commerciale o in un altro posto qualsiasi, devi mostrarti persona educata e ammodo per conquistarti la simpatia generale». Bisogna studiare con cura gli usi legati al commercio dei luoghi in cui si arriva. In particolare è importante conoscere bene il diritto commerciale. Per conseguire successi nel proprio commercio il mercante deve conoscere le lingue, innanzi tutto il latino e il francese perché sono le più diffuse. Al mercante-navigatore occorre sapersi orientare nella disposizione degli astri e nell’avvicendamento del tempo nelle ventiquattr’ore nonché discernere i punti cardinali. «Non lasciar passare nemmeno un giorno senza apprendere qualcosa di utile per te [...] e se davvero vuoi acquistare la reputazione di saggio devi imparare continuamente». Il mercante è tenuto allo spirito di pace e alla riservatezza, «ma, se le circostanze ti costringono allo scontro con l’avversario, non aver fretta di abbandonare il luogo; dopo aver valutato con attenzione tutto, agisci a colpo sicuro». Una particolare cautela va manifestata nella scelta dei soci nel commercio. «Una parte del profitto deve essere sempre devoluta a Dio onnipotente e alla Santa Vergine Maria nonché ai santi ai quali tu sei solito rivolgerti per aiuto».
Osservando tutti questi consigli ci si può arricchire. L’autore dello Speculum regale, nel riconoscere il grande rischio al quale è collegato il commercio d’oltremare, raccomanda al giovane mercante: «Allorché vedrai che come risultato dei viaggi commerciali la tua ricchezza è davvero aumentata in maniera consistente, la cosa migliore sarà sottrarre agli affari due terzi del capitale e investirli in un solido possesso terriero, poiché questo genere di bene sembra il più sicuro sia per il proprietario sia per i suoi posteri».
La cosa curiosa è che un simile consiglio venga dato in Norvegia, un paese dove manca lo spazio per l’agricoltura. Ma gli stessi investimenti nelle proprietà agricole dei capitali creati con le attività mercantili si riscontravano anche nei paesi del continente europeo, dalla Germania all’Italia. Le occupazioni commerciali sono importanti, ma i pericoli d’ogni genere che le insidiano e il rischio sociale ed economico della professione spingono i mercanti a ritornare alla più garantita sfera della proprietà terriera.
D’altro lato il prestigio sociale dei mercanti è assai modesto. Il ricco desta invidia e malevolenza, la sua onestà e coscienziosità ispirano seri dubbi. In generale il mercante restava, a detta di uno storico contemporaneo, un «paria» della società medievale nella fase iniziale del suo sviluppo. In che cosa propriamente consiste la giustificazione del suo profitto? Egli acquista la merce a un prezzo e la rivende a uno più alto. Qui si celano le possibilità dell’inganno e dell’ingiusto lucro; i teologi ricordavano volentieri le parole: «il mestiere del mercante non è grato a Dio». Poiché, secondo i padri della Chiesa, è difficile che nei rapporti di compravendita non s’insinui il peccato. Negli elenchi delle professioni, qualificate «disoneste», «impure» – queste liste venivano stese dai teologi – quasi sempre figurava il commercio. Nel respingere il mondo terreno, nello svalutarlo dinanzi al mondo celeste, il clero non poteva non condannare il commercio, occupazione che perseguiva l’obiettivo del profitto.
Qu...