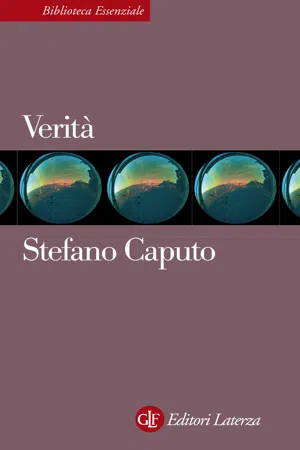
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Verità
Informazioni su questo libro
A volte la temiamo e la fuggiamo, più spesso la desideriamo e la ricerchiamo.La verità ci interessa. Ma che cos'è?
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Saggi di filosofiaV. Tarski: dalla verità
ai predicati di verità
Con Il concetto di verità nei linguaggi formalizzati (1935) Tarski si propone di costruire una teoria della verità che soddisfi questi tre requisiti: 1) colga il nucleo essenziale della concezione corrispondentista, da lui identificato con l’idea che la verità di un enunciato dipende da come è fatto il mondo; 2) sia scevra da quelli che egli considera i principali limiti della suddetta concezione: applicarsi, in primo luogo, ai soli enunciati della forma soggetto-predicato (il problema di Procruste sollevato, come si è visto nel capitolo III, dallo stesso Tarski) e fare ricorso, in secondo luogo, a nozioni poco chiare come quella di «corrispondenza» o «fatto»; 3) sia scientificamente rispettabile, soddisfi cioè i più alti standard di rigore, chiarezza concettuale e adeguatezza empirica.
La realizzazione di tale progetto comporta però, secondo Tarski, un significativo ridimensionamento delle aspettative di coloro che fino a quel momento si erano adoprati nel tentativo di chiarire la natura della verità22.
1. La definizione semantica: una corrispondenza senza corrispondenza
Tarski ritiene che tanto il nucleo della concezione corrispondentista quanto quello della nozione ordinaria di verità siano espressi dalla seguente caratterizzazione, che egli chiama «definizione semantica» (Tarski 1935: 155):
S) Un enunciato vero è un enunciato che dice che lo stato di cose è così e così e lo stato di cose è effettivamente così e così23.
Si osservi, a tal proposito, che (S) ricorda da vicino il principio di oggettività della verità (vedi cap. I, § 2.4.1):
(OG) Una cosa che diciamo o pensiamo è vera sse le cose stanno nel modo in cui essa dice che stanno.
(S) può però al più costituire il punto di partenza di una teoria della verità: si tratta infatti di fornirne una formulazione rigorosa che, in particolare, non ricorra ad espressioni quali «Dice che» o «Lo stato di cose è così e così». La prima esprime infatti una nozione semantica e, come vedremo nei paragrafi successivi, Tarski ritiene particolarmente problematiche tali nozioni. La seconda, invece, in primo luogo fa riferimento a entità quali gli stati di cose, la cui natura ed esistenza costituiscono una delle principali fonti di perplessità nei confronti delle concezioni corrispondentiste; in secondo luogo contiene l’espressione colloquiale «essere così e così», il cui significato dovrebbe essere esplicitato in modo rigoroso. Quando si tratta di spiegare ciò in cui consiste la verità di singoli enunciati ciò che è detto da (S) è però secondo Tarski perspicuamente colto da enunciati come:
1) L’enunciato «Palermo è in Sicilia» è vero sse Palermo è in Sicilia,
cioè dai bicondizionali (V1) che sono, come sappiamo dal capitolo I (§ 2.4.1), gli esempi dello schema di equivalenza
(V1) L’enunciato «p» è vero sse p.
Ciascuno di essi è una definizione parziale della verità (Tarski 1935: 155), nella misura in cui sembra fornire una spiegazione del tutto esaustiva del perché un determinato enunciato sia vero (se lo è). Una definizione della nozione di verità dovrà dunque essere una generalizzazione di tali definizioni parziali, un modo cioè finito di fornire le informazioni in esse contenute: i bicondizionali (V1) sono infatti in numero infinito, essendocene uno distinto per ciascuno degli infiniti enunciati dell’italiano cui si può applicare il predicato «è vero». (S) costituisce appunto una generalizzazione non rigorosa e colloquiale di questo tipo. Che una certa definizione sia effettivamente una generalizzazione dei bicondizionali (V1) lo si potrà verificare appurando se essi sono ricavabili, cioè deducibili, da essa (Tarski 1944: 30-31). Se infatti un enunciato è conseguenza logica di un altro allora quest’ultimo fornirà già in un certo senso l’informazione fornita da quello: è questo il criterio di adeguatezza materiale per una definizione di verità. L’adeguatezza in questione è detta «materiale» perché essa concerne lo specifico oggetto della definizione, la sua materia appunto, cioè la verità: non ci sarebbe infatti alcuna ragione di considerare una definizione che non rispettasse tale criterio come una definizione della verità piuttosto che di qualche altra cosa24. Il soddisfacimento di tale criterio costituisce una condizione non solo necessaria ma anche sufficiente per la correttezza di una definizione della verità a patto che essa sia formalmente adeguata, a patto cioè che essa rispetti gli standard di rispettabilità scientifica che valgono per tutte le definizioni, indipendentemente dal loro specifico oggetto.
2. I prezzi da pagare per la rispettabilità scientifica
Le analisi della verità che abbiamo fin qui presentato, che chiameremo da ora in poi concezioni classiche, avevano tutte la forma «x è vero =def x è G»; esse si prefiggevano cioè di spiegare ciò in cui consiste l’essere vero, l’avere quella proprietà cui si riferisce il predicato «è vero». Un tale progetto deve però, secondo Tarski, essere abbandonato: la nozione ordinaria di verità non è infatti definibile, per lo meno se la definizione deve rispettare alcune basilari condizioni di adeguatezza formale, quali l’ammettere nel definiens solo nozioni più perspicue di quella da definire e l’essere coerente, non implicare cioè contraddizioni.
Il carattere della nozione ordinaria di verità che la rende più refrattaria ad una definizione che rispetti tali condizioni è la sua universalità, il fatto cioè che essa sia la nozione di un’unica proprietà che può essere attribuita a qualsiasi enunciato dichiarativo, tanto della nostra lingua che di altre.
2.1. I portatori di verità: da «vero» a «vero in L»
L’esigenza che una definizione formalmente adeguata non contenga nel proprio definiens nozioni oscure o problematiche conduce Tarski ad escludere che le credenze e le proposizioni possano svolgere il ruolo di portatori di verità in una teoria scientificamente rispettabile (Tarski, 1944: 28-29). La reale natura, e finanche l’esistenza, delle credenze e delle proposizioni è infatti oggetto di perdurante disputa, tanto ai tempi di Tarski quanto ai nostri. I portatori di verità prescelti sono invece gli enunciati, intesi come entità individuabili semplicemente in base alla loro forma, cioè in base alle loro caratteristiche ortografiche. Ad esempio, l’enunciato «Pippo corre» può essere descritto come la concatenazione delle parole «Pippo» e «corre» e queste possono a loro volta essere identificate con due diverse concatenazioni di lettere. Entità di questo tipo non sono però di per sé vere o false, ma lo sono solo in quanto ad esse è associato un certo significato in un certo linguaggio di cui fanno parte. Ad esempio, la sequenza di lettere «I vitelli dei romani sono belli» è vera in quanto parte dell’italiano (nell’ipotesi che i vitelli dei romani siano effettivamente belli), ma non lo è in quanto parte del latino (dato che essa non è in latino un enunciato dichiarativo ma un’esortazione rivolta al console romano Vitellio). Dunque quello che si può definire, quando si tratta di enunciati individuati in base alla loro forma, non è ciò in cui consiste essere un enunciato vero simpliciter, quanto piuttosto ciò in cui consiste essere un enunciato vero di un determinato linguaggio. Si potranno cioè definire molteplici predicati della forma «vero in L», ciascuno dei quali si ottiene sostituendo ad «L» il nome di uno specifico linguaggio e viene detto predicato di verità di L (o per L) (Tarski 1935: 153; 1944: 29).
Una teoria rigorosa della verità potrà dunque caratterizzare una molteplicità di nozioni quali vero in italiano, vero in francese, e così via, cioè definire i predicati di verità per le cosiddette lingue naturali? La risposta di Tarski a questa domanda è negativa.
2.2. L’incoerenza della verità
Un aspetto dell’universalità della nozione ordinaria di verità è che il predicato «è vero» si può applicare anche ad enunciati che lo contengono. Ad esempio si può correttamente dire che l’enunciato «L’enunciato “Roma è in Italia” è vero» è a sua volta vero. Tale possibilità dipende dal fatto che l’italiano, come tutte le altre lingue naturali, è una lingua semanticamente chiusa, una lingua cioè che contiene i propri predicati semantici. Ciò vuol dire che essa contiene predicati come «è vero», «si riferisce a», «significa» (detti appunto «semantici») che si possono applicare alle sue stesse espressioni. Se, da una parte, la chiusura semantica delle lingue naturali è una componente essenziale della loro potenza espressiva (poiché ci consente di parlare con una certa lingua delle espressioni di quella stessa lingua), dall’altra essa condanna secondo Tarski all’incoerenza qualsiasi tentativo di analizzare la nozione ordinaria di verità. Tale nozione infatti, proprio in virtù della chiusura semantica delle lingue naturali, è incoerente: da alcune sue legittime applicazioni sono cioè deducibili delle contraddizioni (Tarski 1935: 158; 1944: 35-38). Si consideri infatti l’enunciato
1) L’enunciato (1) non è vero.
In base alla trasparenza della verità abbiamo:
2) L’enunciato «L’enunciato (1) non è vero» è vero sse l’enunciato (1) non è vero.
Ma l’enunciato «L’enunciato (1) non è vero» di cui si parla in (2) altro non è che l’enunciato (1); dunque possiamo inferire da (2)
3) L’enunciato (1) è vero sse l’enunciato (1) non è vero.
Usando premesse inoppugnabili, quali la trasparenza della verità e la costatazione empirica che l’enunciato «L’enunciato (1) non è vero» è l’enunciato (1), siamo pertanto giunti ad una conclusione che appare inaccettabile in quanto sembra implicare una contraddizione. In base a (3), infatti, nel caso in cui l’enunciato (1) fosse vero al contempo non lo sarebbe, e nel caso in cui non fosse vero lo sarebbe. I ragionamenti di questo tipo che, partendo da premesse che appaiono indiscutibili, conducono in un modo che sembra impeccabile a conclusioni inaccettabili sono detti paradossi. Si tratta, in questo caso, del paradosso del mentitore la cui prima...
Indice dei contenuti
- Introduzione. L’importanza della verità
- I. Che cos’è una teoria della verità?
- II. Le cose vere
- III. La teoria della corrispondenza: verità e realtà
- IV. Le teorie epistemiche: verità e conoscenza
- V. Tarski: dalla verità ai predicati di verità
- VI. Il deflazionismo: nient’altro che trasparenza
- VII. Oltre il deflazionismo?
- Cos’altro leggere
- Riferimenti bibliografici
- Ringraziamenti
- L’autore
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Verità di Stefano Caputo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Saggi di filosofia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.