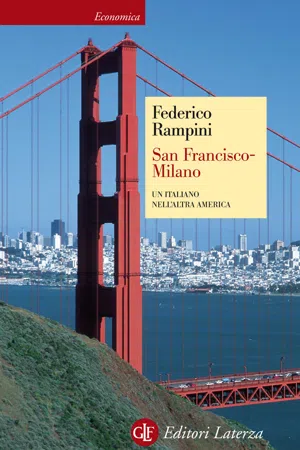Ultime dalla California, dieci anni dopo
Mountain View rivisitata
Dal mappamondo sullo schermo tridimensionale partono fasci di raggi laser sottilissimi che si proiettano verso lo spazio. Ogni raggio è una miriade di puntini luminosi, acceso da milioni di «ricerche» in corso in questo istante. Spuntano da tutti i centri abitati del pianeta, s’illuminano con colori diversi a seconda delle lingue. Minuto per minuto lo schermo riproduce l’attività di centinaia di milioni di utenti Internet che nel mondo intero stanno cliccando su Google le loro richieste: cercano nomi, località, prodotti, notizie, libri, immagini, video. C’è chi sta facendo la propria tesi di laurea e chi prepara un rapporto di lavoro, chi cerca un film e chi organizza una vacanza, chi divora gossip sulle pop-star e chi indaga sulla solidità finanziaria dell’azienda che sta per assumerlo. Quei fasci di raggi laser rappresentano i pensieri che agitano la popolazione mondiale; e le risposte che sta trovando su Internet. Il vero Grande Fratello abita qui, è questa la banca-dati mondiale delle nostre intenzioni. Basta cliccare su google.com/trends per conoscere in tempo reale le domande più frequenti in questo preciso istante. L’inquietante visita al mappamondo coi raggi laser, guidata dal ventitreenne addetto alle risorse umane Andrew Pederson, mi serve come un brutale richiamo alla realtà. Nel giorno in cui visito il suo quartier generale (7 settembre 2008) a dieci anni esatti dalla sua fondazione Google è la regina-madre di Internet, un’azienda che ha cambiato per sempre il nostro modo di informarci. Una potenza che fa tremare Microsoft. Un’impresa con diecimila dipendenti sparsi in dozzine di paesi dalla California all’India. Un colosso che in Borsa vale più di Walt Disney, Ford e General Motors messe assieme, ovvero trenta volte il «New York Times». Finché Pederson non mi porta davanti al mappamondo col fascio di raggi laser puntati nel cyber-spazio, ho potuto illudermi di essere in un parco giochi per eterni bambini, colpiti dalla sindrome di Peter Pan. Si può vagabondare per ore in questo villaggio-vacanze che è Googleplex a Mountain View. Lo chiamano campus per la somiglianza con le facoltà della zona come Stanford e Berkeley, città-studi immerse nel verde e carezzate dal sole, dove la popolazione universitaria si sparpaglia a studiare sui prati. A Googleplex l’atmosfera è perfino più rilassata e gaudente, la dimensione ludica sembra dominare. Nel parco centrale un gruppo di ragazze gioca a beach-volley sulla sabbia. Camminando all’aperto costeggio una piscina; una sala-fitness coi tapis roulant e le tv sintonizzate su canali in tutte le lingue; dei tavoli da biliardo; il salone per massaggi; il coiffeur. Tutto gratis. Design e decorazione del campus evocano un museo di arte contemporanea o il set di un film di fantascienza: in uno dei giardini c’è uno scheletro di Tyrannosaurus Rex, circondato da fenicotteri rosa col tesserino d’identificazione «Dipendente Google» appeso al collo. Le mense aziendali sono ristoranti Slow Food con menu agrobiologici. Il fondatore della ristorazione interna, il mitico chef Charlie, era il cuoco del gruppo rock Grateful Dead. Un manifesto annuncia un concerto destinato alla causa Free Tibet. Nei bagni le istruzioni sono scritte in inglese, spagnolo, cinese, giapponese e hindi. Giovani di tutte le razze chiacchierano amabilmente in piccoli gruppi, seduti ai tavolini di tanti bar all’aperto, sotto il sole californiano. In realtà stanno lavorando. Lo capisci solo quando osservi i loro laptop e orecchi le conversazioni. Non è in questo nirvana che ti aspetti d’incontrare i nuovi Padroni dell’Universo. Loro sembrano in perenne vacanza – e, se questo è il tecno-lavoro del ventunesimo secolo, è il Giardino dell’Eden. Qui stanno progettando il nostro futuro digitale, gli itinerari dei nostri pensieri, i percorsi dei consumi culturali. Una volta alla settimana, nella grande sala dell’auditorium i dipendenti incontrano i due fondatori Brin e Page, per una sessione di «democrazia aziendale» in cui tutto è permesso: domande indiscrete, nuove idee, lamentele, critiche. Si può rivoltare come un calzino ogni progetto in cantiere. Una regola d’oro: ciascuno deve riservarsi il 20% del proprio tempo di lavoro «per fare qualcosa che gli piace»; è la ricetta dell’eterna creatività, il segreto per vivere in una fucina permanente di innovazioni. Oggi chiunque abbia un computer o un telefonino con accesso a Internet (cioè la maggioranza della popolazione dei paesi sviluppati, ed anche trecento milioni di cinesi) è abituato a cliccare l’argomento che lo interessa, un nome, una frase, e sa che in una frazione di secondo vedrà apparire sullo schermo un’infinità di «link», di accessi a siti che contengono le informazioni desiderate. Delle ricerche che nell’èra pre-Internet potevano richiedere giornate intere in biblioteca, telefonate, scambi epistolari, ora si risolvono alla velocità della luce. Ma anche quando Internet già si era affermato, alla fine degli anni Novanta, esplorarlo era complicato. Inserendo una parola-chiave nei primi «motori di ricerca» si ottenevano troppe risposte irrilevanti. I contenuti del web erano già allora immensi e farsi strada in mezzo a quel caos primordiale era come perdersi in un labirinto. È per dare un ordine e un senso all’universo virtuale che Page e Brin cominciano a lavorare insieme nel 1995. All’epoca sono due dottorandi di Stanford. Figli d’arte, cresciuti tutti e due da padri e madri scienziati, Page e Brin maturano presto delle intuizioni geniali. Un motore di ricerca per essere efficace quando parte alla caccia della parola richiesta non può procedere senza un metodo, a casaccio. Deve escogitare il modo di ordinare i risultati secondo la loro utilità. Come misurare la diversa rilevanza di milioni di siti Internet che contengono la parola richiesta? I due si ispirano alla regola delle pubblicazioni scientifiche calcolando il numero di «citazioni»: ovvero i link, nel cyber-spazio, con altri siti. E non tutti i siti sono uguali. Una citazione su Yahoo ha più peso in termini di popolarità visto il numero di utenti; un collegamento al sito di Harvard è più autorevole che su un sito sconosciuto. Questi criteri logici e qualitativi vengono codificati in complessi algoritmi matematici, i veri segreti industriali elaborati dalle menti di Page e Brin, grazie ai quali sgominano i concorrenti. Bisogna anche trovare il modo di «scaricare» costantemente il contenuto globale di Internet in continua espansione, per scandagliarlo e ordinarlo alla velocità della luce. È un compito che richiede una formidabile potenza informatica. Qui scatta l’altra innovazione dei due amici. Nessun supercomputer sarebbe stato all’altezza di quella sfida: un sistema centralizzato è troppo vulnerabile, in caso di guasto paralizzerebbe l’intero motore di ricerca. E comunque nessun supercomputer, di quelli in uso alla Nasa o al Pentagono, è alla portata dei portafogli di due studenti universitari. Nasce allora l’idea di far «lavorare assieme» decine – poi centinaia, migliaia – di normalissimi personal computer, prodotti di serie, i meno cari sul mercato. (Ed ecco la banale risposta al quesito: perché anche Google come tante leggendarie aziende hi-tech della Silicon Valley viene creata in un garage? Perché un garage è il locale meno costoso da affittare per chi deve stipare metri cubi di computer uno sopra l’altro.) Quello che i due ragazzi lanciano a metà degli anni Novanta è l’applicazione del taylorismo al cyber-spazio. Reinventano una ricetta antica: la divisione del lavoro, la specializzazione estrema delle mansioni. Prendono una missione terribilmente complessa, e la spezzettano in un’infinità di singole operazioni più semplici. Al posto degli operai della Ford che nel primo Novecento assemblavano le auto un bullone alla volta nelle prime catene di montaggio, loro mettono a lavorare i personal computer. L’immane compito di ricopiare, catalogare, analizzare e selezionare l’intero universo di Internet, è frantumato in micro-mansioni, suddivise lungo la catena di montaggio in cui lavora un esercito di computer-operai. «La più grande novità dopo Gutenberg e l’invenzione della stampa cinquecento anni fa», la definisce David Vise, il reporter del «Washington Post» che ha vinto il Premio Pulitzer per la sua storia di Google (pubblicata in Italia dalle edizioni Egea). «Ancora adesso – mi dice Pederson – gran parte del lavoro qui ruota attorno al motore di ricerca. Dall’esterno non ci si rende conto di quanto Google sia un concentrato di potenza informatica». Ormai usa più di duecentomila personal computer, e aumentano ogni giorno. In confronto la Nasa e il Pentagono sono delle arcaiche botteghe artigiane. La passione per i grandi numeri è la chiave di questa storia, sta scritta fin dal nome scelto per l’azienda: una deformazione di Googol, che in matematica indica la cifra formata da uno seguito da cento zeri. Né Henry Ford né Thomas Edison, né l’Ibm né la Microsoft hanno conosciuto un trionfo così rapido e così globale: il mondo intero si è «convertito» spontaneamente a questa tecnologia in un decennio. Certo il merito non è solo dei due geniali fondatori. I dottorandi di Stanford hanno trovato nella Silicon Valley degli alleati formidabili: investitori audaci e illuminati, pronti ad assumere in proprio rischi elevati. Gente come Andy Bechtolsheim, che in un fast-food Burger King stacca un assegno da centomila dollari per due ragazzini sconosciuti: il capitale con cui fondano il 7 settembre 1998 la Google Inc. I celebri «capitalisti di ventura» John Doerr e Michael Moritz, che mettono da parte la proverbiale rivalità, co-finanziano lo sviluppo dell’impresa, e poi la sua quotazione in Borsa. Sarà il più grande collocamento azionario nella storia della Silicon Valley, l’ingresso al Nasdaq il 19 agosto 2004 con un valore iniziale di 23 miliardi di dollari. Quattro anni dopo il rialzo è del 420%. Le disavventure altrui hanno contribuito ad aiutare Google. Il crac di Borsa della New Economy, e la crescente impopolarità di Microsoft alle prese con vari processi antitrust, indeboliscono la concorrenza e fanno di Google la meta prediletta dei giovani talenti scientifici più dotati. Perché questa fantastica fabbrica di soldi nasce con un dna tipico della Bay Area di San Francisco: una controcultura radicale, trasgressiva, perfino anticapitalista. All’inizio Page e Brin teorizzano che non accetteranno mai la contaminazione della pubblicità. Poi in realtà questa diventa la loro maggiore fonte di entrate; ma solo dopo avere inventato una forma di pubblicità non intrusiva, discreta, che appare «a richiesta», strettamente collegata alle domande di chi consulta il motore di ricerca. La vedi se la vuoi vedere, perché la stai cercando. E la pubblicità resta assente, proibita, in quello che viene definito «il pezzo di proprietà immobiliare più pregiato del pianeta»: la pagina d’ingresso di Google, candida e vergine come alla nascita. In questo decennio ogni resistenza è stata travolta. Ex colossi dominanti come Aol e Yahoo, che pochi anni fa guardavano i ragazzini di Google con superba sufficienza, si sono inchinati a usare la loro tecnologia. Google ha conquistato la stratosfera, le sue mappe del globo terrestre sono così accurate che le basi militari devono oscurarne i dettagli troppo precisi. Ha diffuso con successo il suo servizio di e-mail. Ora ha il suo browser in concorrenza con l’Explorer di Microsoft. Ha in corso la schedatura dell’intero genoma umano. Eppure a Mountain Valley sono convinti che la loro sfida è appena iniziata. «La mappatura integrale di migliaia di miliardi di pagine Internet non ci basta – mi dice Pederson – perché tanta parte dello scibile umano è ancora off-line, su carta, non è tradotto in forma digitale, è contenuto nelle biblioteche tradizionali, è segmentato in centinaia di lingue diverse. Il prossimo traguardo è questo: rendere accessibile, traducibile e consultabile all’istante tutto l’universo delle conoscenze che ancora non sono su Internet. Questo significa che a oggi abbiamo fatto appena il 5% del nostro cammino». Pochi mesi prima del decimo compleanno aziendale, in uno degli scherzi che costellano la sua comunicazione quotidiana, da Googleplex fu diffuso l’annuncio dell’apertura di una nuova filiale sulla luna. Da allora l’ufficio del personale continua a ricevere curriculum vitae dai giovani laureati delle migliori università americane che si candidano per quella sede. Sono convinti che Google sulla luna prima o poi ci andrà davvero, e vogliono arrivarci con i primi.
Eppure Google è già vecchia, ovvero: Internet è morto?
«Ti svegli e senza alzarti dal letto controlli le e-mail sul tuo iPad. Stai usando un’app, un’applicazione. Durante la prima colazione dai un’occhiata alla tua pagina su Facebook, su Twitter, e alle ultime notizie sul ‘New York Times’. Sono tutte app. Idem quando in auto ascolti musica dal tuo iPod o dall’iPhone, poi in ufficio usi Skype per telefonare a un amico dall’altra parte del mondo. Alla fine avrai speso la giornata usando Internet ma non più sulla ‘rete’ aperta, libera. Sei diventato il frequentatore di tanti giardini chiusi». Chris Anderson ha lanciato una provocazione intitolando la copertina di «Wired»: «Il web è morto, lunga vita a Internet». Mi riceve a San Francisco, South of Market, nella sede storica della rivista che fu un simbolo della New Economy (i numeri del 1999 e del 2000 erano grossi come l’elenco del telefono tanta era la pubblicità) ed oggi è rinata a una seconda vita. «Proprio come Internet – osserva – che sta entrando in una nuova fase rivoluzionaria. Le rivoluzioni industriali hanno dei cicli, e per la rete se n’è chiuso uno». Un profano, uno come me per esempio, ancora fatica a fare la differenza tra il concetto di Internet e quello di web, cioè rete. Confesso che li ho quasi sempre usati in modo interscambiabile, come fossero la stessa cosa. Ancora un minuto fa: nello scrivere il titolo di questo paragrafo. Per Anderson la mia confusione è inammissibile. Il titolo della sua rivista inneggia alla morte della «rete», non di Internet! Dunque non siamo più prigionieri come dei pesciolini?
«Ancora pochi anni fa – mi spiega – tutto sembrava ruotare attorno al browser (o ‘navigatore’): accendevi il tuo computer, cliccavi sull’icona di Internet Explorer o Firefox e ti si apriva la possibilità di navigare. Poi sceglievi il motore di ricerca Google e la tua esplorazione continuava, in mare aperto. Lo spostamento in poco tempo è stato drastico ed è trainato dal successo della nuova generazione di telefonini come l’iPhone, poi dei lettori digitali o ‘tavolette’ come l’iPad. I consumatori li preferiscono per la facilità che offrono: è lo schermo che ti viene incontro, offrendoti quello che hai preselezionato in base ai tuoi interessi, non sei più tu che devi affacciarti sullo schermo e andare alla ricerca. Ovviamente le app usano sempre Internet come mezzo di trasporto, ma non ti danno quella libertà di scelta che avevi con il browser. Sono tante reti di proprietà di qualcuno, spesso con pedaggio di ingresso».
Svanisce il mio senso di liberazione. Avevo festeggiato troppo presto. Dunque in cambio della comodità stiamo rinunciando alla nostra libertà?
«È inevitabile – mi risponde il direttore di ‘Wired’ –. Lo dico senza nessun compiacimento. Io stesso sono una creatura del web, la mia storia qui a San Francisco è legata a questo strumento aperto. Ma è il consumatore a decidere, e il consumatore sta dicendo che vuole un servizio veloce, facile, da attivare con la punta dei polpastrelli. Presto il numero di utenti che avranno accesso a Internet dai loro telefonini avrà superato il numero di chi usa il computer. Il verdetto è chiaro. Per quanto possiamo amare la libertà di scelta, vogliamo avere la vita facile, vogliamo dei servizi efficienti e affidabili a portata di mano. Naturalmente questo non significa che il browser scomparirà. Così come le e-mail non hanno fatto scomparire le cartoline postali...»
Eccoci quindi a un’altra delle periodiche rivoluzioni generate da quest’angolo di California. Sono passati appena pochi anni da quando Google spodestò sua maestà Microsoft, oggi è la coppia Page-Brin a fare la figura dei Matusalemme di fronte alla sfida che gli viene lanciata dal ragazzino terribile Mark Zuckerberg, ovvero Mister Facebook. E in parte anche da un signore un po’ più anziano, ma capace di molteplici reincarnazioni come gli avatar della religione induista: un certo Steve Jobs di Apple.
Il passaggio dal browser alle app comporta delle trasformazioni profonde nel business online, nel modello economico, e nei rapporti di forza tra i giganti del settore. Si accelera la concentrazione: nel 2001 i primi dieci siti attiravano il 31% degli utenti, oggi ne catturano il 75%. Il modello Facebook, che ti pre-seleziona l’esperienza di navigazione in base ai tuoi interessi, minaccia per questa via la supremazia di Google.
«È il ciclo del capitalismo – dice Anderson –, è la storia delle rivoluzioni industriali che si ripete. Nasce una nuova tecnologia, si diffonde, fioriscono cento fiori, poi qualcuno trova il modo di impadronirsene, di recintare il giardino. Internet oggi si sta avviando ad essere una serie di giardini recintati. Il web aperto resterà ma come un’eccezione, sempre meno usata. Ancora una volta: è l’utente a imboccare questa direzione. Internet compie 18 anni dalla nascita e il sapore della novità ormai si è spento. La nostra sete di scoperta si attenua, per quanto intellettualmente noi della West Coast apprezziamo l’apertura e la libertà, alla fine vogliamo anche avere la vita facile. Cioè le scelte precotte, le app che attiviamo sfiorando con le dita lo schermo del telefonino o dell’iPad. O la nostra pagina su Facebook, che crediamo di avere disegnato a nostra immagine e somiglianza, su misura per i nostri gusti e i nostri amici».
Ho un’obiezione da giornalista e scrittore. Le app sul telefonino sono facili da usare, ma non finiremo per consumare informazione sempre più spezzettata, in formati ridotti che devono entrare nello schermo di un cellulare?
«La frammentazione – mi risponde – era un rischio maggiore nell’èra precedente, quella del browser. Usando un motore di ricerca come Google finivamo per scorrere tanti siti a volo d’uccello, raccoglievamo qui e là tanti bocconcini di contenuto gratuito, in modo atomizzato. Quando uso l’iPad, al contrario, io mi soffermo a lungo nel contenuto di un giornale. Le app ricostruiscono un contesto, il filo di un discorso. Mentre sul web sorvolavamo velocemente su tutto, ora ci soffermiamo più a lungo nell’assorbire i nostri contenuti preferiti sull’iPhone. Siamo in una transizione dall’èra del multi-tasking, in cui facevamo troppe cose alla volta (telefonavamo guardando lo schermo del computer) ad un mono-tasking. La nuova generazione di tavolette, i lettori digitali, ci spingono alla concentrazione. O per dirla con una battuta: passiamo meno tempo a cercare, e più tempo a trovare».
La nuova èra ha conseguenze profonde anche per chi produce contenuti: informazione, cultura, giornali, libri. Abbiamo conosciuto le regole dell’impero di Google, che pretendeva la gratuità dei contenuti e poi si arricchiva vendendo spazi pubblicitari un po’ dappertutto. Ora il modello nuovo è quello di Apple, dove i contenuti si pagano. E si scopre che i consumatori preferiscono pagare 99 centesimi per scaricare una canzone da iTunes, anche se perdendo un po’ di tempo e di fatica potrebbero trovarla altrove gratis. Sì, la «morte del web» libero e caotico significa un cambiamento di paradigma per il mondo dei media. Prima il contenuto online era gratuito e attirava ricavi pubblicitari grazie alla grande affluenza di visitatori. Ora siamo in piena transizione verso il freemium che è la combinazione di gratuito e «premium»: offriamo degli assaggi gratuiti, per attirare il consumatore verso un contenuto molto più interessante e gratificante, a pagamento. È il modello iPad, una piattaforma ricca, di alta qualità, dove il contenuto gratuito è limitato. Nel momento in cui l’accesso a Internet si è trasferito dalla tua scrivania alla tua tasca, la natura del mezzo è cambiata. Come dice il mio guru Anderson: «Il caos delirante è stata la fase adolescenziale del web».
The Social Network
Era dai tempi di Citizen Kane, il magnate della stampa personificato da Orson Welles in Quarto potere, che un personaggio prepotente, inquietante e forse malefico non affascinava a tal punto le folle. Le sale cinematografiche si riempiono per vedere il «sosia» di Mark Zuckerberg che recita la parte del fondatore di Facebook, magistrale ritratto di un genio che sprizza antipatia da tutti i pori. Forse solo un essere così asociale, diffidente, egoista, fondamentalmente misantropo, poteva inventare la più grande rete di relazioni sociali dell’èra digitale. The Social Network, appunto. Un’invenzione densa di rischi. Che vengono descritti altrettanto bene da un altro film dedicato al fenomeno Facebook, anch’esso premiato dal successo di pubblico e di critica: il documentario Catfish. Questo è un reportage dal vivo su una particolare disavventura accaduta davvero a un utente di Facebook. Che ha intuito di essere stato ingannato da alcuni suoi «amici di Facebook», e ha preso la decisione audace di andare a smascherare gli impostori (che si riveleranno dei poveracci, del tutto innocui ma disperati: il finale è agrodolce). Il documentario Catfish l’ho visto a New York in una sala affollata di ventenni. Dalla trepidazione, perfino l’angoscia, con cui seguivano le peripezie del protagonista, ho sentito quanto s’identificassero con quella situazione pericolosa. Tant’è. Un pericolo? Sicuramente lo è, ma Facebook ha oltrepassato la soglia dei 500 milioni...