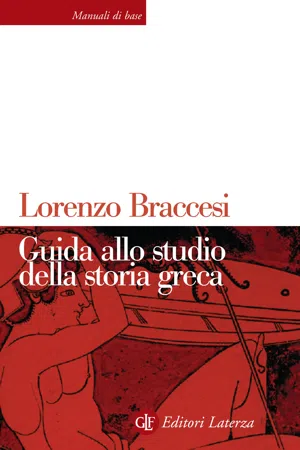
- 204 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Guida allo studio della storia greca
Informazioni su questo libro
Questo libro si affianca alle altre analoghe guide storiche la cui comune griglia di base (Concetto, periodizzazione, problemi – Le grandi questioni – Le Fonti – Come lavora lo storico) è stata pensata ed elaborata in funzione della nuova didattica universitaria. Oggi che il vecchio corso monografico è morto per sempre, l'ambizione di questa Guida allo studio della storia greca è quella di offrire –non senza originalità– allo studente spunti per una riflessione sulla disciplina e al docente argomenti di discussione e di ulteriore approfondimento.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Guida allo studio della storia greca di Lorenzo Braccesi,Flavio Raviola in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia antica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia antica1. Concetto, periodizzazione, problemi
1.1. Storia greca o storia dei Greci?
Esiste una storia greca, o non piuttosto una storia dei Greci? La risposta ci è offerta dal cosiddetto Vecchio Oligarca, autore della Costituzione degli Ateniesi (2, 8), che ci è tramandata sotto il nome di Senofonte:
Per lo più i Greci usano ciascuno la propria lingua, il proprio modo di vita e le proprie vesti; ma gli Ateniesi usano una miscela di costumanze proprie di tutti i Greci.
Su Atene torneremo [2.6]. Chi scrive fotografa la grecità nell’età del definitivo approdo del suo cammino evolutivo. In realtà, in piena età classica, i singoli Greci erano facilmente riconoscibili nella loro appartenenza a una determinata etnia per il tratto esteriore, per il dialetto usato, per il taglio dell’acconciatura, per la foggia delle vesti, per la varietà delle armature, per le preferenze alimentari. Inoltre, a livello pubblico, appartenendo a distinte comunità sovrane, si distinguevano per le divinità di riferimento, per i culti praticati, per i codici comportamentali, per i calendari in vigore, per i sistemi metrologici e monetali, per gli ordinamenti politici, giuridici e sociali. Tante le diversità all’interno del pianeta ellenico da indurci senz’altro a riflettere sulla legittimità non solo dell’espressione «storia greca», ma anche di definizioni troppo generalizzanti, e perciò coercitive, del tipo «diritto greco» o «religione greca».
Non esiste dunque una storia greca, bensì una storia dei Greci. Ma chi sono costoro? Il nome di «Greci», quale oggi noi l’usiamo, in un’accezione culturalmente globale, e in una dimensione etnicamente aggregante, è estraneo al mondo ellenico. Con questo termine i Romani designarono per estensione le genti elleniche, dal nome di Graikòi che pare portassero quelle genti con le quali essi vennero per primi a contatto sul suolo d’Italia. Ma i Greci, già da epoca antica, definivano se stessi Hèllenes, termine originariamente tessalo, che accomunava fra loro le genti settentrionali per la prima volta raccolte in una confederazione politica e religiosa attorno al più celebrato santuario del mondo ellenico, quello di Delfi. Dunque Hèllenes, Elleni, con una definizione globale che abbraccia insieme le tre stirpi in cui si riconoscevano i Greci in epoca storica: Ioni, Dori, Eoli. Prima di questa età, che tradizionalmente etichettiamo come «arcaica» (secoli VIII-VI), e prima dello iato – se non di rottura, certo di documentazione – che si frappone fra grecità del secondo e del primo millennio, i Greci sono noti essenzialmente come Achei. Lo testimoniano i documenti ittiti contemporanei e l’attesta la sopravvivenza del nome, in un’accezione preminente, nell’epica omerica.
Tali precisazioni di nomenclatura acquistano più pregnante significanza storica se si considera che i Greci mai ebbero unità politica e spesso neppure continuità territoriale di insediamento. Così Hèllenes è nome etnico che non designa appartenenti a una stessa compagine statale, ma popoli fra loro consanguinei che si riconoscono in una medesima dimensione sociale e culturale, pure al di là di legami interpolitici e di vincoli territoriali. Comunanza di lingua, di costumi e di religione qualificano gli Elleni, più ancora che per associazioni di componenti etniche, per opposizione al concetto, esasperato e quasi razzistico, di «straniero», cioè di bàrbaros. Così Hellàs è una definizione non traducibile con «Grecia», intesa come l’odierna realtà politico-geografica, ma semmai con «grecità». Definizione che oggi possiamo assomigliare a espressioni o concetti per noi più abituali, del tipo – per esemplificare – di «mondo arabo» o di «società ispano-americana». Cosa è la Megale Hellàs, la Magna Graecia, la Grecia di Italia? Non certo una Hellàs più grande in prospezione geografica o economica o culturale, ma parte costitutiva di una Hellàs, la quale in questo caso è divenuta grande, e quasi senza frontiere, dilatandosi a occidente. Dove approda il navigante greco lì è la Hellàs, che diventa grande, cioè megale, quanto più egli dilata la propria sfera di irradiazione. La definizione non presuppone un intento comparativo, ma solo un’affermazione di legittimo orgoglio.
Se però Hellàs equivale a «grecità», non possiamo che ribadire come non esista una storia greca, ma solo una storia dei Greci. La quale, di necessità, è somma, o sintesi, di tante storie locali. Greca è Atene (Athènai), in area metropolitana, come città elleniche, indipendenti e sovrane, sono Marsiglia (Massalìa) in Gallia, Cirene (Kyrene) in Africa, Istro (Histros) alla foce del Danubio. Socialmente, solo la somma di tante microstorie crea l’espressione di un’identità collettiva. Politicamente, solo la somma di tante, variate, microstorie consente la decodificazione unitaria per una pagina centrale della storia del Mediterraneo antico.
Abbiamo detto che tre sono le stirpi in cui si riconoscono gli Hèllenes in età storica, classificandosi come Ioni, Dori ed Eoli. Ma le originarie affinità di dialetto e di cultura presto si affievoliscono in processi di trasmigrazione che, di necessità, come in tutti gli esodi, vengono a interessare più gruppi etnici. Nascono così la Ionia, la Doride e l’Eolide sulle coste dell’Asia Minore e sulle prospicienti isole della Troade e del Dodecanneso. I Greci di Asia, e in particolare gli Ioni, sono i primi a doversi «autodefinire» al contatto delle più evolute civiltà anelleniche dell’Asia: espressioni dei regni di Frigia e di Lidia o dei distretti di Licia e di Caria, tutti, col tempo, fagocitati nel grande impero persiano, soprannazionale e plurietnico. Nel loro processo di «autodefinizione» gli Ioni crearono un’associazione federativa – un Panionio – con medesime festività e tradizioni culturali, e con la medesima aspirazione a riconoscersi in una comune madrepatria adottiva. Che, in opposizione alla dorica Sparta, e non senza violente strumentalizzazioni, sarà Atene. Ma, in effetti, gli Ioni di Asia nascono da un crogiolo di razze, ed è proprio per questo motivo che sono spinti a crearsi un’identità comune. Lo attesta, senza disincanti, Erodoto (1, 146, 1-2), che è un testimone privilegiato in quanto nato sì nella Doride di Asia, ma educatosi alla scuola di Atene:
Sarebbe molto stolto dire che questi Ioni siano più Ioni degli altri o che abbiano origini più nobili: [proprio] essi, di cui sono parte non piccola gli Abanti dell’Eubea, i quali non hanno nulla in comune con gli Ioni, neppure il nome. Vi si sono quindi mescolati Mini di Orcomeno, Cadmei, Driopi, Focesi distaccatisi dai propri consanguinei, Molossi, Arcadi, Pelasgi e Dori di Epidauro. Quelli venuti dal pritaneo di Atene, e che si reputavano i più nobili fra gli Ioni, non avevano condotto donne al seguito, ma si unirono con donne di Caria di cui avevano ucciso i genitori.
Di fatto l’identità di Ioni e di Dori sopravvive più come grande stereotipo di impronta etico-culturale, anziché come genuina coscienza etnica. Sopravvive, cioè, in dimensione strumentale, con un processo rigenerativo che è riciclato di continuo dalla propaganda di Atene e di Sparta: con formule, care ai filosofi, ma prive di giustificazione nella prassi quotidiana, quali «vivere da Ioni» (e quindi con il gusto per la vita, per la cultura, per la musica, per il dibattito e per un ordinamento democratico) o «vivere da Dori» (e quindi con il culto per l’austerità, per la disciplina, per l’obbedienza, per il valore e per un ordinamento oligarchico). Ciò avviene in un’età che etichettiamo come «classica» (secoli V-IV), nella quale, appunto, quelle di «Ioni» e di «Dori» sono mere etichette di comodo, utili a favorire il gioco delle alleanze negli scontri fra superpotenze; ma nulla più. Come prova la graduale eclisse della definizione etnica di «Eoli», determinata dalla sua minore capacità aggregante in politica estera perché estranea a un «bipolarismo» che ormai solo contrappone le due grandi superpotenze, cioè la ionica Atene e la dorica Sparta.
Abbiamo indugiato su Ioni, Dori ed Eoli, ma non dobbiamo pensare che gli Hèllenes che si riconoscono in queste tre stirpi si siano limitati a un arcaico – quasi ancestrale – espansionismo sulle coste dell’Asia Minore e sulle limitrofe isole dell’Egeo, ché il raggio della loro espansione, a oriente e a occidente, si dilata ben oltre. L’area geografica degli insediamenti greci, che ha come centro propulsore l’area metropolitana – cioè la penisola dell’Ellade, e quindi l’Egeo con entrambe le sue coste –, disegna infatti una sorta di ellisse ideale intorno all’intero bacino del Mediterraneo con dilatazione al Mar Nero. Motivo per il quale, parlando dei Greci, dobbiamo constatare come essi, il più delle volte, non si insedino in stanziamenti che abbiano fra loro continuità territoriale o presentino identici codici di relazione con le limitrofe popolazioni indigene: dove queste furono primitive, i Greci, infatti, imposero loro una dominazione economica, e talora anche politica, mentre dove queste furono culturalmente emergenti, nonché organizzate in robusta compagine statale, essi, pur non abdicando alle forme dell’autogoverno, dovettero accettarne la sovranità. Elemento comune agli insediamenti ellenici, dovunque disseminati, è invece la contiguità al mare. L’ellisse ideale disegnata intorno al Mediterraneo e al Mar Nero ne interessa solo le coste, con breve raggio di estensione nell’entroterra: quasi un dominio di vie di acqua con infiniti punti di approdo più che un dominio territoriale, compatto e proiettato alla conquista di regioni continentali.
Il mare, per i Greci, è sempre l’arteria principale di espansionismo [2.1]. Essi si insediano sulle sue coste non diversamente da come altri popoli del Vicino o Medio oriente sviluppano la propria civiltà attorno a un fiume: il Nilo, il Tigri, l’Eufrate, l’Indo, il Gange. Ulisse, il greco Odisseo, è il modello di riferimento, avendoli preceduti alla scoperta di sempre nuove rotte marittime! Come per l’eroe omerico, la grande e quotidiana avventura transmarina ne tempra l’ingegnosità, assicurando loro – giunti a destinazione – i mezzi di sussistenza. Il dato è importante. Infatti, il suolo dell’area metropolitana, per gran parte arido e impervio, consente limitate risorse agricole, inferiori alla richiesta legata al tasso di incremento della popolazione. Donde, per le frange sociali più povere, la necessità stringente dell’emigrazione, con conseguente trasformazione, nelle patrie di origine, di strutture legate alla terra in strutture aperte al commercio e all’espansionismo transmarino. Fenomeni centrali per la storia della grecità: destinati a originare la grande colonizzazione di età arcaica e quindi l’instaurazione di tirannidi rivoluzionarie. Le quali spezzeranno il potere di consorterie aristocratiche legate alla terra, preludendo, in nuova dinamica sociale, a una più matura coscienza della città-stato e, in non pochi casi, al decollo del suo regime democratico.
Quello dell’emigrazione è peraltro, e comunque lo si valuti, un fenomeno già presente in età micenea, al tempo dei reami achei. Infatti, anche la grecità del secondo millennio sperimenta un espansionismo transmarino che anticipa – e, sorprendentemente, sempre nelle medesime aree – la più nota colonizzazione o frequentazione commerciale di epoca storica. Fu anche allora l’insufficienza di terra a costituire la molla per un’irradiazione di respiro mediterraneo? Non lo possiamo escludere. Come non possiamo escludere che proprio tale irradiazione abbia determinato uno scontro violento con le grandi potenze allora detentrici del dominio del mare o del controllo degli stretti: Creta e Troia.
L’avventura greca è comunque figlia della fame. Lo si è sottolineato più volte, e giova ancora ripeterlo. Il suo primo interprete è Ulisse: innata allo spirito ellenico è, come per l’eroe, l’arte di sopperire con la tecnica alla povertà dei doni della natura. L’emigrazione al di là del mare e la capacità di insediarsi in terre lontane, ricreandovi proiezioni della patria di origine, sono peraltro, per i Greci, attitudini favorite sì dalla padronanza di un mare che per loro è sempre dietro l’angolo, ma anche attitudini facilitate dallo stesso assetto geografico e climatico della penisola ellenica. Da un lato, infatti, l’asperità di un clima, per nulla moderato, con enorme escursione termica fra estate e inverno, li allena ad adattarsi agli ambienti più diversi: ai calori estivi del deserto libico come ai rigori invernali del delta danubiano; dall’altro, l’estrema varietà delle linee di costa e dei rilievi montuosi, che si frangono in mare, consente loro di riscoprire anche in terre lontane paesaggi conosciuti da sempre. Non a caso, in una regione periferica come la sponda occidentale dell’Adriatico, l’unica colonia di tutto rispetto che essi fondano è ad Ancona, laddove il promontorio del Conero spezza la monotonia di un litorale piatto e sabbioso, rigenerando così un paesaggio «alla greca».
Abbiamo insistito sull’avventura dei Greci al di là delle frontiere domestiche per mostrare come frammentato sia il loro pianeta insediativo. Se poi a ciò assommiamo la constatazione che in area metropolitana ogni «campanile» rappresenta un’entità indipendente e sovrana, ci rendiamo allora conto di quanto sia arduo indagare in forma totalizzante la storia della grecità. A livello politico, infatti, non c’è un elemento accentratore e comune intorno al quale coordinare l’indagine; almeno se rifiutiamo surclassati schematismi di marca idealistica che teorizzano la «storia» come pàideusis – cioè come perenne palestra educativa – e quindi assegnano alla storia della grecità, colta nelle sue emergenze, il ruolo di historìa di pàideusis. A livello socio-economico, d’altro canto, troppi sono gli elementi centrifughi che, per loro individuali peculiarità, precludono un discorso globale senza trascinarci in nuovi schematismi di matrice antropologica o in troppo rigide interpretazioni di stampo marxiano. Se una costante comune possiamo rintracciare nella storia dei Greci, a partire dalle origini fino ad arrivare all’età che etichettiamo come «ellenistica» (secoli III-I), questa è la concezione localistica della comunità sovrana, la quale, il più delle volte, si esplica nella creazione della città-stato protesa a un’armonica ripartizione di poteri, pure a prescindere, beninteso, dalle differenti forme costituzionali che li possono ispirare. Tale la polis [1.4]: essenza e limite della storia dei Greci nella concezione idealista, espressione di ideologia della classe dominante nell’interpretazione marxiana.
La sua tenace...
Indice dei contenuti
- Premessa
- 1. Concetto, periodizzazione, problemi
- 2. Le grandi questioni
- 3. Le fonti
- 4. Lo storico al lavoro
- Cronologia essenziale
- Cartine